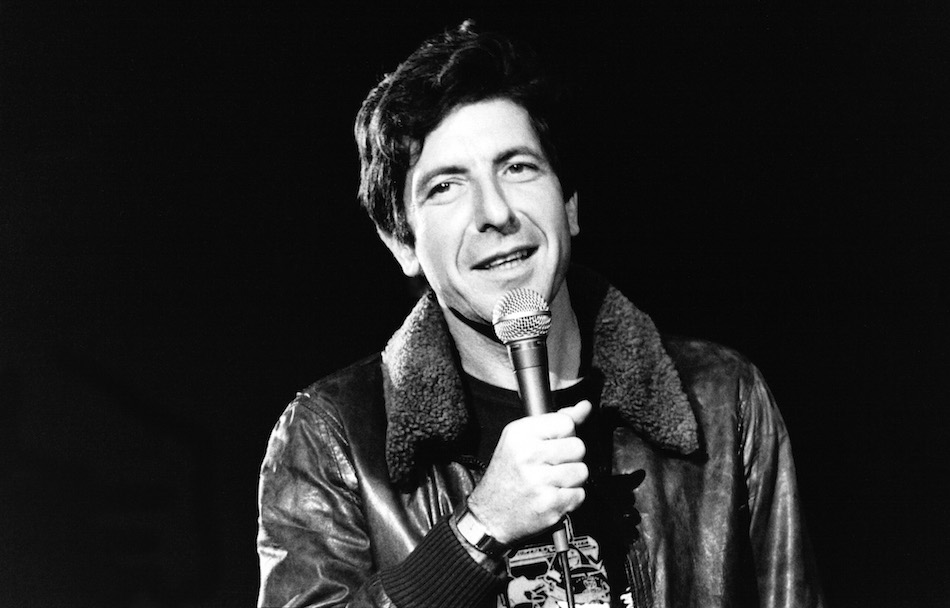Leonard Cohen è stato il poeta della distruzione. Lo è stato fin dalla prima canzone che ha attirato l’attenzione su di lui, Suzanne: “E Gesù era un marinaio quando camminò sull’acqua / e restò per molto tempo a guardare giù dalla sua torre solitaria… / E ancor prima che il cielo si aprisse, lui era distrutto / abbandonato, quasi umano, sprofondò come una pietra in fondo al vostro giudizio”. La distruzione è sempre stata lì. Si è dimostrata fondamentale per lui, in musica, poesia e letteratura (nessun altro ha saputo maneggiare le tre discipline insieme, come lui), e ha segnato Hallelujah, la sua più famosa visione della trascendenza: “Non è un pianto che ascolti di notte / non è qualcuno che ha visto la luce / è un Alleluia freddo e distrutto”. Ha seguito Cohen fino in un monastero Zen, dove anni di contemplazione e preghiera hanno saputo essere strazianti quanto l’orrore che lo spinse a rifugiarsi lassù. È apparsa persino nelle ultime strofe dell’ultima canzone del suo ultimo disco, uscito alcune settimane prima della sua morte. “È finita, l’acqua e il vino / allora eravamo distrutti, ma adesso siamo al limite”.
Ma Cohen – che è morto il 7 novembre 2016, a 82 anni – non si è mai arreso all’oscurità. In una canzone del 1992, Anthem, canta: “C’è una crepa in tutte le cose / è il modo in cui la luce riesce a entrare”. «La depressione è stata lo sfondo generale della mia vita quotidiana», mi disse una volta. «Credo di poter dire che tutto quello che ho fatto è nato nonostante la depressione, non a causa sua. Non è stata il motore del mio lavoro… ma il mare in cui nuotavo». Il suo lavoro non è stato soltanto oscurità. Il suo umorismo pungente si faceva strada durante la conversazione nello stesso modo in cui una musica maliziosa accompagnava la sua voce da oltretomba. In Tower of Song canta: “Sono nato così, non ho avuto scelta / Sono nato con il dono di una voce d’oro”. Eppure, inizialmente, la combinazione tra la voce e i temi delle canzoni tenne alcuni a distanza. Sembra che il discografico Walter Yetnikoff, spiegando perché non aveva intenzione di pubblicare Various Positions del 1984 (l’album con Hallelujah) in America, abbia detto: «Leonard, sappiamo che sei grande, ma non sappiamo se c’è qualcosa di buono in te».
Altri invece lo sapevano. Per quasi 50 anni, gli artisti che hanno seguito Cohen – Patti Smith e Kurt Cobain tra gli altri – riconobbero in lui un’impudenza coraggiosa e una mente empatica (In Pennyroyal Tea, Cobain canta: “Dammi un aldilà alla Leonard Cohen / così che io possa sospirare eternamente”). «Ci sono poche persone che occupano il terreno dove Leonard Cohen cammina», ha detto Bono: «Lui è il nostro Shelley, il nostro Byron». Ancora di più furono quelli che cantarono la sua musica – in particolare Hallelujah, la canzone che la Columbia non avrebbe voluto realizzare. Cohen impiegò cinque anni a scriverla, e a ridurre dozzine di strofe a quattro. La canzone avrebbe languito nell’oscurità, se John Cale non l’avesse registrata per un tributo a Cohen nel 1991. Quella registrazione trovò la sua strada verso Jeff Buckley, che reinterpretò la canzone nella versione incandescente che sarebbe stata usata tantissime volte per film, programmi tv, tributi all’11 settembre. Esistono più di 300 versioni, tra cui una famosa di Rufus Wainwright (padre di una nipote di Cohen) – così tante che pure Cohen si lamentò della sua ubiquità. «Penso sia una buona canzone», disse nel 2009, «ma troppe persone l’hanno cantata».
Hallelujah, una liturgia di giubilo che considera con sincerità gli inganni di Dio, è emersa come il punto di massima rottura nella carriera di Leonard Cohen. «Volevo stare con quelli che vedono il regno di Dio per quello che è, sacro e distrutto, e ancora trovano il coraggio e il cuore per lodarlo», ha scritto una volta. «Non ottieni sempre quello che vuoi. Non sempre sei pronto alla sfida. Ma allora ero pronto». La sfida, però, sarebbe diventata ancora più difficile prima che la luce potesse entrare. Leonard Cohen era di diversi anni più vecchio della schiera di artisti folk e rock nei quali sarebbe stato incluso. Era nato il 21 settembre 1934 a Westmount, Quebec, una città di lingua inglese sull’isola di Montreal, in una famiglia ebrea di classe borghese. Sua madre, Masha, era la figlia di uno studioso del Talmud. Era la famiglia di suo padre Nathan, però, a essere stata importante per la comunità ebrea di Montreal. Il nonno di Leonard aveva fondato delle istituzioni che avevano aiutato gli ebrei russi. Nathan, invece, non era una figura religiosa. Aveva servito nell’esercito canadese durante la Prima Guerra Mondiale e, quando la salute aveva iniziato a declinare, si era buttato nel business dell’abbigliamento di lusso per uomo (“Leonard –come scrive in I’m Your Man la biografa Sylvie Simmons – è cresciuto in una casa piena di completi”, nda). Sia il temperamento di Masha che la morte di Nathan – quando Leonard aveva 9 anni – ebbero un grande effetto su Cohen. «Mia mamma era una rifugiata, e aveva assistito alla distruzione di tutto il suo mondo, in Russia», mi disse nel 2001. «La sua malinconia era giustificata. Era un personaggio cechoviano, sia comica che consapevole. Ma non l’avrei descritta come morbosamente malinconica, com’ero invece io… La morte di mio padre fu significativa, e insieme alla morte del mio cane fu l’evento più importante della mia infanzia e della mia adolescenza…».
La sensibilità cattolica di Montreal avrebbe caratterizzato il lavoro di Cohen con la stessa forza delle sue origini ebree. «La figura di Gesù mi ha sempre toccato, ed è ancora così», mi disse nel 2001. «Ama i tuoi nemici. Beati siano gli umili, perché erediteranno la Terra. Questi punti di vista non sono estranei all’educazione ebrea che ho avuto, ma mi sembrano, piuttosto, una rifinitura radicale di certi principi». Molto prima che le misteriose congiunzioni tra lo spirito e la carne riuscissero a penetrare nelle sue canzoni, Cohen era già riuscito a imporsi come potente poeta e autore poco ortodosso. Sua madre lo incoraggiò fin dall’inizio sulla strada della scrittura. Le sue prime influenze includevano i poeti metafisici – Andrew Marvell, John Donne, W.B. Yeats – e W.H. Auden, che mescola temi religiosi e culturali.
Ma nessuno lo influenzò come il poeta surrealista spagnolo Federico García Lorca, che collezionava le canzoni folk del suo Paese e le trasformava in poesie, prima di essere giustiziato dalle forze nazionaliste nel 1936. Cohen ascoltò le canzoni folk socialiste anche durante un campo estivo. «I testi di quelle canzoni», disse, «mi toccarono: “A te, cara compagna, facciamo questo voto solenne / La lotta andrà avanti… / Come pegno ti diamo i nostri corpi / La lotta andrà avanti”. Una posizione appassionata ed eroica». Nello stesso periodo, Cohen mise in piedi una country band chiamata Buckskin Boys. Quando aveva 17 anni, entrò alla McGill University come studente di Inglese. Le aspirazioni per la mitologia – insieme a un forte appetito per le donne – arrivarono presto. Guardando indietro ai suoi primi scritti, la mancanza di una centralità della città di Montreal nel mondo dell’arte, della letteratura e delle idee, forse, aveva finito per essere una manna per lui e i suoi compatrioti canadesi. «Era una situazione completamente indeterminata», disse. «Il clima dei nostri incontri nei caffé e nelle case private di Montreal ci convinceva che si trattava senz’altro della cosa più importante che stava succedendo in Canada, che eravamo i legislatori dell’umanità e avevamo in qualche modo una funzione salvifica… Ma al campus non potevi mica alzarti, dire che eri un poeta e aspettarti che qualcuno ti chiesse un appuntamento. Non c’era alcun prestigio nella cosa».

Marrianne Ishtel con Leonard Cohen a Idra, Grecia ottobre 1960.
Foto di James Burke
Time Inc Owned
Merlin- 1202404
Le cose cominciarono a cambiare nel 1956, quando Cohen pubblicò il suo primo libro, Let Us Compare Mythologies. «Erano le poesie che avevo scritto tra i 15 e i 20 anni», mi disse Cohen nel 1988. «Non ho mai più fatto niente di così bello». Il libro successivo, The Spice-Box of Earth, aumentò la sua fama e gli fece meritare le lodi della critica come un nuovo, importante poeta; il suo romanzo d’esordio, The Favourite Game, seguì nel 1963. Cohen si era trasferito a Londra nel 1959, poi, l’anno dopo, sull’isola greca di Idra, dove pagò 1500 dollari per una casa a tre piani. A Idra visse con la prima delle sue leggendarie storie d’amore, Marianne Ihlen, di Oslo. Anni dopo, Ihlen disse a un intervistatore che Cohen aveva sempre mostrato «un’enorme compassione per me e per mio figlio». La relazione con Ihlen diede il via a una specie di pattern per Cohen: avrebbe teso a un ideale di significato e passione romantici, che nelle ristrettezze economiche si sarebbe tuttavia rivelato difficoltoso – anche in un luogo fuori mano come Idra.
L’atmosfera si fece burrascosa. David Remnick del New Yorker riportò che Ihlen si inferociva quando era ubriaca, e che né lei né Cohen erano fedeli. «Tutte le donne gli sbavavano dietro», ricordò Ihlen, «potrei perfino spingermi a dire che sono stata sul punto di ammazzarmi, per questo». Mentre viveva a Idra, Cohen lavorò a un secondo romanzo, Beautiful Losers, che per poco non gli costò la salute mentale. Nel 2001 mi disse: «Credo di essere stato un po’ demente e delirante, durante la sua creazione. Credevo fosse una cosa viva. La scrivevo all’aperto, nel sole della Grecia, su un tavolino portatile dietro alla mia casa. Sapevo che qualcosa si stava schiudendo, e c’era una gioiosa attività dietro a questo, che liberava tremendamente la scrittura – ma, come dicevo, era una cosa leggermente folle. Fumavo erba e prendevo acidi, ogni tanto».
«Un giorno, a un certo punto, andai in camera e, in piedi su una sedia, cominciai a scrivere sul muro con la vernice d’oro: “Cambio, sono lo stesso, cambio, sono lo stesso, cambio, sono lo stesso, cambio, sono lo stesso, cambio, sono lo stesso…”. Questa è l’unica che cosa che ho scritto sotto acido, e compare nel libro». Alla fine collassò, e dovettero ricoverarlo. Marianne si occupò di lui. «Mi piacerebbe dire di essere diventato una specie di santo», disse Cohen. Beautiful Losers fu pubblicato nel 1966. Un’opera genuina, ardita, innovativa, erotica, che parla di un uomo in cerca di identità, memoria, scopo e trascendenza in mezzo a un vorticoso intreccio di tradimenti romantici, religiosi e storici – con un finale inaspettato e sconcertante, che è in grado di far saltare le teste. Proprio come Howl di Allen Ginsberg nel 1956 aprì nuovi territori nella poesia americana, Beautiful Losers aprì nuove prospettive sulla forma e sul tempo nel romanzo moderno. Cohen aveva l’immaginazione e l’abilità per ottenere il tipo di reputazione letteraria conferito ad autori come Thomas Pynchon e Henry Miller. Ma lui aveva in mente qualcosa di completamente diverso.
Quando nel 1966 tornò a Montreal, scoprì che Beautiful Losers stava ricevendo molte attenzioni. Alcune recensioni lo paragonavano a James Joyce per il suo uso del flusso di coscienza, anche se Cohen lo portò addirittura oltre, nella fantasmagoria. Un giornale lo ritenne “masturbazione verbale”. Il Toronto Daily Star lo definì “il libro più rivoltante mai scritto in Canada”, ma anche “il libro canadese dell’anno”. Ma fin da subito fu chiaro che il romanzo che lo aveva quasi distrutto aveva sì spinto in alto il suo destino, ma non le sue fortune. Nonostante il successo, infatti, Cohen non era in grado di pagare l’affitto. «Ho pubblicato due romanzi e due o tre libri di poesia», mi disse nel 2001. «Non mi aspettavo di vivere di poesia, ma credevo che avrei potuto guadagnare scrivendo romanzi. Invece c’erano forse soltanto 3.000 copie di Beautiful Losers in tutto il mondo». Ma dentro Cohen cominciò a farsi strada una nuova possibilità. «Vivendo in Grecia per la maggior parte del tempo, ero completamente inconsapevole del grande rinascimento in musica che stava prendendo piede a metà degli anni ’60. Suonavo ancora la chitarra, e così pensai: “Ok, ho sempre voluto essere uno scrittore. Ma mi piacerebbe andare a Nashville e fare dischi country… Sì, questo mi tirerà su”. Avevo già qualche abbozzo di canzone».
Nessuno parlava della musica, erano tutti fissati coi testi e con la mia cupezza
Durante il viaggio, Cohen fece tappa a New York e scoprì che la sua opera l’aveva preceduto. Incontrò cantanti come Bob Dylan e Phil Ochs, e al Max’s Kansas City conobbe Lou Reed, che l’avrebbe più avanti introdotto nella Hall of Fame del Rock and Roll. «I ragazzi conoscevano già quello che avevo scritto», mi disse. «Figure romantiche, quei menestrelli. Erano come me, erano quello che volevo essere: andare alla deriva per il mondo, parlando dal cuore e perseguendo un’esistenza mitologica. Mi sentivo veramente vicino a loro». Nel 1966, Judy Collins registrò Suzanne: la canzone godette subito di grande fama. Collins registrò anche Dress Rehearsal Rag, un precoce esempio di quello che alcuni considerano il lato morboso di Cohen. «Parla del buio», Collins disse più avanti a Sylvie Simmons, «una canzone sul suicidio. Ho tentato il suicidio a 14 anni, prima di scoprire la musica folk, quindi me ne innamorai». Nel 1967 Collins convinse Cohen a iniziare con i live. Lui era riluttante, ma la folla ebbe la meglio, e quell’anno suonò molte date di successo nei festival.
Più o meno nello stesso periodo John Hammond, produttore della Columbia Records (che ha scritturato e/o prodotto artisti come Count Basie, Billie Holiday, Bob Dylan e Aretha Franklin, tra gli altri), visitò la stanza di Cohen al Chelsea Hotel per ascoltare il suo materiale. Lo scritturò per la Columbia, che nel 1967 pubblicò il suo debutto, Songs of Leonard Cohen. Il disco confermò la sua reputazione come portavoce di chi si sentiva perduto, in cerca di una qualche grazia o salvezza, fosse questa il sesso o la religione. Il leggendario archivista Harry Everett Smith, che compilò la fondamentale Antologia della musica folk americana, incontrandolo al Chelsea Hotel un giorno gli disse: «Leonard, so che un sacco di persone si stanno complimentando con te per i testi, ma voglio che tu sappia che anche le melodie sono molto buone». Nel 2001, parlandone, Cohen sorrise al ricordo. «È vero», disse, «nessuno parlava della musica, erano tutti fissati coi testi e con la mia cupezza».
Ma la sua cupezza non era certo una posa. La situazione di Cohen a New York diventava sempre più disperata. Marianne e suo figlio lo avevano seguito in città, ma la loro relazione stava giungendo al termine. «Le persone parlano spesso di solitudine», mi disse Cohen, «ma io passavo intere giornate senza parlare con anima viva. Settimane in cui il solo contatto che avevo era con la donna da cui compravo le sigarette. Un’intera giornata poteva essere riscattata da un suo sorriso. Fu un periodo difficile, e non smise di essere difficile per lungo tempo… Capisco che un sacco di persone dovevano sentirsi come me, perché avevo queste metafore bibliche che mi giravano in testa. Cominciai a sviluppare l’idea che qualche catastrofe stesse avvenendo. Non riuscivo a capire perché non riuscivo a entrare in contatto».Cohen e Marianne Ihlen si separarono. Nel 1969 iniziò la relazione con la 19enne Suzanne Elrod, che sarebbe durata quasi un decennio. Elrod sarebbe diventata sua moglie e madre di suo figlio Adam e di sua figlia Lorca, anche se Cohen si lamentò spesso di come lei avesse ogni volta forzato quei vincoli («Riusciva sempre ad averla vinta», disse una volta).
Cohen registrò i suoi album successivi a Nashville con il produttore Bob Johnston, che aveva lavorato anche con Johnny Cash, Marty Robbins, i Byrds, Simon & Garfunkel e Dylan. Le melodie e la voce di Cohen hanno in questi anni una gamma limitata, che calza con la sua immagine ombrosa. Ma con New Skin for the Old Ceremony, del 1974, prodotto da John Lissauer, l’oscurità di Cohen acquistò una sfumatura più soave e luminosa. Fu il suo album migliore fino a quel momento, e anche il più triste, e includeva anche il ritratto di un incontro con Janis Joplin: “Ti ricordo bene al Chelsea Hotel / parlavi così coraggiosa e così dolce / Facendomi un pompino nel letto sfatto / Mentre la limousine aspettava in strada… / Ti ricordo bene al Chelsea Hotel / Eri famosa, il tuo cuore era leggenda”.
Nel 1977, Cohen collaborò con il produttore Phil Spector per Death of a Ladies’ Man. È l’unico errore tra le opere di Cohen, anche se il disastro è da imputare più a Spector, la cui megalomania era già paranoide. «Voleva entrare in una specie di modalità wagneriana, quand’era in studio», mi raccontò Cohen, «ed era abbastanza matto, ai tempi. Ma devo dire che avevo una specie di fede nel suo metodo – rispettavo davvero tanto il suo lavoro. Speravo che a un certo stadio della produzione tutto si sarebbe coeso in qualcosa che avrei trovato più interessante. Beh, non successe». Spector era appassionato di pistole, e spesso chiudeva le persone dentro allo studio. A un certo punto, sparì con i master dell’album. «Ero bloccato con quello che avevamo», disse Cohen nel 2001. «Forse avrei dovuto porre il veto all’intero progetto… Era l’unica arma in mio possesso».

Leonard Cohen con i figli Adam e Lorca
Ho incontrato Leonard Cohen per la prima volta nel 1979, in un ristorante messicano a Hollywood chiamato “El Compadre”. Paul Nelson di Rolling Stone mi aveva chiamato chiedendomi di scrivere una preview del suo nuovo album. Io esitavo. Nessuna possibilità di prepararsi, e il lavoro di Cohen mi impauriva. «Vai», mi disse Nelson, «lo amerai. È un gentiluomo assoluto». Quando arrivai a El Compadre, una band messicana stava facendo una serenata. Cohen sedeva su un divano di pelle rossa, ai lati due donne eleganti dai capelli scuri. Era come la copertina di Death of a Ladies’ Man. Parlammo per un paio d’ore, e come Nelson mi aveva detto, Cohen si era rivelato come la persona più di buone maniere – soggetto di intervista o meno – che avessi mai incontrato. Ammise che non si aspettava che Recent Songs, il nuovo disco, avrebbe portato la tanto agognata svolta (il suo primo album Songs of Leonard Cohen rimase il suo bestseller fino al 1988). Non aveva un’etichetta americana al momento. «La mia musica è considerata eccentrica in America», disse. «Le compagnie non mi promuovono con lo stesso fervore che userebbero con qualcuno col potenziale di entrare nella Top 20».
La conversazione andò bene, e continuò con una o due telefonate transatlantiche, quando Cohen si trovava in Europa. Durante una discussione notturna, gli chiesi di parlare di The Guests, la canzone che apre Recent Songs. Mi ricordava Checov, o un racconto di James Joyce, I morti. Comincia con un’idea di comunità, ma più gli ospiti si raccolgono, più isolati appaiono l’uno dall’altro, e alla fine diventa una riflessione sulla morte che abbraccia l’umanità intera. Cohen – che beveva una bottiglia di qualcosa mentre parlavamo – mi illuminò: «La sensibilità della canzone deriva dalle poesie di Rumi e Attar, poeti persiani del XII e XIII secolo. Credo sia un testo religioso, sulla nostra estraneità sulla Terra, “Uno per uno gli ospiti arrivano / gli ospiti passano oltre / i molti col cuore d’oro / e i pochi col cuore a pezzi”». Da qui, Cohen cominciò un’esegesi riga per riga. Gli ospiti, suggerì, domandavano: “Dov’è Dio? Dov’è la verità? Dov’è la vita?”. Molti autori non avrebbero saputo gestire tali riferimenti: chi per troppa dedizione ai propri significati, chi per timore di rivelare incertezza su di essi. Cohen invece conosceva ogni millimetro di quello che le sue canzoni significavano – me ne spiegò altre quella notte, meticolosamente, e se alcune delle sue frasi o immagini sembravano ambigue, lui non lo era. Mentre continuavamo a parlare, sentii il tintinnio del collo della bottiglia sul bicchiere. Cohen ridacchiò. «Ubriaco», disse, «ancora ubriaco».