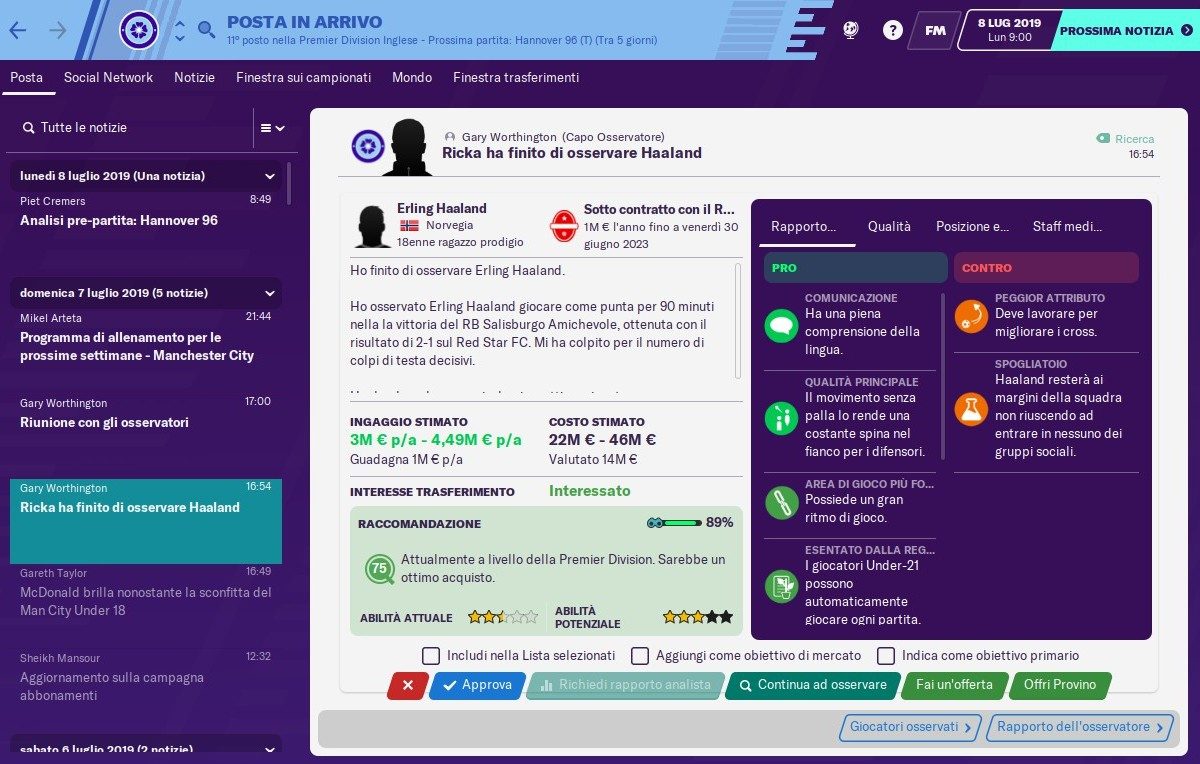Ieri ci siamo vergognati. Non per una sconfitta sportiva: l’1-7 di Brasile-Germania in casa dei verdeoro, la Francia che fu fatta fuori dal mondiale del ’94, le disfatte inglesi, le finali perse dall’Argentina contro il Cile, non sono diverse. E anche nella nostra storia c’è stato di peggio: il 1958 tanto evocato in queste ore ci vide fatti fuori da un’Irlanda del Nord imbarazzante. E poi abbiamo avuto Coree del Nord e del Sud (seppur aiutate nel secondo caso dal bizzarro Byron Moreno), un Costa Rica imbarazzante e persino l’onta di uscire fuori da campioni del mondo tetrastellati facendoci spezzare le reni da Paraguay, Nuova Zelanda e Slovacchia.
Ieri ci siamo vergognati per un altro motivo.
Ci siamo vergognati perché Ventura e Tavecchio siamo noi. Siamo quest’Italia mediocre e presuntuosa, questo paese convinto di una grandezza che non ha, figlio di talenti sprecati ed eccellenze che vengon su nonostante tutte le umiliazioni (in questo senso Lorenzo Insigne in panchina, unico vero talento degli azzurri, la dice lunga).
Per Gianpiero Ventura che è l’Alberto Sordi che Nanni Moretti ci ha sempre detto di meritare: fondamentalmente incompetente, borioso persino nelle scuse (“per il risultato, non per l’impegno” e forse non ha visto la partita d’andata, indolente e irritante), debole con i forti e forte con i deboli, capace di farsi imporre una formazione sbagliata dai senatori della squadra così come di non andare ai microfoni nell’immediato post-partita e assumersi tutte le responsabilità.
Per Tavecchio, che ci fa vergognare dal suo insediamento come presidente FIGC. Anzi, da prima: con le sue battute razziste e sessiste, con il suo navigare nel fango di alleanze grigie (quella con Lotito, a cui tutto è ormai permesso, su tutte), con la totale mancanza di competenza nel proprio lavoro ormai sancita da un risultato che è una macchia indelebile nella storia del calcio italiano. Tavecchio è quella classe dirigente arrivata ai vertici non per meriti ma per relazioni, un perfetto esemplare del nostro piccolo mondo antico tricolore: quanti Tavecchio ci sono nella politica, nell’economia, nei giornali, nella pubblica amministrazione, nella nostra vita?
Ma anche per i Bonucci che si tolgono la maschera, più attenti alle chiacchiere e ai gesti plateali (togliersi la maschera che proteggeva il naso fratturato), che alla maglia. Non come un Daniele De Rossi che preferisce non entrare, pur di vincere. Che non ha paura di rivoltarsi pubblicamente contro il capo anche se magari tutti lo insulteranno. Solo perché lo ritiene giusto.
È figlia, questa vergogna, dell’Italia razzista e campanilista, tutta concentrata sulle squadre del settentrione, che continua, forse casualmente, a ridicolizzare i giocatori che vengono da Firenze in giù, come se quella fosse meno Italia delle altre. Perché forse sono più forti, ma forse il loro peso politico conta qualcosa in scelte che dovrebbero essere solo sportive.
È l’Italia vecchia, che perde sempre. Eh sì, perché abbiamo il mito, schiavi come siamo della gerontocrazia, della “vecchia guardia”. Che non si chiama così a caso: nessuno vuole negare quanto ci abbia dato il gruppo del 2006 (di gratitudine c’è morto anche Bearzot), il blocco Juventus e lo stesso Daniele De Rossi. Ma se Pirlo si è ritirato, se Zambrotta e Gattuso allenano, e loro no, non sarà solo per pochi anni di distanza all’anagrafe. Sarà anche perché noi sui giovani non puntiamo mai. In nessun settore.
È l’Italia convinta, quella degli azzurri, di poter raggiungere sempre il massimo risultato con il minimo sforzo, ciò che noi italiani perseguiamo ossessivamente. Senza costruire un movimento forte, senza le università sportive e una cultura dell’agonismo sana, senza progetti a lungo termine (qui a Conte neanche gli stage concedevano), senza un’attenzione ai vivai, come si pretende di costruire qualcosa? Volevamo davvero passare il turno segnando un solo gol in 180 minuti a una squadra che sarebbe stata battuta anche dalla Spal? Perché non è che ne meritassimo di più, eh.
È l’Italia del gombloddo, paranoica a buon mercato, che preferisce prendersela con l’arbitro, i raccomandati, urlando “piove governo ladro” piuttosto che rimboccarsi le maniche e farcela contro tutto e tutti. Perché la Svezia delle botte dell’andata e del catenaccio del ritorno, non è altro che una squadra che ha fatto ciò che noi abbiamo insegnato per anni al calcio mondiale.
Sbaglio o i nostri miti fondativi sono la marcatura ruvidissima di Gentile su Maradona, la testata di Zidane a Materazzi, il contropiede e appunto il catenaccio?
È l’Italia che si sente patriottica solo nel momento del bisogno, solo quando la tragedia è a un passo: nello sport come, ahinoi, nelle cose più serie. Che non rispetta nulla e nessuno, che non si rispetta. Che vorrebbe tutto su un piatto d’argento senza aver faticato per ottenerlo.
Ventura, Tavecchio, siamo noi. Così come quei milionari in calzoncini e maglietta che si sono ricordati di essere italiani e attaccati a qualcosa per qualche decina di minuti e perché quello stadio di San Siro avrebbe mosso e commosso chiunque. Dovrebbero vergognarsi tutti per quell’inno italiano che sorge spontaneo dagli spalti al 78imo. Ed è da lì che dobbiamo ripartire. Perché se è vero che la Nazionale attuale è lo specchio di quanto in basso siamo caduti – per fortuna poi c’è Salvini con i suoi tweet che poi scava – è anche vero che quello stadio, ieri, innamorato nonostante tutto, altruista senza motivo, generoso oltre ogni razionalità, è quel popolo che dovremmo essere sempre. Che smette di chiedersi cosa faccia il paese per loro (niente, anzi peggio), ma che ha voglia di fare qualcosa per il paese.
È solo da lì che viene la speranza di migliorare. E non perché il Brasile dopo il Mineirazo è diventato imbattibile o perché la Francia di Zidane nasce dalle ceneri dell’umiliazione subita da Hristo Stoichkov o che la Spagna del tiki taka sia figlia dei continui fallimenti dal mondiale di casa in poi. Dopo ogni fragorosa caduta, c’è una rinascita, è banale: anche perché peggio è difficile fare. La speranza nasce da quei 70.000. Che non si sono abbandonati ai fischi, all’arena, alla rabbia, che sono stati più equilibrati di mille commentatori che hanno attaccato la Juventus perché non farebbe giocare Bernardeschi (ma siamo pazzi? La grande con più italiani? Forse senza i bianconeri neanche ai play-off saremo arrivati), che non si sono abbandonati al facile populismo che da noi ormai è pane quotidiano.
Ripartiamo da loro, dai De Rossi che hanno il coraggio di alzare la testa e di dire le cose come stanno, ma anche di chiedere scusa dopo e di metterci la faccia. Da Jorginho, che ieri ha onorato la maglia più di un italiano (alla faccia dei razzisti di turno). Magari cercando le Bebe Vio e gli Alex Zanardi anche nel calcio: sono tra i pochi ad averci reso orgogliosi di essere italiani, dimostrando che grinta, voglia di soffrire e di non prendere scorciatoie valgono più di tutto.
Ricominciamo allo smettere di avere l’ossessione di vincere senza meritare, ma di cominciare a meritare qualcosa. O di far di tutto perché sia così. Forse faremo meglio nel calcio, di sicuro faremo meglio fuori.