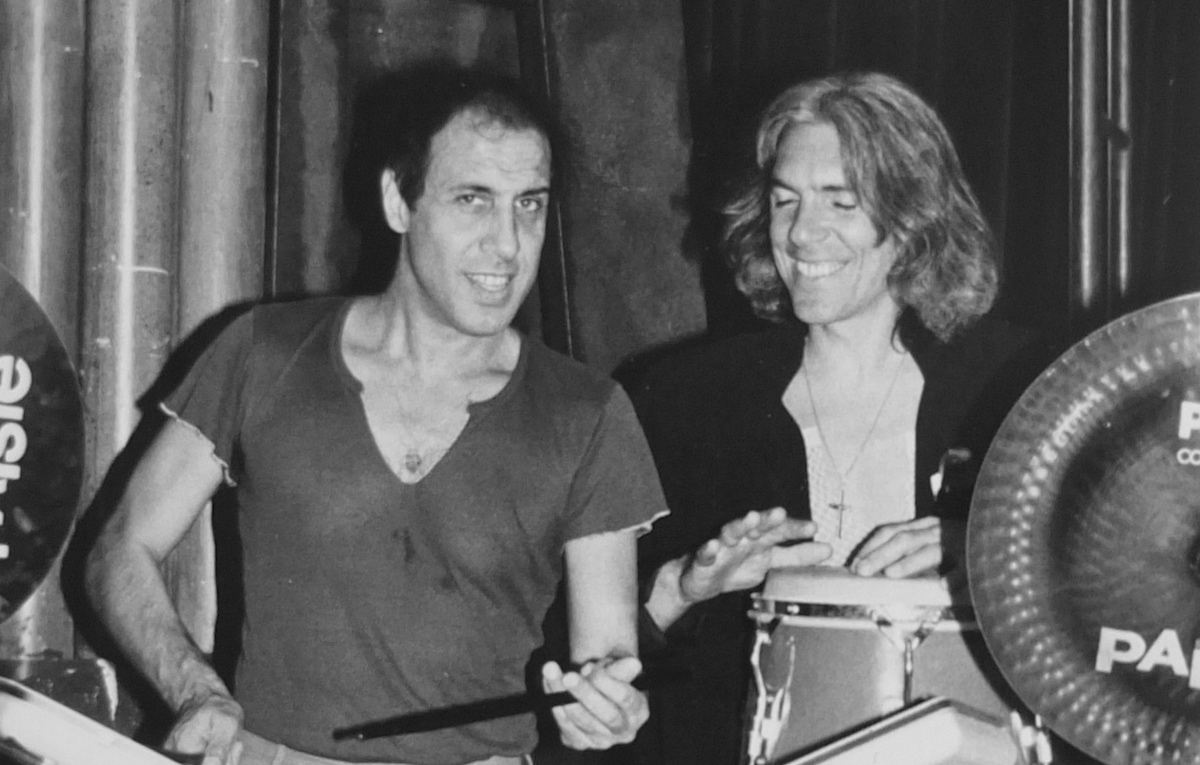Quando il 9 settembre del 1998 Lucio Battisti è morto colpito da un tumore fulminante che nel giro di quindici giorni l’ha progressivamente e letteralmente distrutto, io avevo 13 anni. La storia e il ricordo di quel giorno li ho raccontati e scritti molte volte perché credo che, fuori dalla singola esperienza, conservino al loro interno una certa quantità di universali: l’essere ragazzini del secondo novecento che stanno scoprendo la musica in Italia, trovarsi nella piena scoperta della nostra musica del passato e trovarsi al contempo di fronte al fatto che, effettivamente, con l’arrivo della morte, quel passato resterà ineluttabilmente tale, che non sarà cioè mai più neppure parzialmente presente, tangibile. E poi, magari, prendere persino coscienza della morte stessa. Quel 9 settembre io, per esempio, non avevo perso ancora nessun parente, nessun amico, non sapevo cosa significasse la morte di qualcuno di vicino, di qualcuno che ti aveva detto qualcosa e con cui avevi in qualche modo dialogato.
In quel 1998, però, ero già pazza di Lucio Battisti: lui, prima degli amici dell’età della ragione, prima di qualsiasi amore, prima di ogni formazione relazionale matura mi aveva parlato, mi aveva detto cose che non conoscevo, aveva anticipato l’età adulta a me che adulta ancora non ero così che, in qualche modo, anche a me era parso di parlare con lui, come se nelle infinite ore trascorse ad ascoltare le sue musicassette, i suoi dischi, io avessi superato per la prima volta l’unica relazione possibile della prima giovinezza: quella con i genitori, con i nonni, quella con la famiglia.
Fummo moltissimi ragazzini, lo scoprimmo anni dopo, a piangere insieme agli adulti – ragazzini a cui Battisti aveva parlato venti, trenta, quaranta anni prima – quella mattina, seduti insieme sui divani nei salotti delle nostre case italiane, seduti ai tavoli delle nostre cucine italiane, magari negli abitacoli delle nostre automobili andando chissà dove, apprendendo dal televisore o sentendo alla radio quella notizia e i suoi sviluppi e il magma dei suoi ipotizzati retroscena. Insieme a noi una quantità di italiani sparsi per il mondo si unì a un vicinissimo commiato emotivo, pur fisicamente distante da una camera ardente in cui solo cinque parenti strettissimi – escluso anche il padre di Battisti che non volle neppure vedere il figlio morto per la certezza dichiarata di morire a sua volta di fronte alla salma – erano stati ammessi.
Ci ritrovammo ad ascoltare e guardare gli esperti analizzare, i collaboratori e gli amici ricordare, i conduttori far soprattutto cantare ospiti e spettatori in trasmissioni dai titoli un poco retorici e didascalici come “Pensieri e parole” o “Il nostro caro Lucio”, nomi presi da altre citazioni o adattamenti di titoli delle sue canzoni più note.
In qualche modo, su una certa scala, quella morte, tenuta il più possibile segreta nei dettagli, la morte del più leggendario e popolare tra i cantautori italiani, lontano da anni dalle scene e dai riflettori, fu la prima grande perdita della canzone popolare italiana. Lo avrebbe seguito di poco, purtroppo, Fabrizio De André, con un cantautorato opposto e però alcune sottili ma fondamentali trame condivise.
Non avevamo internet, non avevamo i social network, non avevamo timeline da riempire, purtroppo, di canzoni fondamentali per tutte le nostre vite e in qualche modo, quella sua morte, pur collettivamente sofferta, e quindi quella sua vita artistica tanto privata quanto esondante e straordinaria che la tv stava celebrando, rimasero, viste con gli occhi di oggi, intime e private come lui e come sua moglie, Grazia Letizia Veronese, volevano e avevano sempre voluto.
Paradossalmente, però, questa segretezza, iniziava proprio in quel momento, quel 9 settembre del ’98, a scontrarsi più che mai con l’inevitabilità pervasiva del pop, l’assoluta necessità e le assolute capacità esplosive che la canzone popolare ha di infilarsi ovunque, di distruggere ogni forma di privato per rispondere naturalmente alla sua vocazione prima: essere di tutti, essere così pubblica da farsi pubblico, di aderire all’ascoltatore facendosi da esso conoscere e riconoscere, scoprire, interpretare, fino a trasformarsi in un prodotto che solo in ridotta parte è infine dell’autore – in questo caso degli autori – per diventare poi, soprattutto, prodotto del pubblico, sua immagine e sua immaginazione, suo sogno, sua emanazione, sua materia e suo futuro ricordo.
Quando un grande autore di canzoni muore, dunque, e lo fa il più segretamente possibile, la sua canzone, che già nei decenni era stata di donne e di uomini e di ragazzini che scoprirono suoni, che scoprirono parole e nuove, diverse, forme di combinazioni e intrecci delle proprie vite uscire sconvolgenti da juke box, radio, mangiadischi e stereo, quella canzone, dicevamo, esplode una seconda volta, anche se mai assente ritorna comunque più presente, più viva, più pervasiva e quindi ancora più pubblica, ancora più pubblico.
E così è stato per Battisti in questi ultimi venti anni, un Battisti ancora più amplificato – specialmente considerando la crescente distanza anagrafica dall’uscita dei suoi dischi – nelle orecchie e nei suoni non solo degli ascoltatori ma specialmente dei musicisti italiani che ne hanno fatto la principale ispirazione e il principale riferimento su larga scala. Non si contano i nomi di chi lo ha più o meno esplicitamente citato: Dente, Verdena, Iosonouncane, Colapesce, Coma Cose, Calcutta sono solo i primi che ritroviamo nel setaccio; senza parlare poi dell’enorme fascinazione su scala internazionale: dai dj set di Ricardo Villalobos alla scelta di Aziz Ansari di inserirlo nella colonna sonora dell’ultima stagione della sua serie Master of none.
Battisti, negli ultimi due decenni, è stato ovunque non solo per la sua grana più popolare ma anche e soprattutto per il suo tessuto più intimo di musicista nato tale, la sua vocazione costante alla ricerca, la sua voglia di scoprire sempre un nuovo da portare nella sua canzone, una nuova istanza mobile e internazionale da fondere con la canzone italiana più classica, melodica, cioè con il nostro più grezzo DNA.
In questo modo Battisti, e lo scopriamo ogni volta che, da italiani, cerchiamo di fare o ascoltare musica rivolta al nuovo, ci ha offerto non solo canzoni ma un modo intero, avanguardista per la canzone italiana, di concepire sé stessa, proprio grazie alla continua fusione con un imprevedibile diverso, apparentemente distante. Il Brasile, la California, i ritmi tribali, la black music, e molto ancora, senza mai fermarsi.
E così Battisti, oggi, non solo resta l’esempio della nostra ossatura melodica più intima e popolare, quella che, nei secoli, costruisce e costituisce il topos della canzone italiana nell’uomo italiano stesso, ma suggerisce la via verso il nuovo costante: suggerisce il metodo.
E il suo metodo non si piega, non cede, è costante come in un loop, continuo, senza sosta, inarrestabile: nonostante i tentativi di moglie e figlio di tenere la sua voce e il suo modo quanto più segreti e distanti da piattaforme streaming, eventi e ogni altra espressione della memoria. Dove Battisti, dunque, non può farsi memoria, si cristallizza di continuo nel presente, nel suo ritorno costante, nel suo farsi futuro. Che sia o meno una follia, che sia o meno una strategia, questa pudicizia assoluta e questi tentativi di segretezza totalizzanti non fanno che contribuire ad alimentare un mito che da sé non ha alcun bisogno d’essere alimentato e che non fa che perpetrare sé stesso in modo sempre più vivo, profondo e autentico.