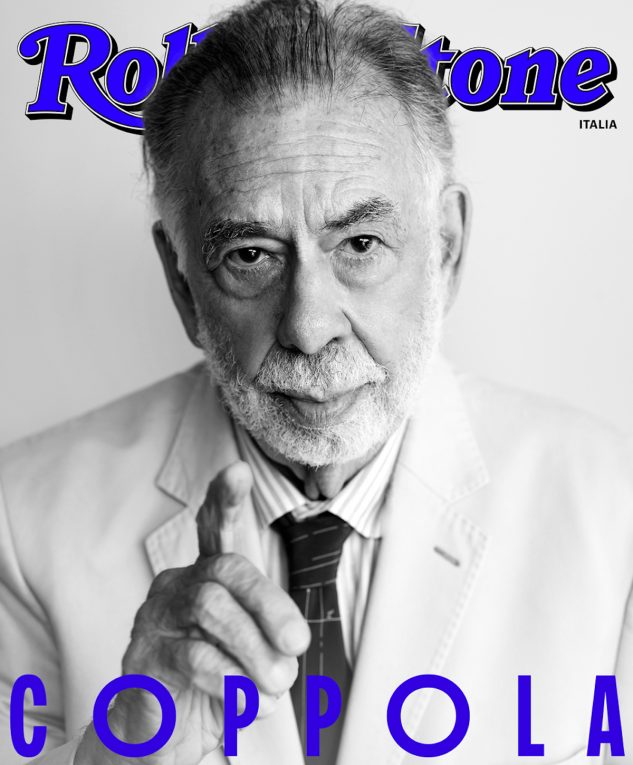Kurt Vile attraverso lo specchio
Seduto sul portico della villa dove ha presentato il suo ultimo album, Kurt Vile cerca una strada per calmare la mente. «Ho molto di cui essere felice, e molte cose per cui essere terrorizzato»
Foto di Jo McCaughey
In fondo alla lunga linea d’asfalto scavata nella foresta della New York State Route 28 c’è una vecchia villa spettrale chiamata Big Indian Springs. 20 stanze in stile vittoriano, poggiate sui 37 ettari delle colline ondeggianti di Catskill, una volta funzionavano da campeggio estivo per le giovani lavoratrici delle fabbriche tessili; adesso è un Airbnb. Sarà per i ritratti sbiaditi allineati sulle pareti, e i ragni e le rane che strisciano attraverso il giardino muschioso, ma l’atmosfera oscilla tra Dirty Dancing e The Shining a seconda del vostro personale grado di paranoia. Inutile prendere in mano lo smartphone. Qui non prende.
La vita ai confini della società si addice proprio bene a Kurt Vile. Seduto sulla veranda panoramica, blue jeans, una t-shirt verde che ha preso al Ramones Museum di Berlino e boccoli ribelli lunghi fino alle spalle, il cantante-chitarrista 38enne fa cadere in una bottiglia d’acqua alcune gocce di una sostanza con l’etichetta “Calm Mind”, poi la agita scrupolosamente. «Erbe ayurvediche», spiega dopo aver buttato giù l’intruglio. «È lo Xanax di madre natura». Non suona troppo convinto.

Kurt Vile, foto via Matador Records
Matador Records, l’etichetta di Vile, ha affittato il posto per qualche giorno con l’idea di festeggiare il completamento del suo settimo album, Bottle It In. C’è ancora molto da fare – un video da girare, un live in studio da suonare in streaming, tutte le prove con la band – ma questo sembra il luogo giusto per rilassarsi un po’, respirare l’ara di montagna e schiarirsi le idee dopo un anno logorante. O tre.
La scrittura del nuovo album si è allungata per molti mesi, un lungo periodo di tempo in cui Vile ha registrato un altro LP con l’amica Courtney Barnett (il delizioso Whole Lotta Sea Lice) e abbandonato una colonna sonora a cui lavorava da un po’. Circa un anno fa, sopraffatto dalle scadenze, ha rimandato l’uscita di Bottle It In al 12 ottobre. Altrimenti, dice, «sarei andato incontro a un grosso esaurimento. Tipico».
Dopo il debutto sulle cronache nazionali con Smoke Ring for My Halo, nel 2011, Vile è emerso come uno dei campioni più gentili dell’indie rock, un guitar hero onesto e capace di scrivere testi disarmanti, soprattutto quando racconta il suo onnipresente panico esistenziale. Prendi Pretty Pimpin, il singolo di lancio di B’lieve I’m Goin Down… (2011), dove canta di dissociazione immerso in una spirale di riff. “I woke up this morning / didn’t recognize the man in the mirror”. Con 44 milioni di stream su Spotify, è la sua unica hit.
Con Bottle It In, Kurt Vile fa del suo meglio per tornare sul pianeta Terra. Se il suo ultimo album solista era come una notte scura e solitaria, qui siamo di fronte a un’amichevole jam session con la sua band di sempre, i Violators. Sotto a una superficie così accomodante, però, Bottle It In si rivela un album dalle serie ambizioni. Nei brani migliori come One Trick Ponies e Loading Zones, Vile riesce a suonare un’altra hit rock & roll e contemporaneamente a cercare una pace interiore che sembra sempre sfuggirgli di un soffio.
Il chitarrista è convinto che parte del merito sia di sua moglie Suzanne Lang, che da 15 anni lo aiuta a stare con i piedi per terra. «Lei ha letto tutti i libri del mondo», dice incantato. «È una specie di essere illuminato». Specialista autodidatta in medicina ayurvedica – e insegnante delle loro due figlie, rispettivamente sei e otto anni, istruite a casa – Lang sta cercando di convincere suo marito a migliorare la dieta (ecco spiegato l’intruglio di prima). «L’obiettivo è diventare ogni volta un po’ più sano», spiega Vile. «E mi accorgo delle differenze».
Il passo più grande verso l’illuminazione, mi dice, è stato ridurre gli alcolici. «Non sembra mai un grosso problema, ma nel tempo l’alcool ti fa davvero male. Quest’anno ha aiutato a diminuire un po’ di stress, ma si aggraverà con il tempo». Per ora è solo un tentativo. Quando è arrivato qui a Catskills, ha passato quattro settimane completamente sobrio. «Poi mi sono bevuto qualche birra, e mi sono sentito annebbiato», dice scuotendo la testa. «Finito il weekend non berrò più».
Nato e cresciuto nella periferia di Philadelphia, Vile ha intrapreso la strada per il successo senza fretta. Agli inizi, verso la fine degli anni ’90, faceva girare cassette e cd con le registrazioni delle sue canzoni, poi ha co-fondato con l’amico Adam Granduciel una band conquista-festival come i War on Drugs, e infine, nel 2009, la firma da solista per Matador Records. «Sono sempre stato produttivo», dice. «Ho solo aspettato di avere più o meno 29 anni per pubblicare la mia musica».
Quando è uscito a settembre del 2015, B’lieve I’m Goin Down… sembrava l’ennesimo grande disco silenzioso in un catalogo pieno di uscite simili. Poi è arrivata Pretty Pimpin e il suo numero uno nella classifica alternative di Billboard, la prima hit della storia di Matador. «Quando la gente ti conosce solo per una canzone il mondo diventa diverso», dice Vile. «Ci siamo dovuti abituare a suonare in sale più grandi senza che io perdessi la testa – senza rinchiudermi in un guscio a pensare al disastro già durante la prima canzone. Il pubblico se ne accorge abbastanza facilmente».

Kurt Vile e Courtney Barnett sulla copertina del loro album
Con il tempo, ha imparato a tollerare e persino a godere delle sue nuove fortune: nelle pause tra i tour con i Violators portava la sua famiglia in vacanza alle Hawaii, o in Nuova Zelanda, e scriveva nuova musica nel tempo libero, per poi registrarla in studio il più velocemente possibile una volta tornato negli States. «Da ragazzino ho letto un libro sugli Stones», dice. «Andavano in studio a Los Angeles per un paio di giorni, non dormivano, registravano Satisfaction e tornavano in tour. C’è davvero un modo migliore per registrare? Suoni la tua musica e te ne vai fuori dai coglioni».
L’estate scorsa, dopo una serata memorabile con i Violators a Salt Lake City – «Era in un parco e i biglietti costavano poco, quindi c’erano qualcosa come 9mila persone, tutte fuori di testa» – è andato a Los Angeles per incontrare il produttore Shawn Everett. Aveva già registrato gran parte di Bottle It In con i suoi collaboratori storici, Rob Schnapf e Peter Katis, ma sentiva che mancava qualcosa; sperava che Everett, che ha messo le mani sui dischi rock più Grammy-friendly dell’ultimo decennio (compreso l’ultimo disco degli amici ed ex-colleghi War on Drugs), potesse aiutarlo a capire cosa. Poco prima dell’incontro, però, era certo di aver fatto un errore. «Ho praticamente avuto un attacco di panico, non sapevo come sarebbe andata a finire. Poi Shawn è arrivato ed è andata alla grande. Devi sentirti almeno un po’ a disagio prima di diventare libero, non credi?»
Tra le canzoni registrate con Everett ci sono i 9 minuti – il centro dell’album – di Bassackwards, un lento sogno psichedelico con un doppio fondo terrificante. In un certo senso, spiega Vile, è una canzone su un futuro in cui il riscaldamento globale e l’odio tra la gente sono andati fuori controllo. «Al momento il mondo è sottosopra da far schifo», dice.
Da buon cittadino bianco della Pennsylvania, e con una famiglia della classe operaia, Vile ricade alla perfezione nella fascia demografica che ha regalato lo stato a Donald Trump. Non ha votato per lui – «ovviamente» – ma conosce molte persone che sono su quella sponda del fiume, compresi alcuni tra i suoi nove fratelli e sorelle, quasi tutti della zona vicino Philadelphia. «Alcuni dei miei fratelli sono cristiani, quindi votano Repubblicano per l’aborto e tutto il resto», dice. «Durante le elezioni postavano video allucinanti. Il fatto che si voti una persona così negativa per inclinazioni religiose…»
Si interrompe e salta in piedi, pronto ad affrontare il resto della serata. «Ho molto di cui essere felice», mi dice. «E molte cose per cui essere terrorizzato».
Alcune ore dopo, la festa lubrificante per l’industria musicale è in pieno svolgimento. Nel perimetro si aggirano tutti e quattro i canadesi dei Sadies, il chitarrista Matt Sweeney; il presidente di Matador Records; la troupe di un documentario; una dozzina tra compagni di band, assistenti e dipendenti della label. Nel salotto i musicisti fanno a turno per suonare di fronte alla telecamera. Dopo un po’ diventa difficile distinguere il fumo delle macchine da fumo da quello delle sigarette elettroniche. Fuori, sul portico, qualcuno recita il testo di Feel Good Hit of the Summer dei Queens of the Stone Age. “Nicotine, Valium, Vicodin, marijuana, ecstasy and alcohol / C-c-c-c-c-cocaine!”. Ridono tutti.

Kurt Vile sul palco di Ypsigrock Festival nel 2014
Vile in persona rimbalza tra una stanza e l’altra armato di birra light: è l’anima della festa, cinque minuti per volta. È difficile capire se si stia divertendo davvero, ma con il passare del tempo sembra sempre più rilassato. Verso mezzanotte sale sul palco con i Violators, i Sadies e Sweeney per suonare una versione di Rollin’ With the Flow – un classico del country scritto nel ’77 da Charlie Rich -, l’unica cover nella scaletta di Bottle It In. “While guys my age are raising kids, I’m raisin’ hell just like I did”, canta Vile atteggiandosi da star di un piano bar. “I’ve got a lot of crazy friends, and they forgive me of my sins…”
Lo ritrovo sul portico la mattina dopo. Mangia un panino con la frittata e beve caffè nero. «Ieri notte ho pasticciato un po’», dice. «Questo sono davvero io». Prende in mano il banjo e pizzica una manciata di riff bluegrass. Tra un’ora partirà verso Philly. Tra un mese inizierà il tour con i Violators in Europa e Nord America. «Questo è stato un perfetto weekend di perdizione», aggiunge sfoderando il sorriso più genuino che abbia mai visto. «Adesso sono pronto a prendere la vita per le palle».