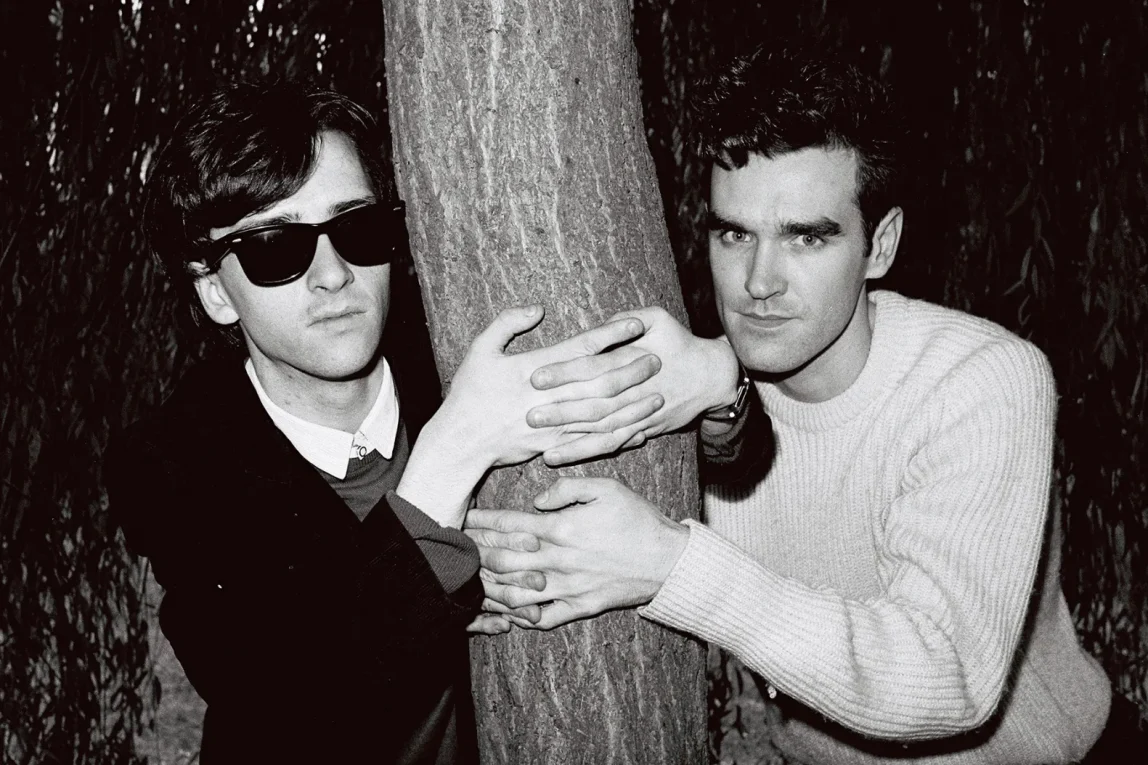Dave Haslam storce un po’ il naso se gli si offre una birra. Preferisce un calice di vino rosso. Cosa quantomeno inusuale per un inglese, ma è anche vero che Dave non è mai stato un tipo comune.
Quando ha iniziato a mettere dischi nell’Hacienda, leggendario tempio del clubbing voluto da New Order e Factory, nessuno a Manchester voleva fare il DJ. «Era un’epoca in cui era più cool fare il parrucchiere» mi racconta Haslam, seduto a un tavolino fuori dal Ral8022 a Milano, dove sta per mettere dischi in diretta su Radio Raheem. Ma è proprio questo suo essere anticonvenzionale ad avergli assicurato un futuro da giornalista musicale, professore universitario, scrittore, DJ preferito da Depeche Mode, Stone Roses e amici.
Dave sarà tra i protagonisti di BDC Weekender, evento parmense dedicato all’Hacienda e ai suoi protagonisti che inizia oggi e continuerà fino a domenica. Qui tutte le info.
Fare il DJ è sempre la tua professione principale?
Non so in realtà se ne ho una principale. Non ho un ordine preciso, vanno tutte di pari passo. Diciamo che è molto importante perché è quella che mi fa uscire di casa. E poi, se come me scrivi di musica, è meglio essere in prima linea. Ci sono tantissime persone della mia età che scrivono di musica e concerti senza schiodarsi dal divano, cosa che non mi convince molto. Non sono molto coinvolti, mentre non c’è niente di più coinvolgente di suonare davanti a centinaia di persone.
Giri sempre con i vinili?
No, preferisco i CD per comodità.
Beh, se vuoi essere ancora più comodo puoi portarti dietro solo le chiavette USB.
No, per due ragioni. Uno. Ho iniziato con i vinili, quindi sono abituato a maneggiare dischi. Devo metterne uno a sinistra e uno a destra, altrimenti il mio cervello mi dice che qualcosa non va. Ed è stato già abbastanza tragico passare dai vinili ai CD, fidati. Due. Se hai le chiavette UDB o peggio un laptop, potenzialmente hai a disposizione qualsiasi disco sia mai uscito nella storia. Se invece hai un libro di CD o una borsa di vinili ti stai limitando, puoi suonare solo quello che ti sei portato. Quindi non puoi imboccare la strada semplice.
È vero che hai venduto la tua intera collezione di vinili?
Sì, ho venduto 4500 vinili.
Perché?
Perché no, Claudio?
È un pezzo di storia, della tua storia.
Esattamente.
Quando è successo?
Tre anni fa ormai. Mi sono svegliato una mattina e li ho venduti tutti.
Come ti senti ora?
Nessun rimpianto. La musica esiste ancora, ora i dischi appartengono a Seth Troxler, il DJ. Li ha comprati tutti lui. Ogni tanto ricevo delle sue mail in cui mi scrive “Ho appena aperto la scatola numero 27”. Ci sono 35 scatole in tutto. È vero, è la mia storia. Ma è anche la storia di decenni e decenni di singoli e album che riguardano Manchester, la Factory Records, l’Hacienda… È come passare il testimone. E poi so bene che lui quei dischi li suonerà spesso e davanti a migliaia di persone. Fossero ancora miei, a quest’ora starebbero prendendo polvere su uno scaffale. Li ho comprati per suonarli: ora che non lo faccio più tanto, è giusto che qualcuno lo faccia per me. In più c’è un’altro aspetto da non sottovalutare. Gli uomini in particolare tendono a collezionare gli oggetti in maniera pericolosamente morbosa. Cose, oggetti, dischi: ci sono passato anche io, ma sono arrivato a un punto in cui mi sono imposto di non avere più bisogno emotivo dei dischi.
Non hai nemmeno una lista dei dischi che avevi?
No, ma Seth mi lascia spulciarli ogni volta che voglio. È stato un po’ come vendergli mia moglie, ogni tanto passo a trovarla.
Quanto spazio hai liberato vendendo i dischi?
Vivo in una vecchia casa di Manchester, una di quelle case che si servivano del carbone per ogni cosa. Ogni settimana, ti parlo tipo del 1935, l’omino del carbone arrivava in una stanza speciale dello scantinato chiamata il buco del carbone scaricava lì tutto. Ecco, la mia collezione stava nel buco del carbone. Ora ho di nuovo quella stanza indietro, ma non saprei proprio come usarla. Mi piace l’idea che i vinili siano là fuori, in ottime mani, impegnati in avventure emozionanti. Seth comunque è incredibile, è veramente matto per i vinili. Pensa che la scorsa estate ha portato tutta la mia collezione a Ibiza e poi l’ha fatta riportare a Londra, dove vive. Ora vuole comprare anche la collezione di Danny Tenaglia.
Come è riuscito ad aggiudicarsi i tuoi dischi?
Mi ha scritto una email. La notizia era su diversi siti, tipo Mixmag, Factmag. La mail iniziava così: “Ciao Dave, sono uno dei DJ più famosi al mondo” e lì ho pensato: “Beh, un bel modo per iniziare una mail”. Comunque io la vedo così: noi ereditiamo la musica. Per questo, siamo tenuti a lasciarla in eredità. Bisogna condividerla, bisogna avere il coraggio di cederla a un certo punto, per il bene di tutti. Però i singoli 7 pollici me li sono tenuti [risata generale, ndr].
Oggi siamo tutti DJ, ma cosa significava esserlo quando hai cominciato?
Quando ho cominciato nell’84/85, i DJ erano noti solo nell’ambiente reggae dei soundsystem e in quello jazz/funk del Northern Soul. Ma nel resto del mondo, specialmente nell’ambiente alternativo che frequentavo io, i DJ non avevano nomi, né venivano pagato granché. Non era una vera propria carriera. Donne e uomini di allora volevano fare i parrucchieri, perché era una cosa cool. Era molto più cool che essere un DJ: Era un lavoro vero e poi negli anni Ottanta la gente andava in giro con acconciature assurde. Se andavi a una festa e chiedevi “Oh, chi sta suonando?” ti rispondevano “Non lo so”. Se chiedevi “Cosa sta suonando?” ti dicevano “E chi se ne frega”. Per questo iniziare la carriera da DJ era facile: non c’era nessuno! Non avevi avversari, non c’erano altri 1000 DJ pronti a pugnalarti alle spalle come oggi. Nei primi tempi avevo una scatola di cartone con dei vinili dentro, aprivo i concerti delle band, mi spostavo col bus. I giradischi non avevano il pitch per aggiustare la velocità, il primo mixer dell’Hacienda non aveva crossfader. Era tutto così rudimentale. Era come un mestiere da artigiano, dovevi imparare a intrattenere 25 persone.
Quando ti sei accorto che il gioco per i DJ era cambiato?
Da parte mia, intorno all’89/’90. Per il resto degli anni Ottanta non ero mai stato il DJ ospite, capisci? Arrivavo all’Hacienda alle 9, mettevo dischi fino alle 2. Per 5 ore ero in consolle, ogni giovedì, ogni sabato. Magari ogni tanto qualcuno arrivava in consolle a darmi una mano per un’ora, ma non c’era l’ospite che veniva da chissà dove. Quella cosa prima o poi è cambiata. La gente ha cominciato a riconoscere i nomi dei DJ sui volantini. Nel giugno 1990 c’è stato il primo tour dell’Hacienda negli USA. C’eravamo io, Paul Oakenfold, Mike Pickering, Graeme Park. Quest’ultimo e io eravamo in una limousine dall’aeroporto al centro di Detroit, che all’epoca era pressoché inesistente, era un buco di culo. Ricordo che ci siamo guardati e ci siamo detti: “Come siamo finiti qui? In una limo, nel posto più incredibile della musica contemporanea?” Noi, che eravamo mestieranti di un locale di Manchester. Non sapevamo darci una spiegazione, il gioco era semplicemente cambiato. Nella data dopo, a Chicago, il proprietario del Metro club è venuto da noi dopo il set e ci ha detto: “C’è il pubblico più multirazziale che abbia mai visto qua dentro”. Quindi non solo ci siamo stupiti del fatto che eravamo lì, ma ci siamo anche sentiti fieri che una cosa del genere potesse succedere. Erano feste che univano la gente.
Ho guardato su Google Immagini, ora l’Hacienda è un tristissimo condominio di mattoni. Che effeto ti fa?
È stato aperto 15 anni, che è molto tempo per un club. Tutto deve avere una vita. Se fosse aperto tuttora, forse sarebbe meno speciale e tutto sarebbe più complicato. Se Robert De Niro fosse morto in un incidente aereo nel 1983, a quest’ora sarebbe uno degli attori più idolatrati di sempre. È ancora un ottimo attore, ma non è una leggenda. Quindi penso che sia un bene che l’Hacienda non ci sia più.
Il tuo nuovo libro si chiama Sonic Youth Slept on My Floor. È vero che hanno dormito sul tuo pavimento?
Eh sì, non è che ci fossero molti hotel disponibili. Negli anni Ottanta, parallelamente all’attività di DJ, ero anche promoter di eventi. Ho organizzato concerti dei Primal Scream, Big Black (la band di Steve Albini) e due volte i Sonic Youth. Ho chiamato così il mio libro mica per vantarmi, è soprattutto per ricordare a tutti (me compreso) che la migliore band degli anni Ottanta ha dovuto dormire sui pavimenti prima di diventare tale. Bisogna passarci necessariamente. Le cose all’inizio devono essere comuni e poco spettacolari. Poi vabbè, nel libro ci sono anche aneddoti divertenti. Come quando gli Happy Mondays che mi hanno rubato il telefax.