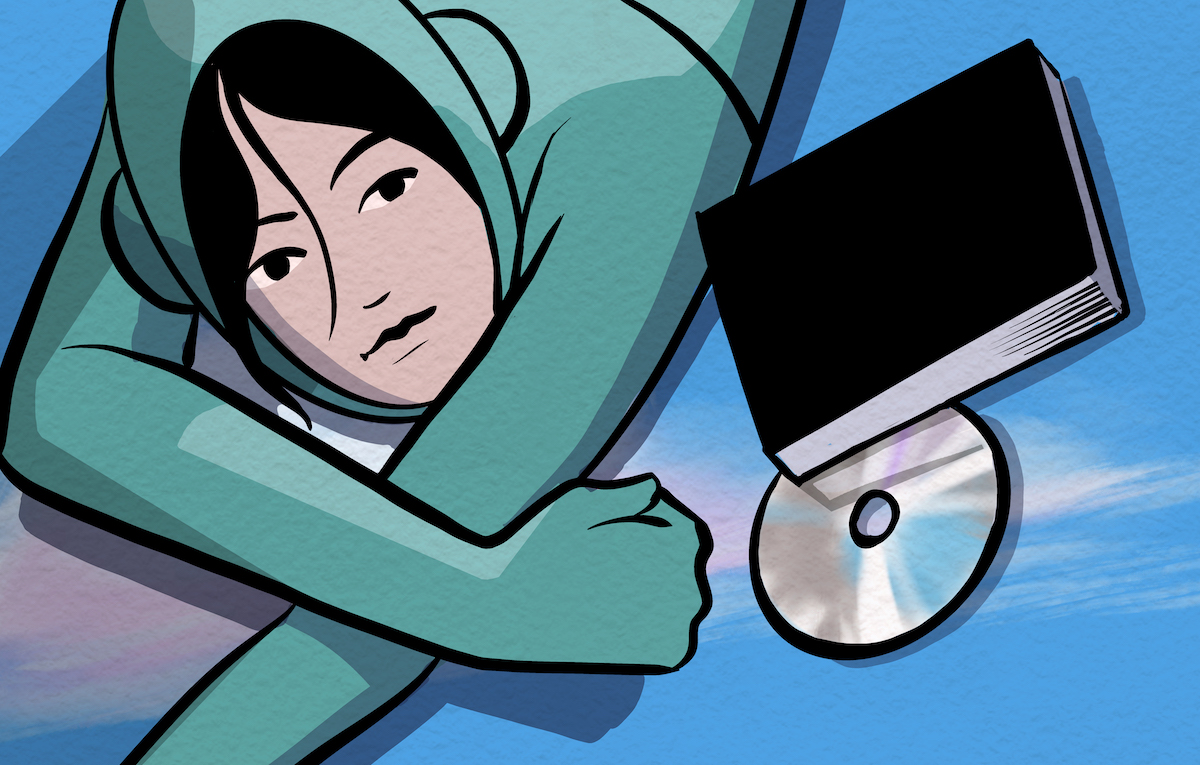Se parliamo dei Giardini di Mirò, Jukka Reverberi ha tante certezze di ferro ma pure delle sane perplessità. Per ciò che riguarda le prime, la chitarra e voce dei post-rocker emiliani è sicura che la sua rimane una band strumentale che, come nell’ultimo Different Times uscito per 42 Records, ogni tanto si concede l’inglese per non dover essere imprigionata dai confini geografici dell’italiano. Le seconde, le perplessità, comprendono invece la totale impossibilità di collocare i Giardini in un’ipotetico campionato delle band. In che serie sono arrivati a giocare dopo 20 anni, 7 album e un numero imprecisato di EP e mini album? Neanche lui te lo sa dire, e forse in realtà non gli importa, così come ai suoi soci. In fondo, c’è davvero bisogno di una serie A o una B quando puoi semplicemente metterti lì e giocare?
Sei in giro?
Sì ma posso parlare, sono appena uscito da lavoro.
Di cosa ti occupi?
Nella vita sono un dipendente pubblico. Lavoro al comune di Reggio Emilia dopo aver vinto un concorso. Mi occupo da sempre di campi nomadi e di alloggi di pronta accoglienza per persone che hanno emergenze abitative.
Quindi sarai una delle poche persone in Italia davvero competenti sui Rom.
Conosco bene sia le comunità dei rom che i pregiudizi verso di loro.
Oltretutto, com’è possibile che esistano ancora pregiudizi? I Rom saranno in Europa da 500 anni ormai.
Ma fai anche mille. È una migrazione che parte attorno all’anno mille dalla regione del fiume Sindh, in India. I rom e i sinti, che sono le due principali famiglie di nomadi europee sono arrivate qui facendo un percorso che è stato possibile tracciare linguisticamente. Cioè non dagli scritti dell’epoca—perché loro non ne lasciavano—ma dai lasciti linguistici dei loro idiomi, romanès e romani, sugli altri idiomi parlati. I si sono fermati nell’Europa orientale, mentre i sinti sono quelli della parte occidentale. Ma li chiamano in tanti modi a seconda del luogo: sinti qui e in Germania, jenisch in Svizzera, manouche in Francia.
Come mai allora dopo mille anni la gente ancora non riesce ad accettarli?
Per lo stesso motivo per il quale non abbiamo mai accettato neanche l’ebraismo. E a lorao volta, altri popoli non accettano minoranze che sono presenti nei loro territori. C’è sempre un gruppo bistrattato all’interno di una società maggioritaria. In primo luogo, per tanti è difficile accettare la diversità. In secondo luogo, i rom e i nomadi non hanno mai avuto una rappresentanza politica, quindi non sono mai riusciti a difendersi e a far valere i propri diritti in sedi ufficiali. Non hanno mai combattuto ad armi pari. E l’altra cosa è che loro non hanno mai combattuto, in tutti i sensi. Su questo nessuno può dire nulla: non hanno mai mosso guerra a nessuno. Non c’è mai stato un esercito dei rom che si è messo a sparare alla gente. E poi è una cultura basata su concetti diametralmente opposti alla nostra, come il nomadismo e l’espressione solamente orale. Alle volte, qualche pregiudizio che abbiamo su di loro poi si rivela esatto. Il problema però è vedere soltanto i pregiudizi. Qualche rom a rubare ci va, qualcuno fatica a comprendere l’importanza dello studio. Ma per uno di questi ce ne sono altri dieci onesti. A me interessa sempre capire come mai succede, quando succese, cosa facciamo noi per superare questa cosa e anche cosa fanno loro. È un argomento sempre molto delicato da trattare. Tutte le certezze sulle varie culture saltano sempre quando si parla di nomadi. Io e te parliamo di futuro e passato, loro parlano solo di presente. E questo è difficile da abbinare al tipo di vita che facciamo noi. È complicato.

Parliamo di musica che è più semplice. Il libro è uscito prima del nuovo album. Vuoi dire che è nata prima l’idea del libro?
Sì, è uscito prima ma è comunque l’album l’idea principale. È nata subito dopo il tour che abbiamo fatto anni fa, quello celebrativo del nostro primo disco. 42 Records ci aveva chiesto di fare la ristampa e visto che c’era ci ha chiesto di fare anche il tour. Eravamo fermi da un po’, quindi abbiamo accettato volentieri e devo dire che la cosa ci ha rigenerato. Paradossalmente, siamo sempre stati contrari alle operazioni nostalgiche e le celebrazioni del passato. Però alla fine ci ha dato una bella carica. Così in poco tempo abbiamo scritto il disco. Ci abbiamo messo un po’ di più a registrarlo. Il libro invece è una proposta che ci ha fatto l’autore. Ci ha chiesto il consenso, non è stata un’idea nostra ma di Marco Braggion. È un grande fan del gruppo, noi ce lo ricordiamo davvero dal primissimo album. È un grande esperto della nostra storia. Ma siccome lo siamo anche noi, gli abbiamo dato anche una mano. Ha voluto sicuramente sapere la nostra, forse proprio per soddisfare le sue curiosità da fan.
Però non è stata una reunion quella del tour celebrativo di Rise And Fall. Cioè comunque eravate in attività.
Sì, eravamo comunque attivi. Però ci è piaciuto fare una cosa del genere, riportare sul palco un disco che non suonavamo da tanto tempo. In quel modo, non lo facevamo dal 2001, da quando è uscito.
Ma siete uno di quei gruppi iperattivi anche nei momenti morti oppure dopo registrazioni e tour vari non vi volete più vedere per un po’?
Beh, noi abbiamo avuto dei periodi di “ciaociao ci vediamo la settimana prossima” e poi ci siamo visti dopo sei mesi. Però anche noi abbiamo una storia che dura da un ventennio. No anzi ventennio è una parola che non mi piace. Facciamo che sono vent’anni che suoniamo assieme, quindi ci sta che ogni tanto uno suoni con altri. Soprattutto perché, a differenza di altri gruppi, non ci siamo concentrati solo sui Giardini di Mirò. Dai 2000 in poi ci siamo concentrati su tanti gruppi e progetti paralleli, che inevitabilmente ci hanno portato via tanto tempo. E poi noi lavoriamo tutti quanti, non facciamo solo i musicisti. E siamo quasi tutti padri di famiglia. Capirai bene che far combaciare tutto diventa un po’ un impresa.
Cavriago è ancora il punto di riferimento del gruppo?
Fa abbastanza ridere perché non ci abita più nessuno di noi. Due di noi, di cui uno sono io, hanno ancora le famiglie lì. Io sono un cavriaghese DOC da varie generazioni. Ci vado spesso, almeno una volta a settimana, anche perché abito a 8 km da lì. Ma ora mi sono spostato a Reggio anche per esigenze di lavoro.
Gli altri si sono spostati di tanto?
Corrado [Nuccini, ndr] si è trasferito a Modena, quindi ha proprio cambiato provincia. Gli altri comunque abitavano nei dintorni e a un certo punto ci siamo trovati tutti ad abitare in città, a Reggio. Ora, molti si sono di nuovo rispostati.
E le prove?
Ecco, se non altro le prove le abbiamo sempre fatte a Cavriago. Per anni abbiamo continuato a provare lì, in uno storico circo lo Arci che si chiamava Circolo Calamita e che ora si chiama Kessel. Non ci proviamo più, perché non ci sono più le sale di prova. L’album comunque l’abbiamo scritto lì. Le prime prove le abbiamo fatte lì ma poi quando c’è stato bisogno di una sala prova allestita ci siamo spostati.
Molti vostri coevi che vengono dal cosiddetto indie anni 2000 e che come voi cantavano in inglese ora sono perlopiù progetti pop solisti in italiano. Che effetto vi fa? Vi sentite costanti e fedeli ai capisaldi di band e in lingua ingkese?
Come Giardini di Mirò, sì, assolutamente. Perché sarebbe snaturare la storia del gruppo e la nostra essenza, che è quella di gruppo strumentale che canta in inglese. Ne cantiamo sempre di più. Per noi è una gara che non so se abbiamo vinto e non so se abbiamo perso, ma il nostro obbiettivo è sempre stato essere un gruppo internazionale. Quindi di poter uscire dai nostri confini e andar fuori a vivere in modo pieno la musica. Ci sembrava che l’italiano potesse essere una gabbia, che potesse aiutarti in Italia ma precluderti il resto del mondo. E diciamoci la verità: ti preclude ancora il mondo. Perché andare a fare i tour tra gli italiani espatriati a Londra o Berlino adesso è un business, però per noi non aveva senso. Volevamo giocarcela con le altre band internazionali. Per noi l’inglese è stata una scelta internazionalista, un modo per guardare fuori. Ed è tuttora la regola per i Giardini di Mirò.

E infatti avete appena annunciato un tour in Cina. Lì di italiani espatriati non ce n’è molti. Come mai proprio la Cina?
Sinceramente, ci hanno scritto un giorno e ci hanno chiesto se andavamo a suonare in Cina. Noi oltretutto abbiamo sempre stampato quasi tutti i nostri dischi a Taiwan. C’è un’etichetta che ha sempre stampato e distribuito le nostre cose lì. Non abbiamo mai visto uno statement di vendite, ma non ce n’è mai fregato nulla. Non è che abbiamo mai pensato di arricchirci con la nostra musica. Semmai, il nostro desiderio è sempre stato di farla girare il più possibile. E poi parlando con altri gruppi abbiamo scoperto l’esistenza di questa agenzia cinese specializzata o quasi negli artisti post-rock. Non solo le prime linee ma anche le seconde, le terze, le quarte. Adesso, noi non so bene in quale linea siamo. Non so bene se siamo in serie A, B o C o in eccellenza. Però ci hanno chiamato in Cina e noi andiamo volentieri. Ci avevano proposto inizialmente più di 9 date ma ci limiteremo a quelle. In fondo teniamo famiglia, figli e lavoro.
Fa sorridere che nell’era della contraddizione eterna fra un pensiero socialista in un sistema capitalista voi siate finiti nella nazione più contraddittorio.
Eh sì, il famoso socialismo di mercato. Ma anche io sono curiosissimo. Dal punto di vista culturale, se non allargo troppo lo sguardo ma lo tengo all’interno della scena musicale, abbiamo imparato a conoscere l’occidente, soprattutto filtrato dalla parte americana e inglese. Quindi andare a suonare in un posto completamente nuovo mi stuzzica, soprattutto sotto questo punto di vista. Figurati che per noi è sempre stata esotica la Grecia. Siamo andati spesso a suonare là. Adesso dopo la crisi non siamo più andati, ma per un periodo abbiamo fatto tante date lì, davanti a tanta gente. Già solo quello ci sembrava andare a toccare l’esotico. Adesso, cazzo, la Cina è tutto un altro campionato.
Gira che ti rigira, alla fine vi hanno sempre chiamato “i Mogwai italiani”. Uno cambia campionato, canta in inglese per darsi un respiro internazionale e poi ci sono sempre ‘sti Mogwai a rompere il cazzo. Non vi ha stancato un po’ questo eterno paragone?
Credo che in un certo senso sia un po’ colpa della pigrizia di certi ascoltatori. Uno sente un strumentale con i delay che ogni tanto canta, allora subito Mogwai. “Ho sentito solo quelli, quindi li abbino a loro”. Poi se vai a vedere i nostri dischi e i loro ci sono differenze abissali.

Infatti.
Se devo ammettere che negli anni Novanta abbiamo scritto un pezzo che aveva una coda che tecnicamente era identico a uno dei Mogwai ti dico di sì. Ma è un pezzo, negli anni Novanta. Le nostre carriere non sono identiche. Ci sono due cose che ci accomunano, che sono le influenze dei gruppi che abbiamo ascoltato e anche il periodo in cui abbiamo iniziato a suonare, praticamente lo stesso. Noi siamo arrivati un po’ più tardi col primo LP, ma perché in Regno Unito erano un po’ più avvantaggiati essendo nato praticamente lì il genere. Sicuramente c’è un patrimonio culturale condiviso fra i due gruppi. Ma sono due band che hanno sapori e colori differenti.
Beh, in comune avete anche il lavoro fatto su colonne sonore.
Quello è un campo non del tutto nuovo per noi ma che vorremmo implementare. Abbiamo curato le musiche originali di Sangue, un film di Libero de Rienzo con Elio Germano. Poi abbiamo musicato delle pellicole per conto del Museo del Cinema e abbiamo venduto anche tanti pezzi per trasmissioni della RAI. Curiamo un corso a Modena che si chiama Soundtrack, incentrato apposta su musica e colonne sonore.
Qualche anno fa avete provato anche a liberarvi del post-rock, con Good Luck.
Ma anche se prendi Dividing Opinions, che è il disco che avuto più successo se per successo intendi quello che ha venduto di più/quante presenze al concerto/eccetera, beh, lì di post-rock c’è poco o nulla. Anzi, la title track è lunga due minuti e mezzo, roba che nel post-rock manco l’intro. Però detto ciò quegli elementi sono lì nel nostro suono e ci saranno sempre. Perché a noi piacciono e non abbiamo nessuna intenzione di toglierli. In più sappiamo bene che le parti strumentali sono quelle su cui poi dal vivo riusciamo a dare il meglio. Non abbiamo nessuna intenzione di lasciar perdere quelle parti. Ci piace metterle e giocarle in modo diverso in ogni disco, questo sì.