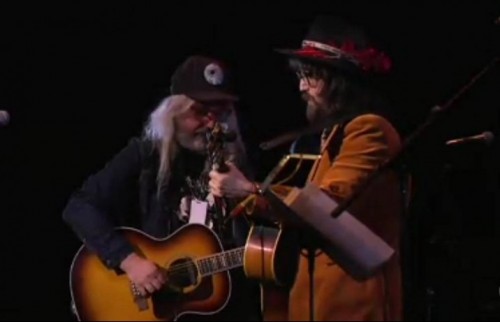Quando incontro Anna Calvi, mi trovo davanti una persona timidissima, schermata tutto il tempo da occhialoni scuri, che parla sussurrando. Sembra quasi un personaggio finto alla J.T. Leroy. La sera si esibisce in concerto alle Terme di Diocleziano. Credo sia una delle performance più coinvolgenti e potenti che abbia mai visto.
La schizofrenia tra la Calvi performer e la Calvi fuori dal palco è talmente assurda che mi chiedo se non ci sia qualcosa di iper-consapevole nel portarla avanti. «Le due identità si nutrono a vicenda. Non potrei mai avere quell’energia che ho sul palco nella mia vita reale, perché altrimenti non riuscirei più ad avercela sul palco». Inevitabilmente il riferimento che si tira fuori quando si parla di lei è PJ Harvey. «Per me il modello è Jeff Buckley», mi confessa, «è lui il motivo per cui ho questa chitarra».
Hunter, il suo nuovo lavoro, è un inno alla libertà, ma anche un disco pieno di devozione. Le chiedo come si concilino le due cose. «Quello che cerco è uno spazio tra un sentimento eversivo e uno divino. In fondo si è liberi attraverso le costrizioni. Quando ti innamori, per esempio, è così». I suoi testi hanno una qualità molto impressionista, sembrano quadri sotto forma di parole. «È come se visualizzassi dei microfilm in testa, e potessi toccarli ed espanderli», mi dice. «Vedo delle immagini nitide, infatti mi sorprendo sempre se poi qualcuno ci vede cose diverse da me». In alcuni casi assomigliano alla trascrizione di sogni, un onirismo incarnato nel quotidiano.
Un po’ marzullianamente le chiedo se lei ce l’abbia, un sogno ricorrente. «Sì, ma è un incubo. Sogno di salire sul palco e vedere tutta la gente che se ne va». “E quando l’hai fatto l’ultima volta?”, le chiedo. Ride: «Ieri notte».