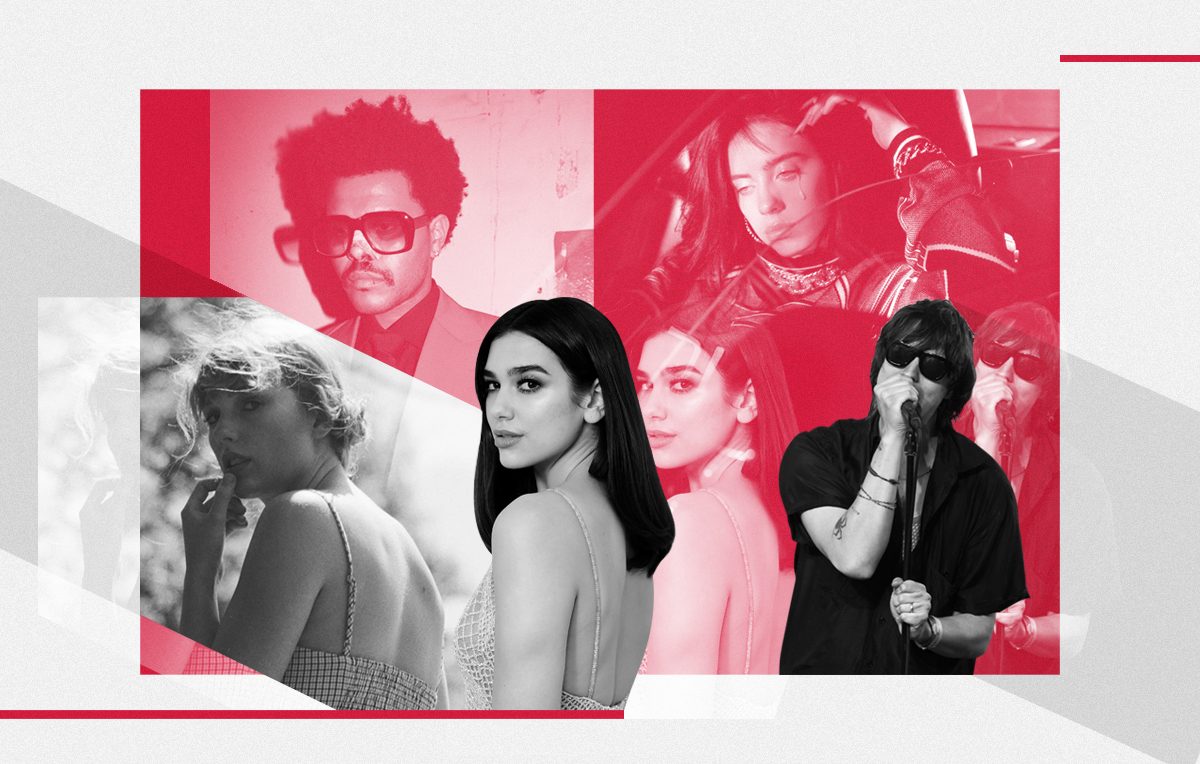A un giornalista di Life che le chiedeva conto delle tante occasioni in cui aveva recitato la battuta «voglio star sola», Greta Garbo rispose che aveva detto semmai «voglio essere lasciata in pace». Una cosa del genere la si può immaginare detta da Fiona Apple, la più riverita ed enigmatica cantautrice uscita dagli anni ’90 americani. Lei, ragazza prodigio cresciuta per qualche anno in pubblico, a un certo punto s’è sottratta allo sguardo di spettatori e media e curiosi con una perseveranza d’altri tempi. Non è sparita come la Garbo, ma pubblica musica con estrema parsimonia, solo quando ha qualcosa da dire, solo quando sa come dirlo.
Aspettare otto anni per fare un disco è un’affermazione significativa in un mondo in cui gli artisti mirano a occupare lo spazio mediatico con una caparbietà che fa pensare che sparire dall’orizzonte equivalga per i poveri disgraziati a una condanna a morte. E per alcuni di loro lo è, in un certo senso: hanno poco da dire, per questo parlano tanto. Non è il caso di Fiona Apple e per un semplice motivo: lei ha talento. La percezione della sua bravura è rafforzata dalla sua assenza. Il suo sottrarsi agli occhi accende la fantasia e fa impennare la curiosità per quel che sta facendo, per quel che farà. Ecco perché il suo nuovo album sta raccogliendo consensi in modo persino imbarazzante. Li merita. È uno di quei lavori meravigliosamente originali, pieni di cose, che parlano una lingua sonora originale, messa a punto con cura artigianale. Apple l’ha prodotto con la sua band, Amy Aileen Wood, Sebastian Steinberg e David Garza, partendo da registrazioni effettuate sostanzialmente a casa e rifinite nell’arco di anni. Ma al contrario di certi dischi che escono da lunghe lavorazioni come spossati e talmente levigati da perdere ogni spontaneità, quest’album suona grezzo e potente.

«Esco e guardo gli esseri umani», ha detto Greta Garbo in un’altra intervista. Occhio e croce è quel che ha fatto Fiona Apple negli ultimi anni. Al centro del suo nuovo album ci sono storie di donne. Ci sono amanti che parlano delle mogli degli altri e mogli che dopo anni di vita coniugale si sentono astronaute schiacciate dalla forza di gravità. Ce n’è una che ripensa alla ragazza che l’ha bullizzata a scuola e un’altra che prova un disperato bisogno d’amore. Un’altra ancora è vittima di molestie e una descrive la depressione come un palla da lanciare in aria che diventa tanto, troppo pesante. In queste 13 canzoni c’è anche un pezzetto di biografia della cantante e c’è soprattutto una voglia d’indipendenza viscerale. E poi la rabbia che bisogna scaricare in qualche modo perché, come canta Apple, il male è uno sport a staffetta in cui a un certo punto passi il testimone a qualcun altro. Alcuni testi sono volutamente elementari, basati sulla ripetizione di poche frasi sottolineate da ritmi martellanti. Ma anche quelle poche parole diventano potenti calate nel giusto contesto musicale.
Il suono è costruito con pochi colori primari ben scelti: un pianoforte che picchia e che ti sembra di stare lì, attaccato a martelletti e corde; un basso che senti vibrare; una bella serie di suoni percussivi imprevedibili, vividi e metallici, ottenuti a volte picchiando su oggetti d’uso quotidiano (bisognerà studiarsela bene questa Amy Aileen Wood); un piccolo armamentario di altri strumenti scelti per le qualità timbriche. Si sente persino l’influenza di certe orchestre di percussioni haitiane e del gospel americano. L’album è stato mixato con Tchad Blake, un produttore specializzato nel trasmettere a chi ascolta la sensazione della presenza fisica, quasi tattile degli strumenti. Il risultato è un sound primitivo e avventuroso, pieno di gesti musicali di cui l’avanzamento della tecnologia digitale ci ha in parte privati.

Foto: press
La scrittura è sempre lucida e ispirata, con picchi di follia cui è difficile resistere. Le canzoni sono piene di svolte inattese, introduzioni e code un po’ pazze che rendono l’album lievemente bizzarro. Fiona Apple canta fregandosene di tutto con lo spirito della jazzista e a volte della sperimentatrice. Rende spettacolare l’imperfezione, assume una voce diversa per ogni canzone, la usa come uno strumento. Seduce, urla, canta come una bambina, si unisce a cori femminili che sembrano la trasposizione di canti da cortile, quasi la versione raffinata di quel che facevano le Slits. Non è una cosa secondaria. L’elemento giocoso e a tratti infantile del disco ne stempera la vena drammatica. Fiona Apple trasforma vicende traumatiche o semplicemente dolorose in un’esperienza sonora grandiosa, e senza piangersi addosso, ma anzi trascendendoli con talento, ironia e un’immaginazione senza limiti. Le eroine dell’empowerment prendano nota: così si fa.
Siccome Apple ha una predilezione per i titoli strani e ancora si ricorda quello dell’album del 1999 che contava 444 caratteri e 90 parole per comodità abbreviate in When the Pawn, tutta questa roba, queste storie, questi suoni li ha messi dentro a un disco titolato Fetch the Bolt Cutters. È una battuta pronunciata dalla detective Stella Gibson nella serie The Fall. Il personaggio interpretato da Gillian Anderson si trova di fronte a una porta chiusa dietro alla quale una ragazza è stata torturata. «Prendete le tronchesi», ordina per entrare nella stanza. «Prendete le tronchesi, sono stata qui fin troppo», recita il testo del brano che dà il titolo all’album e che esprime il desiderio di Apple di liberarsi da un personaggio in cui è stata costretta e in cui non si riconosce, di uscire da una qualche prigione, insomma di reagire. Ed è la sensazione liberatoria che trasmette quest’album senza regole, anzi, con delle regole tutte sue. In un’altra canzone chiamata For Her e ispirata dalla vicenda del giudice della Corte suprema Brett Kavanaugh, la cantante interpreta una ragazza che rinfaccia al suo aguzzino di averla violentata «sul letto dov’è nata tua figlia». Ecco, in quest’altra cosa Fiona Apple è imbattibile: riesce a farti amare una canzone e detestare la storia che racconta.