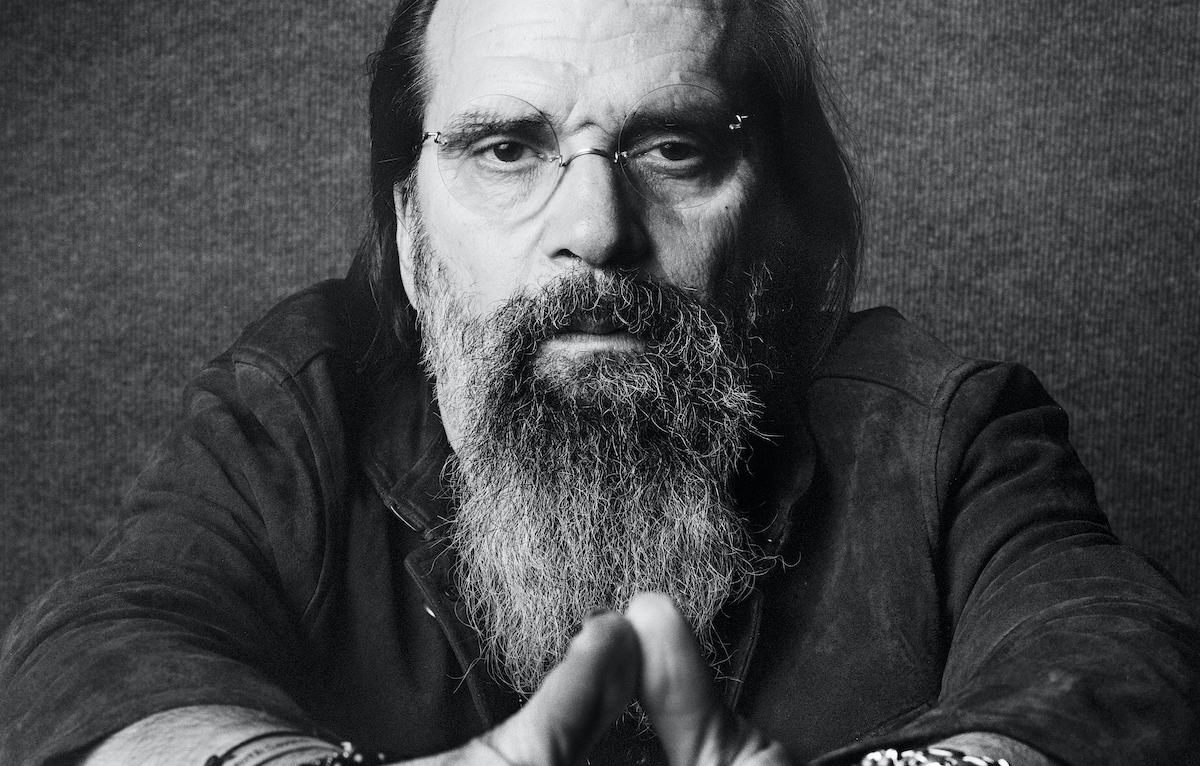Basta scavare appena sotto la superficie country-rock dei primi dischi di Steve Earle per trovare descrizioni toccanti della vita della classe operaia americana. L’esordio del 1986 Guitar Town è pieno zeppo di personaggi impantanati in cittadine di provincia o nella campagna, gente che tira a campare in posti spiritualmente desolati ed economicamente impoveriti. Nella title track, Earle descrive la sua stessa vita, piazzando un bel riferimento a Hank Williams. “Dove sono nato non è mai successo un bel niente / Non sono il tipo che se ne va in giro a zonzo / ma un giorno ho sentito come una chiamata / e ho seguito quella voce lungo una strada perduta”, canta Earle citando il classico di Williams Lost Highway.
Queste immagini di vita di provincia, abbinate alla descrizione della voglia di lasciarsela alle spalle, sono tipicamente blue collar e senza tempo. I personaggi di Earle non sono vittime del destino, ma dalle forze della cultura e dell’economia, ed è proprio su questi temi che il rocker torna nel suo ultimo progetto Ghosts of West Virginia. Nei primi lavori, desideri e realtà erano separati ed è in quella distanza che si giocava il significato ultimo della lotta per la sopravvivenza. In Someday, inno springsteeniano tratto da Guitar Town, si raccontava di un giovane benzinaio che desidera sapere “cosa c’è oltre l’arcobaleno”. In No. 29, dal secondo album Exit O, a un uomo di mezza età non restano che i ricordi dei vecchi giorni di gloria e li rievoca guardando ogni venerdì la star della squadra locale di football che scende in campo con indosso la maglia che un tempo era stata sua. All’inizio Steve Earle faceva country, d’accordo: le sue canzoni parlavano di lavoratori frustrati e della piccole cose che li aiutano a campare. Ma era musica country scritta da uno che la città la conosce bene.
In Copperhead Road, title track del terzo album, un veterano del Vietnam che vive nella parte Scotch-Irish del Tennessee e soffre probabilmente di disturbo da stress post-traumatico, segue le orme del nonno contrabbandiere e si mette a coltivare marijuana finendo nel mirino della DEA. Il protagonista della canzone si chiama John Lee Pettimore e si è arruolato volontario a 18 anni perché “da queste parti comunque arruolavano anzitutto la feccia bianca”. La canzone era un’elegia hillbilly feroce e apocalittica.
Dopo un solo altro album negli anni ’90, The Hard Way, Earle è sparito per quattro anni sia dal punto di vista artistico che personale a causa della dipendenza da droga che l’ha portato all’incarcerazione e alla disintossicazione, per poi riemergere con una serie di dischi magnifici che hanno descritto l’intero arco stilistico della musica delle radici. A quel punto, le sue canzoni a sfondo sociale e politico s’inserivano nella grande tradizione del folk di sinistra di Joe Hill, Woody Guthrie e del primo Bob Dylan. In Christmas in Washington, dall’album del 1997 El Corazón, Earle evocava il fantasma di Guthrie nel ritornello, quando cantava che “i sindacati sono stati fermati, i loro striscioni rossi e fieri fatti a brandelli / La radio dice cheta tutto bene, ma io, te e Cisco sappiamo che andrà tutto in malora”.
In quel periodo la musica di Earle era adatta agli ascoltatori di NPR o ai fan di Michael Moore, non al pubblico country che è notoriamente allergico alle prese di posizione politiche nelle canzoni. Poi, nel 1999, Earle ha pubblicato un disco registrato con la Del McCoury Band, The Mountain. Canzoni come Harlan Man e Graveyard Shift rendevano omaggio alle vite dei minatori, mentre la title track, una delle migliori ballate mai scritte da Earle, puntava il dito contro l’irreversibile danno ecologico fatto dalle miniere a cielo aperto.
L’album del 2002 Jerusalem, scritto dopo gli attacchi dell’11 settembre, conteneva la canzone più divisiva del rocker, John Walker’s Blues, un pezzo con un sound alla Revolver scritto dal punto di vista di John Walker Lindh, il celebre Talebano americano. Nel 2004, giusto in tempo per lo scontro Bush-Kerry nelle elezioni presidenziali, arrivata The Revolution Starts Now, un ciclo di canzoni di denuncia dell’avventura americana in Iraq. Nel brano di punta Rich Man’s War Earle cantava dal punto di vista dell’ennesimo “poveraccio che va a combattere una guerra decisa dai ricchi”. Earle aveva un’agenda politica e non faceva nulla per nasconderlo
Dopo 16 anni e molti altri dischi, Earle è tornato con Ghosts of West Virginia. L’album si accompagna allo spettacolo off-Broadway Coal Country che racconta la vita dei 29 minatori del West Virginia morti nel 2010 nell’esplosione dell’Upper Big Branch, uno dei peggiori disastri minerari della storia americana. Un’indagine ha rivelato innumerevoli violazioni della sicurezza e un tentativo di insabbiamento, che ha portato a un accordo da 209 milioni di dollari con il Dipartimento di Giustizia. Gli autori di Coal Country sono Jessica Blank ed Erik Jensen. Hanno passato anni a intervistare i sopravvissuti alla tragedia e i familiari delle vittime. Earle è andato in West Virginia dove ha scritto sette canzoni per lo spettacolo. Ha cantato i pezzi sul palco – una sorta di “coro greco con la chitarra”, come ha detto lui stesso – prima che le rappresentazioni finissero dopo appena settimane a causa del Covid-19. Il disco è un po’ il complemento dell’opera teatrale.
Di recente, Earle ha detto che la sinistra americana ha perso contatto con la classe operaia, un fatto che ha contribuito all’elezione di Donald Trump. Con gli schieramenti politici oramai sempre più distanti, siamo incapaci di comunicare con chi non la pensa come noi ed è questo forse il motivo di una crisi senza precedenti nella recente storia americana. Ecco perché in Ghosts of West Virginia Earle dà voce a un segmento della popolazione che non vota come lui e ha buone ragioni per farlo.
«Sentivo che, per come stanno le cose, dovevo fare un disco in grado di parlare a e per le persone che non votano come me», dice Earle in un comunicato stampa. «Se quelli come me continueranno a pensare che chiunque abbia votato Trump sia uno stronzo razzista saremo fottuti, perché non è vero. Ci vorrà una generazione prima che questa cosa cambi. Volevo fare un primo passo nella direzione del dialogo. Non è detto che io non abbia nulla in comune con le persone che non la pensano come me. Dobbiamo imparare a comunicare l’uno con l’altro. Questo progetto è il mio piccolo contributo in questo senso. Il mio modo per farlo è onorando i ragazzi morti all’Upper Big Branch».
Earle ha registrato le 10 canzoni di Ghosts of West Virginia con la sua band di sempre, i Dukes. Musicalmente, l’album va dall’hard folk degli Appalachi (nello spirito della Anthology of American Folk Music di Harry Smith) a delicate ballate country e a numeri da coffehouse anni ’60.
Union, God And Country potrebbe essere stata scritta negli anni ’30. Rievoca il grido d’allarme dei minatori di un tempo. It’s About Blood parla delle conseguenze traumatiche dell’esplosione per le famiglie e testimonia il legame generazionale dei minatori in West Virginia. “Si tratta di padri / Si tratta di figli / Si tratta di amanti che si svegliano nel cuore della notte, soli”, canta Earle, aggiungendo: “Una volta in America, un lavoratore sapeva da parte stare / Oggi campa per miracolo”. Sul finire della canzone, Earle grida i nomi dei minatori uccisi nell’esplosione. È una cosa che toglie il fiato.
Un altro pezzo di Ghosts intitolato John Henry Was a Steel Driving Man s’inserisce in una lunga tradizione di canzoni dedicate all’eroe popolare evocato dal titolo (che è anche il nome del figlio minore di Earle): si immagina Henry come il precursore del movimento sindacale del West Virginia. Black Lung è su uno dei grandi nemici dei minatori, l’antracosi, mentre Devil Put the Coal in the Ground è un bruciante numero per banjo suonato con una accordatura modale. If I Could See Your Face Again, che arriva a metà album, è il pezzo che vi farà piangere. È scritto dal punto di vista della moglie di uno dei minatori uccisi. Mentre osserva la vallata a fine giornata, la donna immagina un futuro alternativo con l’uomo oramai scomparso: “Potremmo trovare una città / dove i sogni non sono sepolti sottoterra / e non ci sono così tanti fantasmi in giro a perseguitarci”.
Ma è nel brano di chiusura, intitolato semplicemente The Mine, che la scrittura di Earle emerge in tutta la sua brillantezza. Anche se non la cita esplicitamente, la canzone affronta la crisi degli oppioidi che sta devastando gran parte del Paese, soprattutto Stati come il West Virginia, che secondo i Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie, nel 2019 ha avuto il più alto tasso di mortalità negli Stati Uniti per overdose.
The Mine racconta la storia di un disoccupato del West Virginia il cui fratello lavora nella miniera locale e guida un nuovissimo camioncino Dodge Ram dotato di radio satellitare. Il narratore ha una residua speranza per sé e per la sua ragazza, anch’essa tossicodipendente: potrà rimettersi in sesto e trovare un lavoro in miniera se suo fratello saprà far fruttare i giusti agganci. L’uomo non pensa alla fuga perché istintivamente sa che non lascerà mai il West Virginia. “Quando vivi qui tutta una vita, le montagne diventano parte di te e non c’è modo di farle uscire”, canta Earle.
«Non puoi comunicare con gli altri se non comprendi la loro vita e quel che dà significato alle loro giornate», ha spiegato Earle. «È il punto fondamentale di Ghosts of West Virginia». Non è solo una questione artistica, in questo momento storico è una necessità politica e sociale. Albert Maysles, il documentarista di Gimme Shelter, ha detto più o meno la stessa cosa quando ha osservato che «la tirannia è la rimozione deliberata delle sfumature». Proprio come accadeva nei dischi migliori di inizio carriera, allo Steve Earle di Ghosts of West Virginia non sfugge un solo dettaglio.