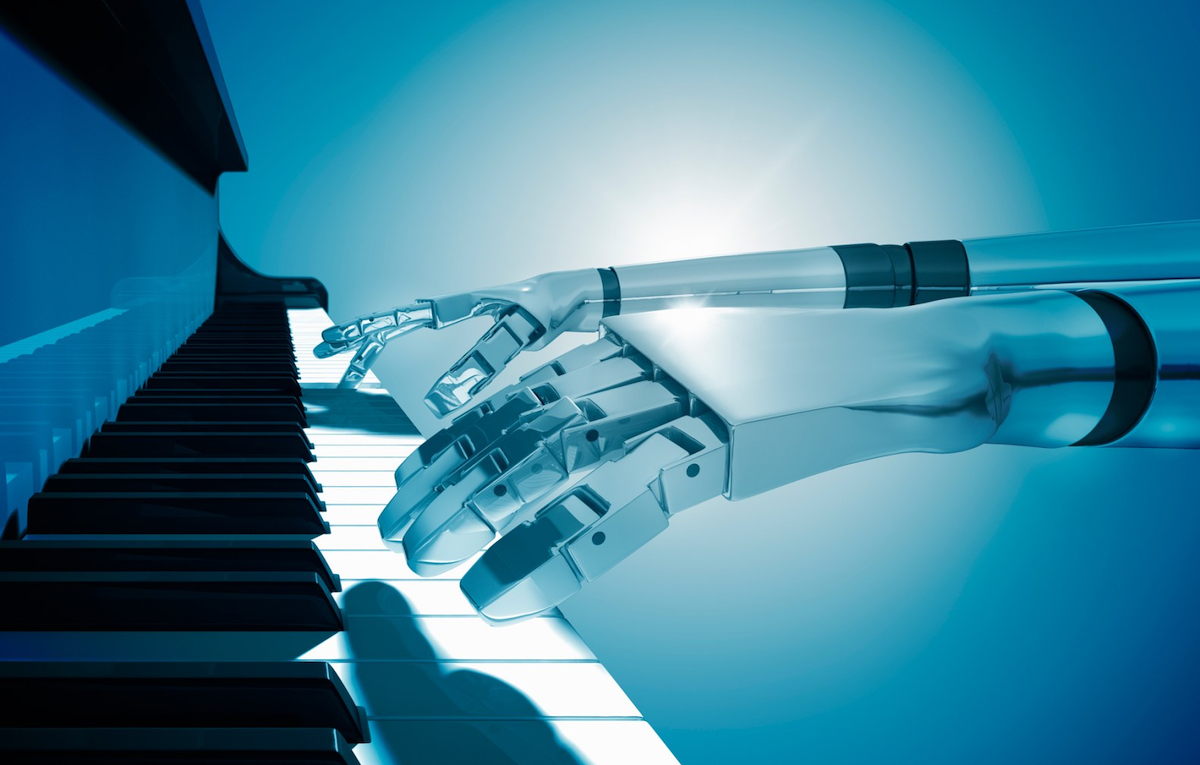Sanremo? Adesso sì che è un problema per tutti, questa è la verità. Ora sì, infatti, che avvelena i pozzi per davvero e bisogna farci i conti, guardinghi. Non prima: ora. Già. Perché cosa ci importava della saga rivierasca quando era solo un carrozzone messo a punto da Pippo Baudo e dagli alti uffici della Rai, con una etnia di cantanti che (spesso) pareva solo sopravvivere fra gli spazi del Teatro Ariston e poi nelle sagre e nelle feste di piazza estive messe su da qualche assessore alla cultura scarso e panciuto? Non era affar nostro. Ci importava che era un capro espiatorio meraviglioso, quello sì, se proprio volevamo degnarla della nostra attenzione. Era l’altro. Era il nemico. E lo è stato, attenzione, anche quando hanno iniziato a metterci piede i Subsonica, i Bluvertigo, i Marlene Kuntz, gli Afterhours: perché tutti loro, nessuno escluso, mettevano piede fra i fiorellini aristoniani col piglio da «eh lo so che sto facendo una cosa iconoclasta e trasgressiva, lo sto che vi sto stupendo»: stupore che poteva essere sia positivo che negativo, con la polemica un tempo vitalissima e ora invece sempre più ammuffita e residualmente manuelagnellistica del «fino a che punto è giusto che quelli della scena alternativa si contagino con la scena mainstream televisiva? Fino a che punto è giusto (s)vendersi? Fino a che punto ha senso gettare dei ponti rischiando di sputtanarsi?».
Era comodo pensare così. Accapigliarsi su ‘ste cose. Facilitava l’interpretazione, gli schieramenti, gli opinionismi. Buoni vs. cattivi, cioè. Coi buoni che entravano nel regno dei cattivi o per provare a riformare il sistema dall’interno (visione buonista e veltroniana) o semplicemente per provare a rimpinguare il conto in banca fingendo di farlo invece per la Causa (visione io-sono-meglio-di-te); ma fosse come fosse, in ogni caso c’era questa chiara contrapposizione, questa alterità che restava solida e chiaramente percepita anche quando si mescolavano un po’ le carte.
È saltato tutto per aria. C’erano già stati i segnali più o meno percettibili nelle scorse edizioni, ma con grande ironia della sorte proprio uno dei direttori artistici più retrivi e sorpassati della storia del festival, almeno a giudicare da certe dichiarazioni alla stampa e dalle scenette architettate con Fiorello (scenette che nella scrittura Macario al confronto era Samuel Beckett: l’invecchiamento artistico di Fiorello è un fenomeno veramente impressionante), dicevamo, proprio Amadeus – l’uomo che usa Instagram con un profilo di coppia per dire quanto è buongiornissimo kaffèèèè – ha introdotto i barbari nel cuore dell’Impero Romano. Anzi, li ha fortemente voluti. E ha fatto così saltare tutto per aria, diventando più bombarolo di chi da decenni faceva la guerriglia al mainstream. Triggerando così la scena indipendente. Che ora non sa bene come prenderla. Non sa bene come comportarsi.
Un tempo infatti potevi arrivare dall’underground, dalla scena vera, e se cooptato in gara sanremesca attraversare il weekend in souplesse dicendo «sono qui, ma non c’entro, sono qui solo per vedere l’effetto che fa», dando di gomito ai (pochi) giornalisti storicamente amici e guardando con affettuoso sussiego i (molti) giornalisti e faccendieri da Sanremo, chiaramente gentuccia irrecuperabile. Questo se eri artista. Se invece eri pubblico da casa, potevi spalleggiare i gruppi/artisti che hai in simpatia in questa lunare scampagnata sentendoti ancora più affratellato a loro, in questo momento difficile, mentre quelli che avevi in antipatia beh, e che caspita!, con grande piacere potevi antipatizzarli ancora di più. Tanto poi finite le danze Sanremo scompariva, con una trascurabile coda semi-lunga nelle programmazioni radiofoniche, e si tornava al dualismo standard, in cui è chiaro chi è di qua e chi è di là. Ma ora è finita la festa. È finita la chiarezza.
In realtà già doveva essere chiaro nel momento in cui Diodato – artista sopra ogni sospetto in quanto a militanza nella musica vera, come conferma il ruolo di direttore artistico nell’anti Primo Maggio di Taranto – vinceva il festival con una canzone che più sanremese non si può (canzone peraltro bellissima). Cortocircuito pazzesco, non a caso forse insabbiato dai duri-e-puri. Ma ok, ci sta che non sempre le cose si colgono al primo segnale, o venga permesso di coglierle. Ora però più che segnali e campanelli d’allarme c’è proprio una fabbrica di riflettori e campanili: non ci si può nascondere più.
Willie Peyote faceva le jam polverose fra b-boy e vinceva le gare di freestyle. Davide Shorty, altrettanto inserito nella scena rap più autentica da tempi non sospetti. Coma_Cose? Fausto Lama era uno dei Gleastilisti, sottobosco hip hop, e comunque la fama che si è costruito con Francesca nasce da raffinati meccanismi estetici hipster, non dalla dozzinalità dei cantanti buoni per radio o televisioni. Colapesce e Dimartino? Cosa di più autenticamente indipendente di loro, mai avuto a che fare con le major, almeno pubblicamente. Se poi scartabelliamo fra autori e produttori e riusciamo a farci largo tra le mille canzoni scritte e co-firmate da Dardust (peraltro, ve lo ricordate quando era negli Elettrodust che sgomitava per farsi notare in concorsi come Rock Targato Italia?) troviamo un Tommaso Colliva (area Calibro 35, qualità doc) o un Alessandro Raina che oggi scrive canzoni per Fedez e la Michielin, sì, mentre ieri era convocato come cantante dagli aedi del post rock mogwaiano Giardini Di Mirò e fondava gli Amor Fou, un gruppo che dovevi essere un lettore di Rockit o un fan della prima ora del MiAmi per trovarlo rilevante.
La scena musicale italiana, e per scena consideriamo collettivamente artisti, addetti ai lavori, giornalisti e pubblico, negli anni ’90 e nei primi 2000 ha fatto un eccezionale lavoro di svecchiamento e di rinnovamento: (ri)connettersi con quello che succedeva nel mondo anglosassone e americano, dopo la dittatura del cantautorato; far esplodere il fenomeno della musica dal vivo alternativa, creando ex novo circuiti live prima inesistenti; generare un sano orgoglio di appartenenza in chi non accettava la pappa pronta delle radio, delle televisioni e dei quotidiani. Per tutto questo, sempre sia lodata. Tanta roba, davvero. C’è sempre però l’altra faccia della medaglia: ha generato e anzi incoraggiato una radicatissima divisione manichea, che all’inizio era sì sana e necessaria, ma via via è diventata una rendita di comodo sia per l’underground (che non veniva mai sfidato a crescere davvero, dato che in superficie c’erano solo il Male, l’Inautenticità e la Corruzione, confrontandosi così con la difficoltà e la complessità dell’età adulta) che per il mainstream e le major, che potevano continuare a farsi i comodi loro e a decidere a tavolino cosa doveva funzionare e cosa no, tanto nessuno voleva insidiare le loro posizioni accanto alla leve del potere. Tutti contenti: da un lato noialtri del rock, o dell’indie, o del rap old school, o della techno, a dire quanto il mainstream fosse una merda commerciale; dall’altro la merda commerciale, a tentare di spremere fatturato da qualsiasi cosa senza nessuno che avesse il coraggio di dire «eh ma forse così anche no… forse a furia di abbassare l’asticella vi state e ci stiamo incagliando nel guano».
La benedizione – ciò che ha cambiato il corso delle cose – non è stata l’onda d’urto della scena alternativa, della musica vera, bensì i conti in rosso delle major. Che ad un certo punto si sono accorte che lo loro ricette apparentemente ben rivolte a massimizzare i profitti in realtà massimizzavano gran poco, visto che si inanellavano trimestrali e annuali sempre più funeree e catastrofiche. A un certo punto, forse per disperazione, forse per convinzione hanno iniziato a cooptare nei loro organici e nei loro think tank autoriali e strategici una nuovissima generazione di scena: non quella degli anni ’90, che così tanto voleva cambiare il mondo da detestare le major e da non volerci parlare pubblicamente, ma quella successiva, o almeno a una mefistofelica e sgamata parte di essa, a cui semplicemente non gliene fregava un cazzo di niente delle vecchie lotte di bandiera e che pur di fatturare e pagarsi le bollette non aveva problemi a farsi cooptare. Provava certo simpatia più per il MiAmi che per il Pulcino Pio o il reggaeton preconfezionato donato a Baby K o alle cassiere dell’Esselunga, chiaro; ma fondamentalmente, aveva e ha un approccio molto laico nei confronti della musica e delle dinamiche che essa è in grado di ricreare.
Pure a questa scena nuova, anzi, nuovissima era ed è tuttavia rimasto un po’ di complesso di superiorità. Siamo nuovi. Siamo diversi dai catafalchi del pop. Siamo ganzi perché combiniamo la trap col trash, l’indie col rap. Siamo, siamo, siamo. Ok. Bravi. Applausi.
Ora però si complicano le cose. Ora infatti state (… stiamo) anche per diventare quello che mai realmente avreste (… avremmo) pensato di diventare: l’establishment. Oh sì. Ora, i Grandi Manovratori siete diventati voi (… siamo diventati noi). Ora, quelli accusati di manovrare cinicamente la massa bue siete diventati voi (… siamo diventati noi). Ora, quelli con la responsabilità di dar da mangiare ai vostri collaboratori siete diventati voi (… siamo diventati noi), lì dove prima invece erano solo favori tra amici, e c’è una differenza. Nel 2021, questa è la novità, non ci sono più Al Bano e Romina, ma al loro posto ci sono Fausto Lama e Francesca California: il compito adesso è dimostrare di essere all’altezza di questa responsabilità e di questo ruolo, accettando di sporcarsi le mani e di lavorare da un lato con onestà, dall’altro senza più cazzeggiare. E prendendosi pure gli insulti di chi ha il lusso, beato lui, di non doversi mettere in gioco mai, in nessun modo, vedendosi perfetto e puro così com’è.
Fa paura, questa cosa. E lo si capisce da come molti addetti ai lavori ma anche molto del pubblico di appassionati di musica vera si siano risentiti, e parecchio, per il testo di Mai dire mai di Willie Peyote: ancorati a uno schema vecchio e parecchio di comodo, l’hanno infatti catalogata come una Quelli che benpensano 2.0: ovvero una nuova versione di un elenco di cattivi, corrotti, falsi e ipocriti da mettere alla gogna, sentendosene migliori, con la differenza che Frankie hi-nrg poteva permetterselo, Willie Peyote insomma. Il rapper-it-popparo sabaudo ha fatto invece una cosa molto diversa, molto più sofisticata e più dolorosa: ha fatto proprio capire come tutti quanti ora nella scena si è in quella merda lì, in questo calderone, in questo Sanremo collettivo. Apre la traccia prendendosela coi rapper con la band (e lui cosa fa?); prosegue insolentendo gli artisti che si svendono ai brand (sui suoi social trovate il ringraziamento a Pignatelli per gli outfit di gara); si lamenta della passione del popolo bue per il calcio (lui sfegatato del Toro, che ai calciatori dedica pure le canzoni, vedi Glik). Fa poi una cosa molto importante, con una sottigliezza nel ritornello sfuggita a molti: gioca sul fatto che oggi si può essere “schiavi dell’hype” sia da “giovani affamati” che da “giovani affermati”. Sì, le vecchie divisioni sono venute a cadere. Questo è il punto. Vecchi automatismi interpretativi e di schieramento non servono più a granché.
Arriveranno prima o poi dei nuovi anni ’90 a riportare la guerriglia, a riportare la controcultura, l’alternativa vera, la contrapposizione – e intendiamo, a riportarle non solo in nicchie stagne e microscopiche ma proprio nel dibattito collettivo. Ok. Ora però stiamo vivendo una stagione molto diversa. Molto, molto diversa. Prima lo capiamo, e smettiamo di ululare alla luna in cerca di una supposta purezza (superata dagli eventi lo si voglia o meno), più riusciamo a godercela, più riusciamo a darle un senso. E la prossima volta, che ne dite, evitiamo magari di aspettare di farci spiegare tutto questo da Amadeus. No? Perché è questa la cosa grave. Farsi spiegare le cose da Amadeus. Mentre noi, noi della scena vera, noi che vediamo la differenza tra Sfera e i Sonic Youth, tra i Led Zeppelin e i Måneskin, siamo troppo occupati e litigare fra noi e a farci le pulci a vicenda.