Domanda: perché la musica degli Yes è così unica e incredibile? Risposta: perché non c’è un altro gruppo che abbia saputo unire in maniera tanto perfetta una serie di particolarità. Anzitutto gli Yes sanno suonare, e anche molto bene. Ognuno è un asso al suo strumento, ma tale abilità non è mai fine a se stessa ma è messa sempre a disposizione delle canzoni. Già le canzoni, quelle degli Yes possono durare dai 3 ai 30 minuti, ma sono sempre alte opere di ingegno. Qualcuno ha detto che gli Yes suonano parti soliste che incastrate tra di loro creano i brani. Ogni pezzo degli Yes è infatti un mondo in continua trasformazione, un po’ come osservare un microcosmo nel quale gli elementi danzano una danza tutta loro, inafferrabile per l’occhio umano e apparentemente caotica, ma in realtà perfetta.
Un esempio per tutti: la sezione iniziale della suite per eccellenza, Close to the Edge. Qualcuno riesce a capire cosa diavolo stiano suonando, chi stia facendo cosa? È un delirio che a ben ascoltare si rivela un puzzle nel quale a un certo punto, come per magia, tutti i pezzi combaciano. E lì, in uno squarcio di luce intensa, esce allo scoperto un tema melodico immortale. Vogliamo paragonare l’ardire di composizioni del genere alle più importanti pagine classiche di Bach, Beethoven o Mozart? Facciamolo! Se non lo facciamo oggi ci penserà qualcuno domani, perché questa è la vera musica classica del futuro ed è classica proprio perché rimarrà per sempre.
Soffermiamoci ora sull’operato dei singoli musicisti, prendiamo quelli dell’âge d’or (nel tempo cambieranno un miliardo di volte, ma tanto tutti tornano sempre all’ovile). Chris Squire: colonna portante, un basso che è esso stesso lo Yes-sound. Lo strumento in evidenza come non mai, forte, possente, a muoversi su mille note che mutano costantemente l’armonia. E poi che abilità ai cori. Steve Howe: uno che con gli strumenti a corda spazia dal rock, al flamenco passando per il jazz, il ragtime, il funk, il blues, la classica e mille altri stili. Rick Wakeman: eccessivo da tutti i punti di vista, gli dai una tastiera, te la percorre a velocità folle grazie alle sue dita extraterrestri e in mezzo ci piazza la melodia vincente (extra Yes: vogliamo ricordarlo in Life on Mars?). Bill Bruford: saetta batteristica che Robert Fripp a un certo punto vuole nei King Crimson, e ho detto tutto. Infine Jon Anderson: la voce fatata del prog per eccellenza. Uomo dalle ampie visioni che col suo timbro e i suoi testi-non-testi ha fatto sognare più generazioni facendosi portavoce di un messaggio di fratellanza tra l’uomo e la realtà che lo circonda. Un mistico che ti prende per mano e ti rivela cosa sia la bellezza.
C’è abbastanza materiale per la creazione di una super-musica, che va oltre ogni istanza terrena e che trasmette all’ascoltatore un senso di grandezza smisurata. La musica degli Yes è da sempre ritenuta eccessiva, solenne, strabordante, pomposa e blablabla. Tutte cose che più le senti e più li ami. Oppure li odi, ma questi sono problemi tuoi.
Eppoi nei loro molti decenni di carriera i nostri hanno dimostrato di sapere spaziare, e bene. Cè chi li conosce solo per Owner of a Lonely Heart, uno dei riff per eccellenza del rock. E sono gli stessi che solo poco tempo prima componevano Sound Chaser. Questo essere così polimorfi e in grado di azzeccare sempre il pezzo, che sia prog o pop, è un altro fattore che li rende quello che sono. O che sono stati.
Purtroppo da un po’ di anni a questa parte la spinta vitale sembra persa, un po’ l’età, un po’ i continui cambi di formazione, un po’ che sono diventati la cover band di se stessi (è rimasto solo Steve Howe dei vecchi Yes, che non è nemmeno un membro fondatore), un po’ ‘sto girare il mondo rifacendo i vecchi album e non sapendo più tirare fuori nulla che faccia drizzare le orecchie… Si capisce, hanno dato tanto ed è già molto che ancora ci siano. Ma gli Yes ci hanno abituati e essere sempre un passo avanti, sempre più grandi.
In attesa di nuove sorprese gustiamoci quindi i loro 21 album in studio messi in ordine, da quello proprio NO, a quello assolutamente YES.
21“Heaven & Earth” (2014)

Jon Davidson è bravo e simpatico, ma sentirlo fare il verso all’altro Jon è veramente malinconico. Come se si potesse prendere una voce e clonarla. E l’anima? Anderson è Anderson, punto, allora sarebbe stato meglio prendere qualcuno completamente diverso. Ma si sa, quel tipo di timbro è diventato un marchio di fabbrica, indissolubilmente legato alla Yes-music. Detto ciò il disco è pieno di canzoni brutte ed è l’ultimo con Chris Squire che lascerà questo pianeta nel 2015. Mette tristezza da tanti punti di vista.
20“Fly from Here” (2011)

Con un altro Anderson-clone, il canadese Benoît David, perfetto anche lui nella parte ma con lo stesso problema di cui sopra. Fly from Here contiene canzoni in larga parte scritte nel periodo di Drama e mai pubblicate. Evidentemente degli scarti. L’album tenta la carta della lunga suite (il brano omonimo) ma non ci siamo proprio, oltre a essere spesso un po’ loffio ritmicamente (Alan White comincia a non farcela più) il songwriting è la pallida ombra di quello lucente di una volta.
19“Open Your Eyes” (1997)

Un disco che non doveva nemmeno essere targato Yes in quanto idea per un Chris Squire Experiment. Poi gli altri ascoltano, ci prendono gusto e il progetto vira Yes. Nel frattempo Rick Wakeman ha abbandonato per la millesima volta. Al suo posto Billy Sherwood, che più avanti sostituirà anche il defunto bassista. Il disco insegue un afflato AOR che in 90125 era una cosa, ma qui si rivela solo piacevole, quando va bene.
18“Yes” (1969)
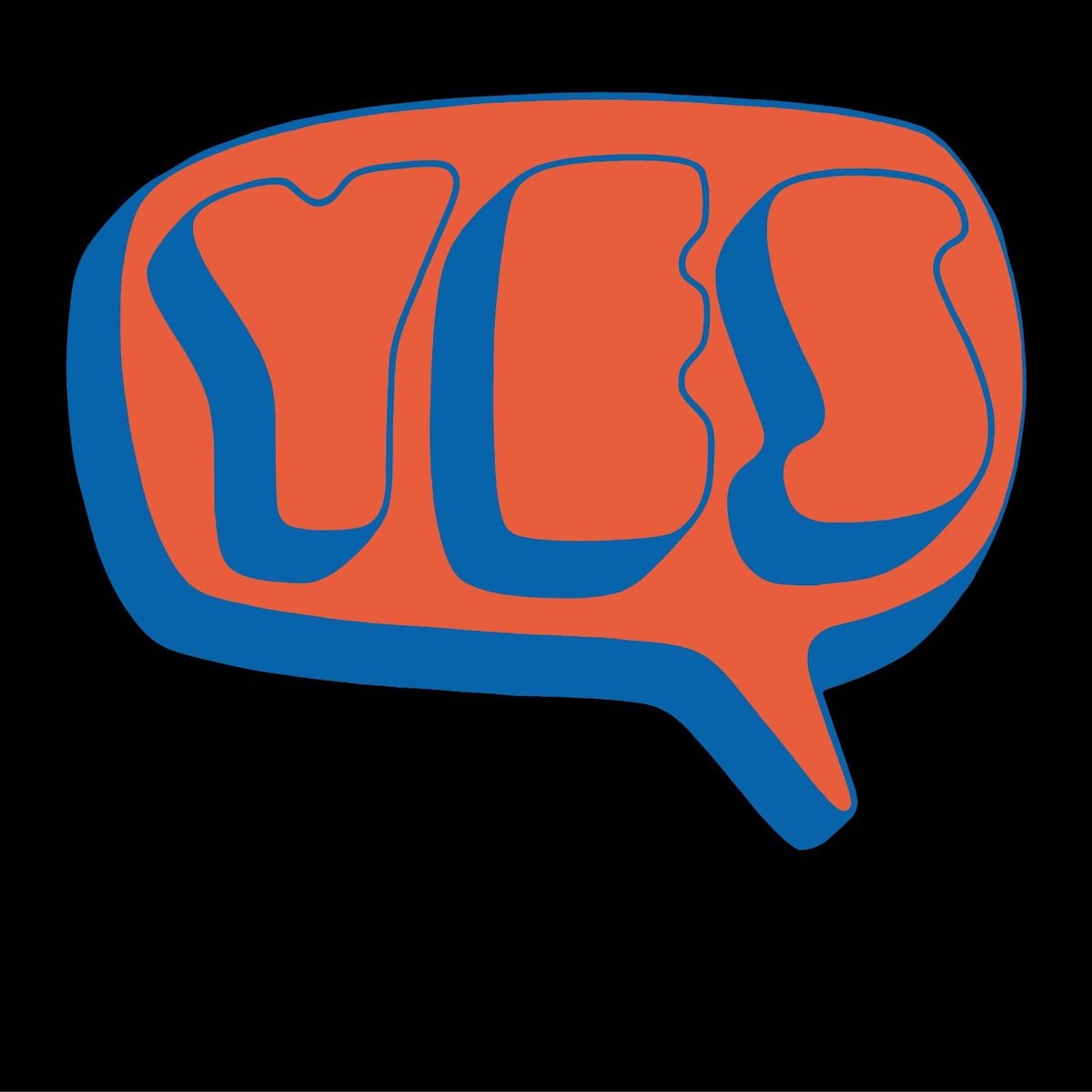
Il primo album, gli Yes ancora parecchio indecisi sulla strada da percorrere. Acerbi ma già dotati della giusta irruenza ai loro strumenti, con Bill Bruford che sposa i suoi amori jazz a un tessuto pop-psych, Squire che col suo bassone rende già il suono originale e Anderson che una voce come la sua non si era mai sentita. In questa fase gli Yes danno il meglio nelle cover, che stravolgono a modo loro: pezzi dei Beatles e dei Byrds. Ma la grazie melodica è già dietro l’angolo, come nella delicata Sweetness.
17“Keys to Ascension” (1996) + “Keys to Ascension 2” (1997)

Strana coppia di doppi album ibridi con eccellenti sezioni live e una manciata di inediti, due nel primo, cinque nel secondo. Quasi tutti brani di lunga durata eseguiti dalla formazione Anderson, Howe, Squire, Wakeman, White. Ci sono tutte le prerogative affinché esca fuori qualcosa di ottimo. In realtà però non sono molti i pezzi che lasciano il segno, le suite Mind Drive e That, That Is hanno bei momenti ma il resto, pur con tutti gli ingredienti al posto giusto, si trascina stancamente nel ricordo sfocato di ciò che gli Yes furono.
16“Talk” (1994)

Pubblicato in piena epoca grunge, quando una band come gli Yes rappresentava tutto quello che non si voleva ascoltare, Talk rimette in pista la formazione di 90125 dopo l’esperimento a otto di Union. Inutile dire che al best seller dell’83 non allaccia nemmeno le scarpe, ma non tutto è da buttare, il prog-AOR di marca Rabin sa rendersi piacevole e poi alla fine arriva Endless Dream che sono realmente 14 minuti di sogno, una boccata d’aria fresca colma di grandi melodie e intense parti strumentali che riportano finalmente alla luce i migliori Yes.
15“Union” (1991)

La super pazzia di una super band: mettere insieme componenti vecchi e nuovi, che fino a poco prima si odiavano, e farli suonare nello stesso disco. Solo agli Yes poteva venire in mente una cosa del genere. In otto, con due batteristi, due tastieristi e due chitarristi, sfornano un album maltrattato dai più che però ha ottimi momenti. Nulla a che fare con gli affreschi del passato ma buon Yes-rock con le punte di diamante di I Would Have Waited Forever, Lift Me Up e Shock to the System. Certo, c’è anche un po’ di pattume, ma in generale si fa ascoltare bene.
14“Time and a Word” (1970)

Nel 1970 siamo ancora distanti dalla maturità, dal prendere possesso del proprio suono e portarlo avanti. Nonostante ciò ci sono meno incertezze rispetto al primo album, si tira dentro un’orchestra e le canzoni mediamente catturano: Then, Sweet Dreams, Time and a Word. Ed è ancora sulle cover che i nostri danno il meglio: No Opportunity Necessary, No Experience Needed di Richie Havens ed Everydays di Stephen Stills fanno fare un gran balzo sulla sedia. Se gli Yes sapranno fare con i pezzi loro ciò che fanno su quelli altrui non li fermerà più nessuno. E infatti.
13“The Ladder” (1999)

La band si sta rompendo le scatole di inseguire in tutti i modi il successo di Owner of a Lonely Heart e si ricorda di essere nata con ben altre prerogative. Gli anni ’80 sono finiti e anche il grunge è alle spalle. Con la fine dei ’90 si ricomincia a pensare che fare prog non sia una bestemmia. E così, belli ringalluzziti e con una nuova splendida copertina firmata Roger Dean, gli Yes tirano fuori il loro album più old fashioned dai tempi di Drama (escludendo l’esperimento Anderson Bruford Wakeman Howe). Non è ancora tutto perfetto ma l’iniziale Homeworld (The Ladder) spezzerà diversi cuori.
12“Magnification” (2001)

Il disco che pacifica definitivamente gli Yes e i loro fan. Dopo anni di prove incerte infatti la band sembra tornare ai fasti del passato con un album realizzato con una grande orchestra, esperimento già tentato all’epoca di Time and a Word, ma che qui assume un significato completamente diverso. Tanto incerto era allora il futuro degli Yes quanto ora è luminoso. I 10 e passa minuti di In the Presence of sono ciò che almeno dal 1976 tutti gli Yes-fan aspettano.
11“Big Generator” (1987)

Il dopo 90125. Tornati in auge freschi e perfetti per la generazione ’80, i nostri ci riprovano con un disco purtroppo (per loro) orfano di una nuova Owner of a Lonely Heart. Nonostante ciò Big Generator si lascia ben ricordare: Final Eyes, I’m Running e Shoot High Aim Low sono grandi momenti prog-AOR, e anche le semplici canzoni sono briose e accattivanti: ascoltare Rhythm of Love e Love Will Find a Way per credere. Certo, non è Close to the Edge, ma dimostra quanto i nostri siano bravi a reinventarsi.
10“Tormato” (1978)

Il segno dei tempi, un momento, quello del dopo-esplosione punk e ascesa della new wave, nel quale gli Yes appaiono decisamente fuori posto. Anzi, insieme a ELP, i più fuori posto di tutti. Ma sono ancora giovani e pieni di voglia di mettersi in gioco. I suoni perdono così qualche pomposità, si fanno più attuali e la band si getta in quello che nei propositi dovrebbe essere il loro disco moderno. Non funzionerà, gli Yes sono ancora troppo Yes per spogliarsi degli abiti che hanno indossato per anni. Nonostante tutto in Tormato ci sono momenti altissimi, uno per tutti la straordinaria On the Silent Wings of Freedom. Ascoltare quello che fa Chris Squire in questo pezzo vuol dire andare fuori di testa.
9“90125” (1983)

1983, il prog degli Yes non è superato, di più. È roba che nessuno vuole più ascoltare, pena l’essere radiati dalla discografia che conta. Che fare quindi? Ci pensa il chitarrista sudafricano Trevor Rabin a tirarli fuori dalle sabbie mobili. Nel frattempo Steve Howe se ne è andato per formare il supergruppo Asia e Jon Anderson è tornato all’ovile, dopo l’assenza di Drama. Il nuovo progetto è quello di traslare la Yes-music verso atmosfere tinte di AOR che però non dimentichino i vecchi fasti, solo li modernizzino. Funzionerà alla grande, 90125 è caposaldo di un nuovo sound che incredibilmente sarà apprezzato da tutti, vecchi e nuovi fan. Se poi è il successo che i nostri cercano qui ce ne sarà a iosa, basta un titolo: Owner of a Lonely Heart.
8“Anderson Bruford Wakeman Howe” (1989)

Questo non è un disco degli Yes, ma a tutti gli effetti lo è. In un continuo afferrare e perdere il successo la band si trova a fine anni ’80 nel pieno della crisi. Il progetto Big Generator non ha ottenuto il riscontro sperato, che fare? Insistere a cercare di sfornare una nuova hit o tornare sui propri passi, quelli fatti di brani lunghi e immaginifici? Anderson non ha dubbi. Tira dentro i vecchi Bruford, Wakeman e Howe, lascia da parte Squire che invece è tutto sull’altro versante, e insieme danno vita all’anima più prog degli Yes. Anderson Bruford Wakeman Howe è una vera boccata d’aria fresca, con pezzi dai suoni un po’ datati (paradossalmente parecchie produzioni anni ’80 paiono oggi assai più vecchie di quelle dei ’70), ma nuovamente dotati di gran gusto melodico e voglia di essere prog senza tante menate. Un singolo da 10 minuti, Brother of Mine, farà da apripista, questo già dice tutto.
7“Drama” (1980)

Dopo l’insuccesso di Tormato gli Yes sono a un passo dallo scioglimento. Rick Wakeman abbandona di nuovo e lo stesso fa Jon Anderson. Un duro colpo, specie la perdita del cantante che fino a quel momento è stato colonna portante dello Yes-sound. Howe, Squire e White però non si perdono d’animo e tirano dentro addirittura Trevor Horn e Geoff Downes, i due Buggles che hanno appena ottenuto uno straordinario successo con Video Killed the Radio Star. Con questi danno vita a un album assai particolare che non avrà la fortuna sperata ma si farà portavoce della svolta che i nostri sognavano di attuare con Tormato. Drama è un disco bellissimo nel quale trovano spazio momenti epici legati al passato come Machine Messiah e freschi esperimenti prog-wave come Into the Lens o Tempus Fugit. Fighissimo poi il singolo Does It Really Happen?, con i cori di Squire e Horn che per una volta non fanno rimpiangere l’assenza di Jon Anderson.
6“The Yes Album” (1971)

Con Yes Album finalmente il gruppo trova la sua strada. Fuori Peter Banks (chitarrista, tra i fondatori del gruppo, colui che tirerà fuori il nome Yes) e strada aperta per l’eclettico Steve Howe che suona qualsiasi cosa sia dotata di corde. Al contrario dell’immediato futuro qui il suono Yes è quasi minimale, con solo quello che serve, senza esagerazioni di sorta. Il basso onnipresente di Chris Squire corre tra le note in composizioni che dopo le incertezze dei primi due album, segneranno per sempre la storia della band: Yours Is No Disgrace, Starship Trooper, I’ve Seen All good People, Perpetual Change. Bastano i titoli.
5“Relayer” (1974)

Una delle cose più sorprendenti partorite dagli Yes che dopo il successo planetario di Fragile e Close to the Edge se ne guardano bene dal ripetersi e prima tirano fuori il controverso Tales from Topographic Oceans e poi questo Relayer che a tutti gli effetti può essere considerato il loro disco più sperimentale. Così fuori dai canoni che Rick Wakeman abbandona sostituito dallo svizzero Patrick Moraz. Le classiche suite qui si vestono di clangori quasi industrial, accenni jazz più o meno free, costruzioni ritmiche impossibili. Tre soli brani. Sul lato A The Gates of Delirium mette insieme follia e sinfonismo e si chiude con uno dei momenti più intensi degli Yes, la sezione chiamata Soon. Sul lato B si delira di brutto con Sound Chaser, forse il punto più estremo dei nostri, e poi torna la luce in To Be Over, un navigare beatamente nel mare della fantasia spinta oltre ogni limite.
4“Going for the One” (1977)

Superate le sperimentazioni di Relayer, Wakeman torna all’ovile. Sono degli Yes più pacificati con se stessi quelli che si apprestano a dare alle stampe Going for the One, un album decisamente più sereno, dai tratti quasi new wage (complice la vena sempre più mistica di un Jon Anderson da sempre vegetariano e salutista convinto). Le composizioni qui esplorano una vena più pop rispetto al passato, c’è voglia di ritrovare un successo che infatti non tarderà. Going for the One è dotato di un perfetto equilibrio che include tre “semplici” canzoni, Going for the One, Parallels e Wonderous Stories, una sontuosa sonata acustico-orchestrale, Turn of the Century, e infine la meraviglia: Awaken, 16 minuti da favola nel quali i nostri innalzano la loro musica verso vette che definire divine non è esagerato. Non si può dire altro, bisogna solo ascoltare.
3“Fragile” (1971)

La maturità definitivamente raggiunta, la conquista di un suono che da questo momento farà scuola, l’ingresso del mago dei tasti d’avorio Rick Wakeman (al posto del dimissionario Tony Kaye), l’assalto alle classifiche con una Roundabout che spalancherà agli Yes le porte del successo mondiale, pur con una musica tutt’altro che commerciale. Tutto questo è Fragile, l’album che segna anche l’inizio del sodalizio con Roger Dean, che da questo momento contribuirà a visualizzare il sogno targato Yes in copertine sempre più colorate e surreali. Fragile è un po’ l’Ummagumma degli Yes, con cinque brani solisti e una serie di prove in gruppo. I brani in solo confermano quanto gli Yes siano cinque belle teste pensanti, ognuno col proprio strumento. Ma è quando le varie creatività vengono unite che si raggiunge l’apoteosi. La già citata Roundabout, punto d’incontro tra sperimentazione e comunicatività, Long Distance Runaround, una delle più tipiche Yes-song, e poi Heart of the Sunrise, tra i massimi capolavori della band: schizoide e mellotronica, melodica e possente, quieta e devastante. In questi 10 minuti c’è tutto quello che si può chiedere alla musica.
2“Tales from Topographic Oceans” (1973)

Forse il disco più odiato della storia del rock, quello che ha agevolato la nascita del punk, movimento che sorge anche per ricacciare dischi del genere nella cloaca. Anche tra gli stessi fan accaniti degli Yes c’è chi lo disprezza ferocemente e chi lo ama di un amore incondizionato. Io appartengo alla seconda categoria, le quattro suite contenute in Tales sono per me una delle più alte manifestazioni dell’arte prog, nonché una delle vette del rock in toto. Ispirato dagli scritti del mistico indiano Paramahansa Yogananda, il sesto album degli Yes è un concentrato di tutto il meglio (o il peggio, dipende da chi giudica) del progressive: magniloquente, pomposo, eccessivo, colmo di sinfonismo, aperture siderali, cambi di tempo, panorami di bellezza incontaminata a base di chitarre acustiche e mellotron, invocazioni di antichi dei, rituali che si perdono nella notte dei tempi, corse mozzafiato tra panorami ora paradisiaci, ora infernali, testi che sono puro suono, con parole che danzano libere insieme alla musica in un turbinio senza fine. Tales from Topographic Oceans non è un semplice album, è un’esperienza per la quale ci vuole una certa predisposizione: quella che consente di abbandonarsi all’aura spirituale che emana, a quell’afflato di unione cosmica, con tutti gli elementi dell’universo che diventano musica. La musica di questo disco.
1“Close to the Edge” (1972)
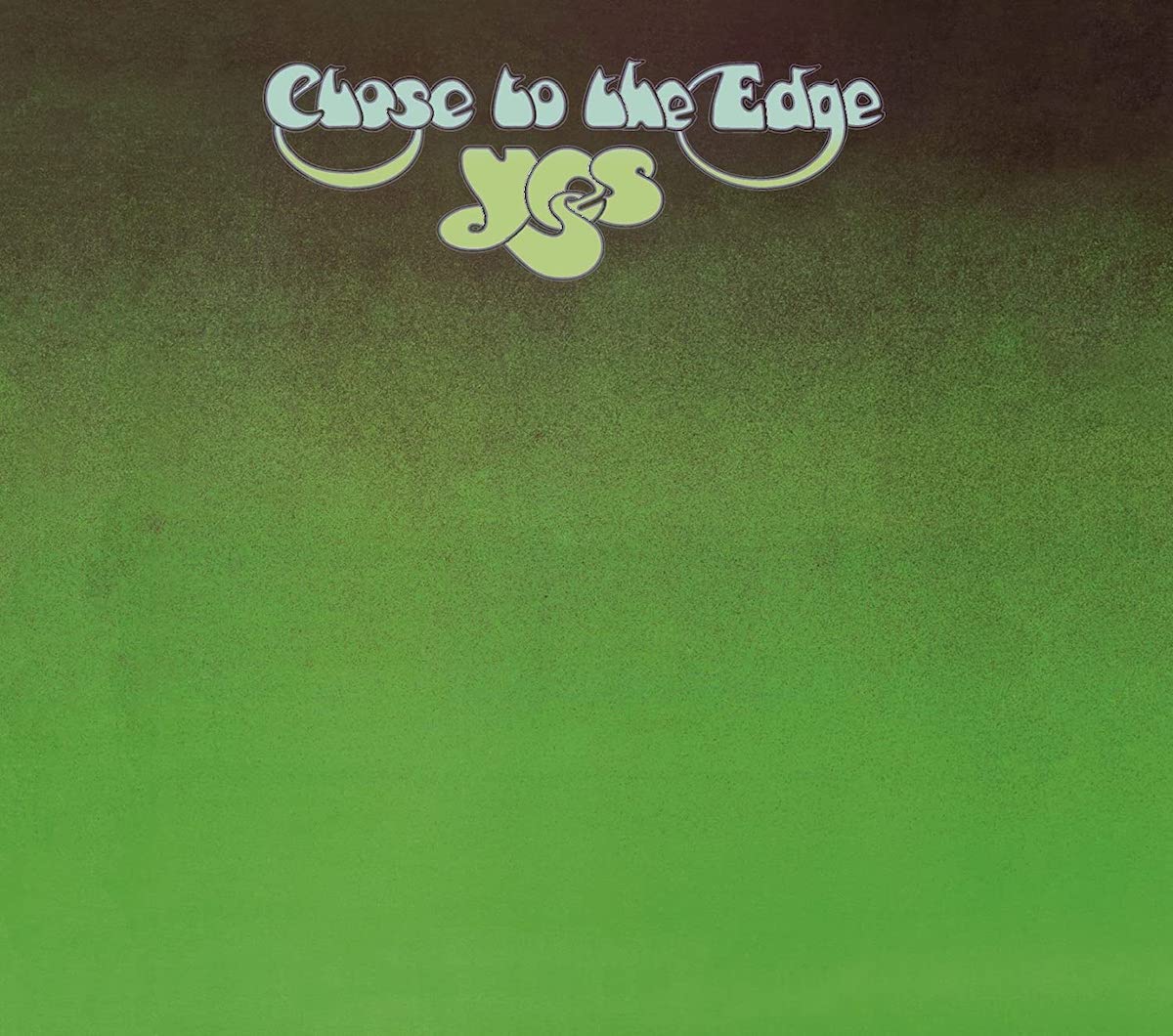
Dopo il florilegio di parole spese per Tales come si può andare oltre? Come si può definire Close to the Edge? Che sia uno dei più grandi album di tutti i tempi è fuori da ogni dubbio. Che la suite omonima sia un concentrato di ritmo infuocato, melodia fuori da ogni schema e virtuosismo creativo è scontato. Che questa esaltante pagina della storia del rock sia qualcosa che va oltre ogni definizione è banale ricordarlo, no? E i brani del secondo lato? L’apoteosi per chitarre acustiche e orchestra gigantesca di tastiere di And You and I? Jon Anderson qui non sembra un angelo circondato da smisurate architetture concepite da esseri venuti da altri mondi? E Siberian Khatru? Così agile e tagliente che lancia l’immaginazione verso l’alto… Non pare di visualizzare enormi lande ghiacciate in qualche pianeta sconosciuto? Tutto in questo disco è immane, sproporzionato, ultraterreno. Non si capisce ancora bene come sia potuta nascere una musica del genere, che sembra scaturire dal ventre più antico della Terra, dall’immensità degli spazi, dagli abissi più profondi degli oceani. Potrei continuare all’infinito con i paroloni e non ce ne sarebbero mai abbastanza.














