Il romanzo d’esordio di Mat Osman, bassista e fondatore dei Suede, non è quello che vi aspettate. Rovine, pubblicato in Italia da Edizioni Atlantide e tradotto da Mirko Zilahy, è un noir psichedelico e surreale che parla di musica, sì, ma soprattutto d’identità. La storia è ambientata a Londra nel 2010, quando l’eruzione del vulcano islandese Eyjafjöll ha bloccato mezza Europa con la sua nube di cenere. Il protagonista è Adam Kussgarten, un londinese introverso e bizzarro – ha ricostruito una città in miniatura nel suo appartamento – che scopre da una strana telefonata che il fratello, rockstar minore della scena inglese, è stato assassinato. La notizia trascina Adam nel mezzo di una vicenda assurda e pericolosa, un viaggio che lo porterà nell’underground londinese «alla ricerca di preziosissimi nastri musicali, risposte alla morte del fratello e, forse, del suo stesso destino». Potete leggere un estratto qui sotto, in anteprima esclusiva sul sito di Rolling Stone.
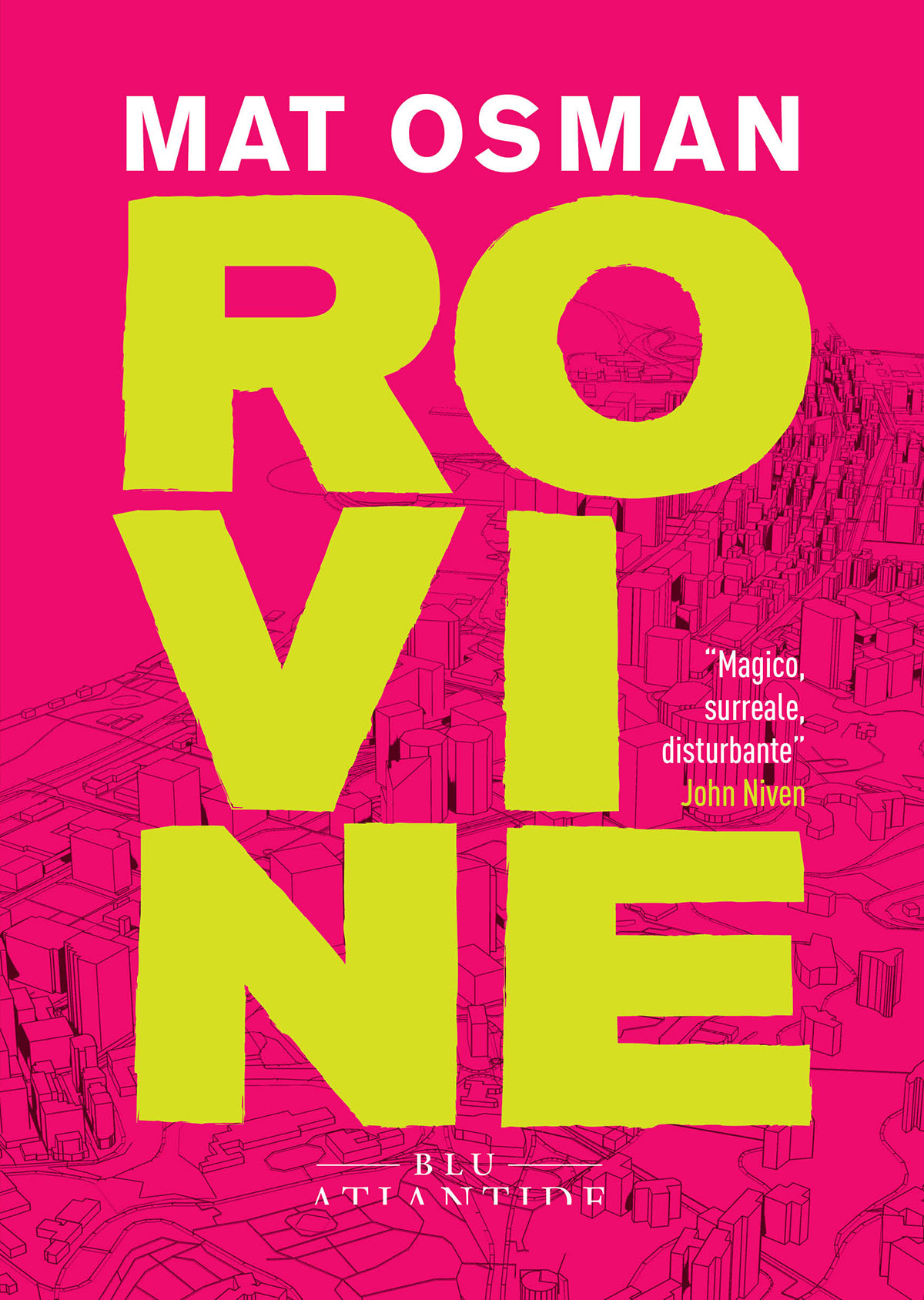
Are We Going to be Alright?
La clip su YouTube era un filmato di quattro minuti della neve che cadeva, mentre il brano che avevamo ascoltato le faceva da colonna sonora. Sotto c’era una lunga serie di commenti, tutti dello stesso utente che si firmava Kissing Garden: il superamento del limite di caratteri di YouTube significava che si era dovuto rispondere da solo per farci entrare tutto ciò che aveva scritto.
Kissing Garden – 15 giorni fa
È passato almeno un minuto dal suono del campanello – in bakelite turchese, una vivace La Cucaracha come jingle – al momento in cui Hyde è venuto fisicamente ad aprire la porta. L’appartamento era buio, l’uomo una sagoma scheletrica stagliata contro l’oscurità. Quando i Remote/Control erano in tour con loro, mi sovrastava; ora, nonostante la cresta instabile di un ciuffo alto circa venti centimetri, era più basso di me, forse di un centimetro appena. Si appoggiava vistosamente a un bastone.
«Posso aiutarti, figliolo?».
Quella voce. Accento mieloso del Sud. Quand’era registrata, aveva il tono stentoreo di un predicatore, e vaticinava l’imminente dannazione per tutti, di persona però aveva un suono rassicurante. L’atteggiamento era quello impassibile con cui i piloti spiegano che un motore dell’aereo è fuori uso.
Allungai una mano. «Sono Brandon, Brandon Kussgarten. Negli anni Novanta siamo stati in tour insieme. Ricordi i Remote/Control?».
Il paesaggio rovinato che aveva al posto del viso emerse dal buio, esaminò la mia mano, poi guardò me. Il ciuffo si sporse in avanti.
«Il tuo amichetto collezionista di dischi non è venuto con te, figliolo?». Disse “collezionista di dischi” con il tono di voce con cui chiunque altro avrebbe potuto dire pedofilo.
«No, non c’è, signore». Mi scappò il “signore”.
Guardò a destra e a sinistra lungo la passerella del palazzo.
«Be’, allora faresti meglio a portare dentro il tuo culo bianco e magro».
Dall’esterno ricordava uno di quegli edifici anni Settanta – il tipo di costruzione tipica delle grandi città, realizzata in fretta e furia con bassa manovalanza – ma nell’appartamento lo stile era rigorosamente americano, anni Cinquanta. Tende di velluto rosso e lampade soffuse che proiettavano coni di luce in ogni angolo. C’erano tappeti spessi di colore oro e scarlatto, un mobiletto per gli alcolici con la parte anteriore incisa, che conteneva bicchieri per cocktail che oggi non ci sono più: Highball, Rob Roy, Egg Flip.
Mentre gli occhi si abituavano alla penombra, mi addentrai nella stanza. Il camino era troppo grande per quell’ambiente, e rivestito con della finta pietra, non sarei rimasto sorpreso se ci avessi visto appoggiato Dean Martin con un Martini in mano. Sopra la spalla di Hyde vedevo il luccichio del cucinino. Il bollitore era color avocado, il mixer color mousse di salmone. Il frigorifero era turchese, un po’ chiaro un po’ opaco, e le ante degli sportelli avevano un bordo che pareva in una fantasia tartan sbiadita. Non se ne traeva un’impressione kitsch, ma non avrei saputo dire perché.
In parte, erano solo gusti del cazzo. C’era un dipinto in una nicchia che sembrava un de Kooning originale, le sedie invece erano sicuramente Herman Miller. Ma c’era anche del puro rigore in quello stile d’arredamento, nulla però che potesse risalire agli ultimi sessant’anni, niente che rendesse anacronistici i carrelli stile hostess degli aerei e gli sgabelli da bar in pelle di zebra.
Kissing Garden – 15 giorni fa
«C’è un ragazzo di una band», gridò Hyde, apparentemente rivolto al buio della stanza. «L’amico di quel tipo. Il collezionista».
Una porzione di divano, una forma bitorzoluta sotto una montagna di plaid e coperte, si staccò e gridò: «È Brandon? Oh, il mio principino».
Jackie non era arcigna come Hyde. Uno dei vantaggi del trucco molto marcato, spesso come l’intonaco di casa, che porti da quando hai quattordici anni è che la maschera in superficie rimane sempre la stessa indipendentemente dalle macerie che ci stanno sotto, le sue mirabili gambe di un tempo però ora erano solo spigoli appuntiti nei pantaloni del pigiama leopardato. Anche le braccia erano chiazzate e butterate come il gorgonzola. Mi tornò in mente sul palco a Camden, mentre infilzava i pedali degli effetti con tacchi da 25 centimetri, l’enorme chitarra White Falcon della Gretsch che la faceva sembrare un elfo, e ululava nel microfono. Ora un soffio di vento l’avrebbe rispedita a letto.
Kissing Garden – 15 giorni fa
Jackie “Jackylline” O è, come me, una che è tornata. È nata proprio qui in fondo alla strada, in una Horsham qualunque, è scappata sorvolando l’Atlantico nel lontano 1972. Secondo la sua biografia, ha trascorso il tempo nella Bay Area della California a posare «senza vestiti mentre teneva della frutta in mano», prima che Hyde (al secolo, Maurice Muscovitch) la incontrasse in un corso di disegno di nudo, e, senza nemmeno chiederle il nome, sciogliesse la sua band, gli Swamp Gators, e la trascinasse sul palco la sera successiva senza neanche una prova. Jackyl & Hyde incisero dischi rockabilly grezzi e sgangherati per un pubblico che avrebbe dovuto essere il quadruplo per poter essere considerati cult. Finché, travolti dalla prima ondata del punk di Los Angeles, divennero una sorta di mascotte dei Black Flag, delle Go-Go’s e degli X, sempre lì ad aprire i loro concerti ululando note blues paludose in uno tsunami di saliva punk che partiva da Orange County e arrivava fino a Orgreave.
Però poi si presero una bella rivincita. Con la convinzione incrollabile che non sarebbero dovuti cambiare né migliorare mai, erano sopravvissuti ai protagonisti di allora, spazzati via dal disinteresse del pubblico, da qualche dipendenza o dalla morte. Loro si erano fatti strada, partendo come outsider e diventando punti di riferimento attempati, fino a diventare patrimonio nazionale, e ciò semplicemente non smettendo mai di esibirsi come avevano sempre fatto. Eravamo la loro band di supporto nel 1992, durante un piccolo tour di locali inglesi di medie dimensioni; il fatto che la scelta fosse ricaduta su di noi già diceva molto sul loro totale disinteresse per la scena musicale contemporanea.
Nonostante la distanza artistica, o forse proprio perché era molta, ci divertimmo tanto. Ogni momento del set di Jackyl & Hyde era lo stesso da sempre. Tutte le serate, a metà della sesta canzone (stessa canzone, stesso set a ogni concerto), Hyde si piegava sulle sue ginocchia magre, con la corda del microfono legata intorno al collo, vomitava i medesimi versi della Bibbia e oscenità da quattro soldi su una Jackie incurante. Ogni sera c’erano due bis, alla fine dell’ultimo Jackie veniva trascinata fuori dal palco da roadies travestiti da infermieri di un manicomio. Anche i ringraziamenti alla Elvis Presley erano distribuiti in modo uniforme nel corso della serata. Questa routine così collaudata lasciava loro molto tempo per andare in giro. Nel tempo le dimensioni del loro autobus turistico (un Airstream metallizzato, naturalmente) erano raddoppiate, ora sembrava una di quelle case delle piantagioni del Sud, però mobile. Ricordo un samovar di tè freddo corretto con bourbon. Metanfetamina. Twinkie e Sno-Ball.
Ho passato molto tempo insieme a Jackie. Era persa, due volte persa, tre volte persa, però io le invidiavo la capacità di reinventarsi completamente ogni volta. Aveva cancellato ogni traccia della ragazza delle Home Counties che era stata agli inizi. Forse solo l’accento più marcato del compagno, per il resto, nient’altro era come alle origini, dal taglio dei capelli alle unghie, alla voce, al nome che aveva scelto. Indossava corsetti così striminziti che letteralmente le rimettevano in posizione gli organi interni, e sul viso una maschera kabuki realizzata con della cipria. Era magnifico vederli esibirsi dal vivo. Lui era emaciato, indossava un giubbotto di pelle nera, era consumato come un fiammifero sfregato, e si teneva a braccetto con questa bulimica Betty Page. Due orsi polari in piena California si sarebbero fatti notare di meno.
Jackie si alzò in piedi. Ancora magra, ancora il vitino da vespa, ancora truccata come una bambola; attraversò in punta di piedi la stanza per venirmi ad abbracciare. Le sue braccia sembravano senza peso, cave.
«Bene, fatti dare un’occhiata».
Mi sforzai di sostenere il suo sguardo. Aveva gli occhi iniettati di sangue che risaltavano contro la cipria bianca del trucco; quella maschera era incredibile, le girava tutto intorno agli occhi e alla bocca. Ma nascondeva una persona astuta. Attento, Bran, stai attento.
«Be’, non sei mica una foto. Fatti vedere alla luce».
Mi strinse la mano con le sue dita fragili, mi portò in cucina, Hyde non ci seguì. Lui tornò infatti a stendersi sul divano. La TV era ingombrante, lo schermo piccolo trasmetteva un film in bianco e nero.
«Allora». Riempì il bollitore, e accese il gas. Anche i fiammiferi erano vintage, doveva essere quella marca americana con la foto di una tigre sul pacchetto. Jackie si spostava con lentezza tra il bollitore e il rubinetto del lavandino; quando era di spalle, si vedeva la vecchia signora che era diventata.
«Tesoro, a cosa dobbiamo la tua visita?».
Di nuovo percepii l’acciaio sotto lo zucchero. La mia intenzione era quella di parlare dei vecchi tempi, poi distrattamente accennare all’idea di prendere in prestito l’elettro-Theremin, proprio mentre me ne stavo per andare – alla tenente Colombo, per intenderci. Lo sguardo di Jackie però non lasciava scampo.
«Il Theremin di Brian Wilson».
Jackie soffiò sul tè. La sua tazza reclamizzava l’Esposizione Universale di Chicago del 1933, la mia i Brooklyn Dodgers, la squadra di baseball di un tempo.
«Ma certo tesoro, come vuoi. Ci sono molti Theremin in giro, e molto più moderni del nostro».
«Ma io voglio tornare ai vecchi tempi».
Aveva intuito che c’era dell’altro. «È bello da parte tua. E noi certamente incarniamo quello spirito».
«E se qualcuno te lo chiedesse, mi farebbe davvero piacere se gli dicessi che non sono mai stato qui».
«Tutto chiaro». Lei mi fissò negli occhi. «Il tuo amico collezionista di dischi è coinvolto in questa cosa?».
Feci rapidamente dei calcoli. Fidati del tuo istinto.
«Sì, è coinvolto, ma tu non dovrai parlarci».
«Bene, lui faceva innervosire Hyde tutte le volte. Ok, va bene. Quanto mi daresti?».
Feci altri calcoli, stavolta a ritroso. «Mille. Non penso che valga così poco, ma è tutto quello che ho».
«Allora ce lo faremo bastare. Vieni, andiamo a darci un’occhiata».













