Quando ancora si aveva l’idea di futuro, l’anno più futuribile in assoluto era il 2001. Tutta colpa di Stanley Kubrick, naturalmente. Passata la botta emotiva della pre-millennium tension, ci si approcciò a quella data fatidica tutto sommato con un certo ottimismo, senza avere idea delle tragedie che avrebbero segnato l’annata e la storia del mondo nei successivi due decenni.
Limitandoci all’ambito musicale, nel 2001 forse non apparve nessun monolite nero in grado di indirizzare la nostra futura evoluzione di ascoltatori, ma la scena pop (per usare il termine più generico possibile) era viva, fertile e variegata. Il processo di disintegrazione e fusione dei generi, innescato negli anni ’90, non si era ancora compiuto del tutto. Gli stili e le famiglie musicali, benché sempre meno “identitarie”, convivevano fianco a fianco, comunicando occasionalmente. Non che questo si intuisse guardando la lista delle hit: nelle classifiche e nelle radio, allora ancora importanti come arbitri del gusto, dominava il pop/r&b mainstream, soprattutto femminile, ed era tutto un profluvio di Shakira, Janet Jackson, Destiny’s Child, Christina Aguilera. I cinque album più venduti erano firmati Linkin Park, Shaggy, NSYNC, Enya (Enya?), Staind. Non esattamente delle madeleine per cui ricordare il 2001 singhiozzando, in effetti.
Eppure, al di sotto della linea di galleggiamento commerciale, il panorama era mosso e stimolante. Hip hop ed elettronica (sia quella più dance oriented che quella più sperimentale e concettuale) erano in fase di rinnovamento, post rock e trip hop esaurivano definitivamente la loro stagione lanciando tuttavia ancora segnali interessanti, il pop soprattutto di marca britannica si difendeva mescolando suggestioni provenienti da fonti diverse (colonne sonore, elettronica “povera”, anni ’60-70 alternativi), il folk e la musica acustica in generale vissero una rinascita inaspettata, il soul diventava “nu” sperimentando percorsi produttivi più contemporanei ma sempre con lo sguardo rivolto all’epoca d’oro. E poi, incredibilmente, c’era il rock. Anzi: il rock’n’roll. Nel 2001 tornò senza preavviso sotto i riflettori, grazie a band come Strokes e White Stripes che fino a un paio di anni prima sarebbero rimaste confinate all’ambito dei cultori dei suoni garage. Improvvisamente nei club si tornò a ballare musica che sarebbe andata bene per il CBGB del 1976, e se anche non si trattò di un boom paragonabile a quello di dieci anni prima certamente quel risveglio delle chitarre (probabilmente l’ultimo) avrebbe segnato i successivi due o tre anni, creando contemporaneamente stilemi e estetica dell’indie anni Zero.
Nell’anno in cui Apple lanciò iTunes, l’industria musicale viveva ancora gli ultimi scampoli di grandeur. Ma era un Titanic che non voleva cogliere i sinistri scricchiolii che già si potevano sentire. Due anni prima era nato Napster, e la strada era segnata. A distanza di vent’anni possiamo ragionevolmente dire che il 2001 in musica, al contrario del 2001 in politica e società, non comportò nessuna cesura netta. Fu un anno di transizione, e tuttavia ricco di dischi eccellenti in ogni ambito. Ne abbiamo scelti e commentati 20, tra quelli secondo noi più rappresentativi.
“Things We Lost in the Fire” Low (gennaio 2001)

Può sembrare strano, oggi, pensare che già nel 2001 i Low venissero percepiti come una band al culmine dell’ispirazione e della maturità, a sette anni dal loro primo album. Con Things We Lost in the Fire, quinto disco dei coniugi Alan Sparhawk e Mimi Parker (ai quali si accompagnava allora il bassista Zak Sally), si lasciano indietro i panorami glaciali di quello slowcore che avevano in pratica inventato insieme a band come i Codeine per accucciarsi intorno a un falò di ballate eteree e melodie di straziante malinconia. Canzoni come Dinosaur Act, Whore, Like a Forest riescono a essere allo stesso tempo imponenti e delicate, le armonie vocali di Alan e Mimi (la cui voce da sola in Laser Beam spezza letteralmente il cuore) avvolgono e confortano. Sembrava un capolavoro difficile da superare, questo, per i suoi stessi autori. Chi poteva immaginare che vent’anni dopo i Low sarebbero stati ancora qui, a forzare coraggiosamente i limiti del loro suono?
“Quiet Is the New Loud” Kings Of Convenience (gennaio 2001)

Nel 2001 le riviste musicali, soprattutto quelle inglesi, avevano ancora un certo peso nell’imporre non solo singoli artisti ma persino interi generi, spesso inventati. Uno di questi fu il cosiddetto new acoustic movement, passato alla storia (si fa per dire) con l’acronimo NAM. I reucci di questa contea erano due nerd norvegesi chiamati Erlend Øye e Eirik Glambek Bøe. I Kings of Convenience, nome ispirato al payoff di una catena commerciale, innescarono praticamente da soli, o al limite con i Turin Brakes di The Optimist LP, una morbida rivoluzione il cui sussurro di battaglia era, per l’appunto, “quiet is the new loud” (frase che poi negli anni successivi avrebbe involontariamente ispirato un tormentone da internet). Un pop-folk soffice e bisbigliato, con Simon & Garfunkel, Donovan e un po’ di bossanova nel cuore, ganci melodici tenui ma azzeccati, e tanti buoni sentimenti che il mondo da lì a qualche mese avrebbe provveduto a spianare. Ma fu bello crederci, per un attimo. Come recita il titolo del primo brano, quel fragile movimento neo-acustico vinse una battaglia perdendo la guerra.
“Discovery” Daft Punk (marzo 2001)

Quando nel 2020 Thomas Bangalter e Guy-Manuel de Homem-Christo hanno chiuso le trasmissioni, sigillando la quasi trentennale storia dei Daft Punk, uno dei topic più caldi nelle discussioni online riguardava quale fosse l’album più rappresentativo nella smilza discografia del duo. I pareri divergono, come è ovvio, ma la sensazione è che Discovery alla fine possa essere considerato il lavoro in grado di raccogliere più consensi da tipologie diverse di fan. Nell’opera seconda dei Daft Punk c’è qualcosa per chiunque, in una sarabanda di suggestioni ideali per il dancefloor quanto per l’ascolto. Dall’acuminato, calibratissimo minimalismo house dell’esordio Homework la coppia francese si sposta qui su un eclettico mix di electro-r&b, garage newyorkese, Euro disco, fantascienza e anime giapponesi. Un gioioso esercizio di sintesi strabordante di effetti speciali, riempipista indimenticabili, sampler, vocoder e Auto-Tune, il cui concept ha vagamente a che fare con il riconnettersi, come adombra il titolo, alla magia della scoperta tipica dell’infanzia.
“Gorillaz” Gorillaz (marzo 2001)

Le band in formato cartoon non erano una novità. Già negli anni 60 c’erano stati, tanto per fare un esempio, gli Archies. Eppure, l’idea di Damon Albarn e del disegnatore Jamie Hewlett di lanciare un gruppo sotto forma di cartone animato sembrò il massimo del post modernismo, perfettamente in linea con le suggestioni pop a cavallo tra i due millenni. Con il passare del tempo la novelty ha esaurito inevitabilmente e velocemente il suo effetto, benché la produzione musicale dei Gorillaz (da lì in poi sostanzialmente un progetto di Albarn con collaboratori occasionali) abbia mantenuto diversi elementi di interesse. L’esordio omonimo resta comunque il vertice della discografia gorillosa, grazie alla sua miscela esplosiva e astutissima (fondamentale la co-produzione di Dan the Automator) di hip hop, funk, rock, dub, psichedelia e pure qualche influsso latino. Clint Eastwood rimane uno dei singoli più appiccicosi e irresistibili degli ultimi vent’anni, e del resto sette milioni di copie non si vendono per caso.
“B.R.M.C.” Back Rebel Motorcycle Club (aprile 2001)

Che fine ha fatto il nostro rock’n’roll? Se lo chiedevano i Black Rebel Motorcycle Club e ce lo chiedevamo un po’ tutti noi, a inizio anni Duemila. Apparentemente ignari del fatto che da lì a poco sarebbe ritornato di moda grazie a Strokes e simili. Un fuoco di paglia, lo avremmo capito dopo, ma bello e intenso finché è durato. Ad alimentarlo, appunto, anche band come quella dei motociclisti ribelli in nero (nome ispirato a Il selvaggio con Marlon Brando), arrivati rombando dalla loro San Francisco. Un rock’n’roll saturo e narcotico che guardava da un lato alla tradizione punk e psichedelica degli anni ’60-70 e dall’altro alle generazioni successive (Jesus & Mary Chain, Spacemen 3, Verve e Brit popper sparsi), il tutto condito da riferimenti alla controcultura beatnik, citazioni di Allen Ginsberg e così via. All’epoca tutto ciò aveva ancora un senso e una certa presa sul pubblico “giovane”. Quello di oggi, giovane o meno, neanche se lo chiede più che fine ha fatto il rock’n’roll.
“Simple Things” Zero 7 (aprile 2001)

Ennesimo duo presente in questa lista, Henry Binns e Sam Hardaker in arte Zero 7 hanno patito, soprattutto all’inizio, l’etichetta semplicistica che venne applicata loro di Air inglesi. La somiglianza c’era, indubbiamente, sia nel suono che nell’impianto estetico generale del progetto, ma i brani di questo esordio apprezzatissimo in tempo reale e oggi forse un po’ dimenticato sono figli anche della contiguità con la scena britannica di allora, Morcheeba e Massive Attack (dei quali potevano a volte sembrare una versione “light”, tanto per insistere con i paragoni) su tutti. Voci soul, melodie, tastiere analogiche, arrangiamenti d’archi, ritmi downtempo: la ricetta vincente per il perfetto album chillout. Il post-trip hop iniziava (o forse si concludeva) con questo disco, la cui definizione su Rolling Stone era particolarmente azzeccata: “more jazz on acid than acid jazz”.
“Miss E… So Addictive” Missy Elliott (maggio 2001)

Sulla copertina di quello che è probabilmente il suo miglior disco, Missy Elliott – il cui middle name artistico, giova ricordarlo, era “Misdemeanor”, cioè “reato” – sembra una eroina da film di fantascienza. Una fuorilegge spaziale, Sigourney Weaver black con lo sguardo deciso di chi sa cosa vuole e come ottenerlo, e che nessun alieno, pardon maschietto, provasse a mettersi di mezzo. Con qualche eccezione come Timbaland, la cui produzione esalta la carica aggressivamente sexy della diva r&b dandole un suono per l’epoca assolutamente contemporaneo per non dire futuribile. Erotismo e orgoglio sono i due poli tra i quali rimbalzano i brani, seducenti incontri tra hip hop e cultura dance in un momento di cambiamento per entrambi. Get Ur Freak On, Dog in Heat e One Minute Man suonano so addictive ancora oggi.
“cLOUDDEAD” cLOUDDEAD (maggio 2001)

Ambient rap? Hip hop post psichedelico? Chiamiamolo come vogliamo, di sicuro al momento dell’uscita non c’era quasi nulla che suonasse come l’omonimo esordio del cLOUDDEAD. C’è una foschia drogata a stagliarsi sopra e dentro i brani di questo album, che nasce più come raccolta di precedenti tracce pubblicate su singoli e EP che come concept vero e proprio. Interferenze, suoni trovati, cantilene ipnotiche che riportano all’innocenza infantile quasi si trattasse di un Syd Barrett cresciuto in un ghetto americano degli anni ’90 invece che nella Cambridge dei ’50. Come punti di riferimento emergono forse più i Boards of Canada o addirittura i contemporanei Radiohead (vale anche il viceversa, naturalmente) che non, per dire, il Wu-Tang Clan. Una ipotesi di trasmutazione in senso astratto e minimal dell’hip hop che non verrà perseguita fino in fondo negli anni successivi, anche se con il secondo album Ten i cLOUDDEAD piazzeranno ancora un colpo magistrale.
“Amnesiac” Radiohead (maggio 2001)
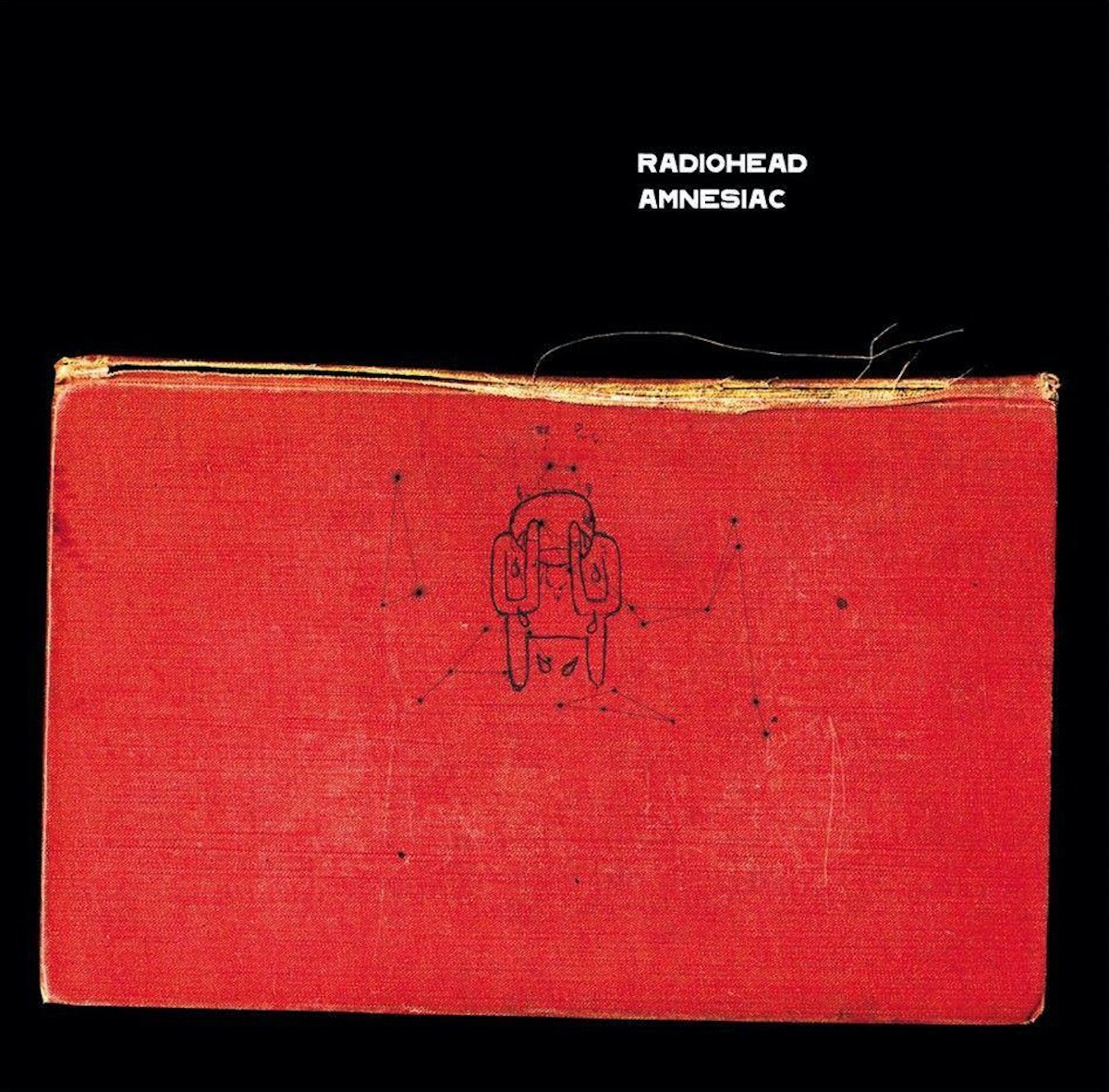
O della metamorfosi, fase 2. Difficile, che si sia fan dei Radiohead o no, separare Amnesiac dal precedente Kid A. O almeno, era pressoché impossibile separarli ai tempi, quando le speranze dei nostalgici dei Radiohead “con le chitarre” si infransero sui nuovi panorami di desolazione disegnati dalla band di Oxford. Con il passare del tempo tuttavia è emerso il carattere meno arcigno e meno de-umanizzato di Amnesiac, e il suo vago sapore “analogico” lascia un gusto meno metallico in bocca. Benché nati contemporaneamente a quelli dell’album precedente, brani come Pyramid Song, Knives Out, Like Spinning Plates, e Life in a Glasshouse recuperano l’idea di canzone (seppur de-costruita) senza che l’atmosfera sonora prenda il sopravvento rispetto a tutto il resto. L’interiorità conta tanto quanto il paesaggio. Certo: non era Ok Computer 2.0. Ma neanche il Kid B sul quale molti hanno ironizzato.
“Poses” Rufus Wainwright (giugno 2001)
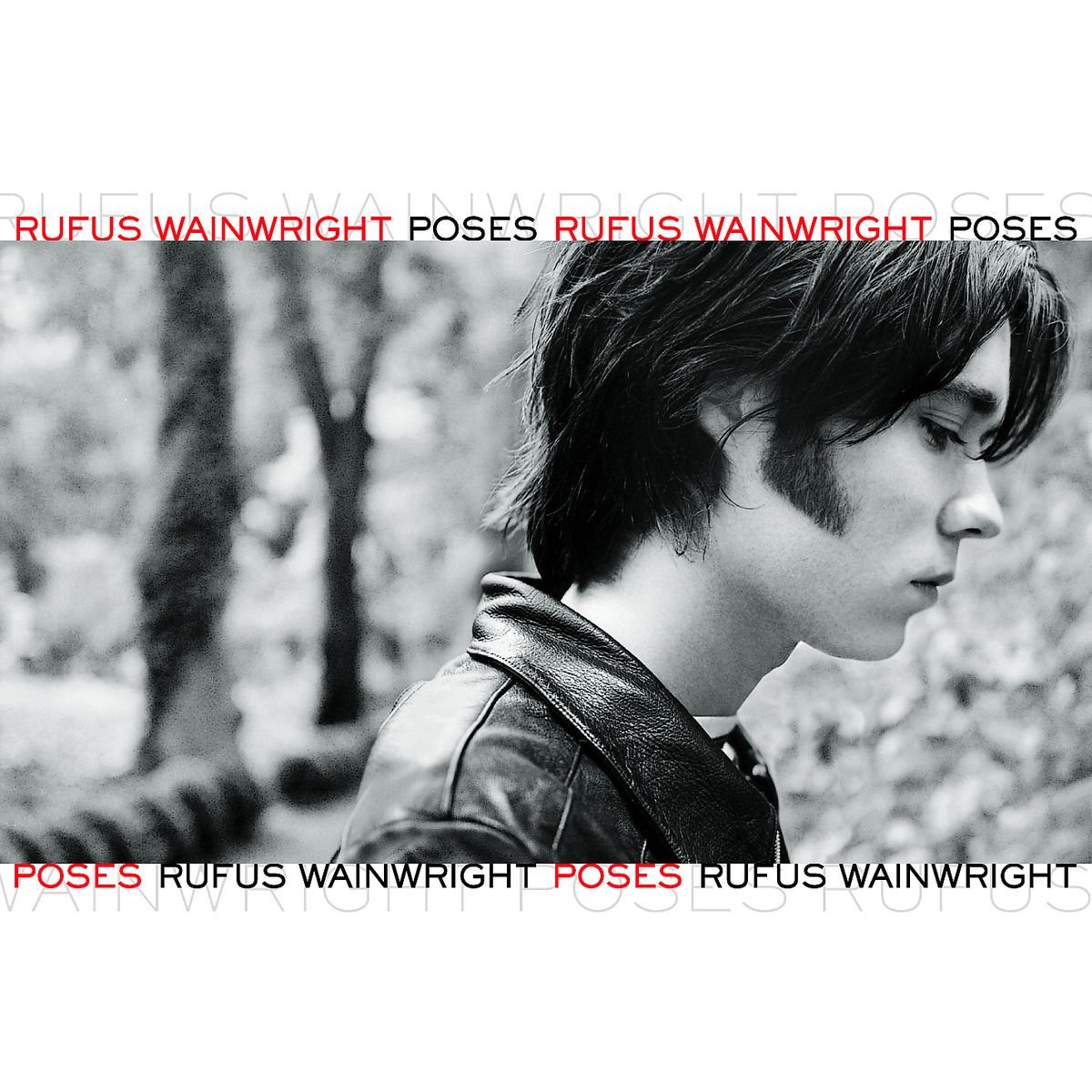
“Sigarette e latte al cioccolato sono solo due dei miei vizi”, canta Rufus Wainwright nel brano che apre questo suo secondo album. Fossero stati solo quelli, appunto. Poses è una sorta di diario del soggiorno newyorkese di Wainwright al Chelsea Hotel, sei mesi di edonismo e decadenza a pieni giri tra droghe, sesso promiscuo e svariati altri divertissement. Materiale che nelle mani sbagliate può sfociare in noiosissimi e autocompiaciuti flussi di coscienza, ma che in quelle del giovane figlio d’arte (i genitori di Rufus sono il cantautore Loudon Wainwright III, del quale interpreta One Man Guy, e la folksinger Kate McGarrigle) si trasforma in scintillanti ballate pop che hanno poco da invidiare all’Elton John più ispirato dei primi anni ’70. Nonostante la produzione di lusso e gli arrangiamenti raffinati, Poses è uno dei più sobri tra i dischi di Wainwright, che qui trattiene al minimo le tentazioni operistiche e l’attrazione verso il kitsch da Broadway, concedendosi al massimo le divagazioni orientaleggianti della splendida Greek Song.
“Rooty” Basement Jaxx (giugno 2001)

Parlando di copertine, tra quelle più istantaneamente associabili al 2001 quella con Snowflake, il gorilla albino che mastica un ramo, se la gioca con la mano guantata sul posteriore di Is This It? degli Strokes. Un po’ meno sexy, magari, ma altrettanto memorabile. Così come memorabile è la musica contenuta in questo album, sempre che quell’anno si sia andati almeno una volta o due a ballare in un club. Uno dei party record più frenetici e spudoratamente divertenti nella storia del dancefloor: i Basement Jaxx (ovvero il duo Simon Ratcliffe e Felix Buxton) gettano nel calderone house, garage, r&b, soul, latinismi vari (i Tijuana Brass campionati) e soprattutto tanto, tantissimo funk. “Rooty” era il nome della serata che la coppia di dj/produttori teneva regolarmente a Londra, e questo disco ne è probabilmente una replica fedele. Senza dress code, buttafuori e liste di invitati.
“Songs in A Minor” Alicia Keys (giugno 2001)

Dodici milioni di copie vendute, di cui 50 mila il giorno dell’uscita, cinque Grammy, dischi di platino raccolti in una decina di Paesi, una enorme popolarità trasversale la cui inerzia ha dato slancio ai vent’anni di carriera di una cantante allora diciannovenne e al debutto: basta questo per inquadrare Songs in A Minor. Alicia Keys è diventata dal momento zero una superstar, ma forse non quella regina assoluta del soul che in molti vedevano in lei, complici anche i riferimenti evidenti a modelli come Aretha Franklin o Roberta Flack. Si è confinata (per modo di dire) in un dorato ambito mainstream, senza mai tentare sortite sperimentali. Peccato, perché il talento vocale, di pianista (la sua educazione classica emerge spesso) e di scrittura è sempre stato enorme. Ed era già tutto qui, in questo sensuale, elegantissimo impasto di r&b, gospel, soul e atmosfere urban.
“It’s a Wonderful Life” Sparklehorse (giugno 2001)

Non era esattamente una vita meravigliosa, quella di Mark Linkous. Lo si sapeva già nel 2001, visti i suoi trascorsi, e ne avremmo purtroppo avuta la certezza nove anni più tardi, quando alla vita vi avrebbe rinunciato volontariamente. Eppure il titolo di questo album, il primo a non essere inciso da solo nel proprio studio casalingo, non può essere solo un cinico sberleffo. In più momenti viene invece da pensare che Linkous, in questo tentativo di ritrovare un senso e una luce all’esistenza, sia disperatamente sincero. Prodotto da David Fridmann, gran maestro di pop orchestrale con Flaming Lips e Mercury Rev, e nobilitato da contributi di alto livello (Tom Waits, voce e co-autore di Dog Door, PJ Harvey, Nina Persson, John Parish, una allora ancora sconosciuta Joan as Police Woman), It’s a Wonderful Life è un mirabile esemplare di indie/chamber pop, ma anche – ebbene sì – un cigolante, perverso inno alla bellezza della vita.
“White Blood Cells” The White Stripes (luglio 2001)

Improvvisamente, a un certo punto dei primi anni Zero, un genere carbonaro e per appassionati come il garage rock divenne mainstream. Una buona parte di merito va ai White Stripes, che con questo loro terzo album (ultimo per una etichetta indipendente, anche se verrà ristampato su major l’anno dopo) rompono definitivamente la barriera del culto per iniziati, anticipando il successo clamoroso che sarebbe arrivato grazie a Seven Nation Army (anche se i mondiali del 2006 erano ancora distanti un lustro). Non si trattò di fortuna né di allineamento favorevole di pianeti: quello di Jack e Meg era un progetto fondato su una precisa e inimitabile visione estetica, sul talento e sulla conoscenza profonda di cosa significa suonare rock’n’roll mantenendo fascino vintage senza sembrare banalmente passatisti. Meno blues rispetto agli esordi, con solo chitarra, batteria e qualche inserto di piano a guidare le canzoni, White Blood Cells graffia, eccita, fa muovere le chiappe. Una lezione di sintesi.
“Endless Summer” Fennesz (luglio 2001)

L’antinomia tra il titolo, perfetto per una antologia dei Beach Boys, e la copertina nella quale il mood estivo è velato da nubi incombenti, è già una sinossi efficace per questo disco di Christian Fennesz. Ottimismo e malinconia, analogico e digitale, melodie reiterate e interferenze elettroniche che gravano sull’atmosfera generale un po’ come il retropensiero che nessuna estate è davvero infinita. No, i Beach Boys non c’entrano nulla, a meno di non pensare che questa sia l’idea di surf che può avere uno sperimentatore elettronico di Vienna, dove le spiagge in effetti non abbondano. Caposaldo dell’estetica glitch, nonché uno dei migliori esempi della fascinazione per antiche memorie anni ’60-70 di cui certa elettronica soprattutto in quel periodo era invaghita, Endless Summer rilassa e massaggia la mente lasciando tuttavia l’impressione di essere intrappolati in una bolla. Una stasi ipnotica dalla quale, una volta entrati, era difficile voler uscire.
“Aaliyah” Aaliyah (luglio 2001)

La storia è nota, e straziante. Il 25 agosto del 2001, neanche un mese dopo l’uscita del suo terzo disco, Aaliyah Dana Haughton muore in un incidente aereo alle Bahamas, dove era andata a girare il video del singolo Rock the Boat. Aveva 22 anni, un già notevole curriculum artistico alle spalle (aveva esordito appena quindicenne) e un futuro che non si fa fatica a supporre radioso davanti. Ma non è per macabro patetismo che abbiamo inserito il suo album omonimo in questa lista. L’r&b di pezzi come We Need a Resolution e I Care 4 You hanno un sapore contemporaneo che non li fa sembrare invecchiati rispetto a produzioni odierne, al contrario di molto neo soul femminile di vent’anni fa. Merito anche di Timbaland e Missy Eliott che danno un contributo importante, ma la regina qui è Aaliyah. Convincente e seducente al di là dei manierismi vocali tipici di quel genere/non genere definito urban, di cui questo disco rimane una delle testimonianze migliori.
“Is This It” The Strokes (luglio 2001)

Certi dischi, e certe band, catturano talmente bene un determinato momento storico da far pensare che avrebbero dovuto rimanere lì, congelati in quell’attimo di magia. Gli Strokes dell’esordio ne sono un esempio, benché il resto della loro carriera sia stato comunque più che dignitoso. In termini pop tutto è perfetto, in Is This It. Le canzoni, i ritornelli, l’atteggimento un po’ arrogante e un po’ annoiato, ma con una punta di innocenza giovanile, il look, il minimalismo estetico quasi warholiano, persino l’estrazione alto-borghese di Julian Casablancas e soci che dava pepe allo storytelling su di loro. Ma soprattutto le canzoni. Last Nite, The Modern Age, Take It or Leave It, Hard To Explain, Someday erano e sono delle bombe di rock’n’roll diretto, monocromatico e riconoscibilissimo nei suoi punti cardinali (Velvet, Television, Modern Lovers, Blondie e Lust for Life riscritta almeno tre o quattro volte). Uno dei dischi più irresistibilmente newyorkesi di sempre, e proprio come la Grande Mela icona pop art che non invecchierà mai.
“Vespertine” Björk (agosto 2001)

In origine il disco avrebbe dovuto intitolarsi Domestika, chiarissima dichiarazione di intenti. Vespertine assolve in modo molto più poetico ed evocativo allo stesso compito, racchiudendo perfettamente in una parola lo spirito e l’atmosfera dominante dell’album che riportò Björk al centro del palcoscenico musicale dopo la parentesi cinematografica, complicata e per certi versi traumatica, di Dancer in the Dark. Una preghiera della sera, un bozzolo casalingo (Cocoon, come recita il titolo di uno dei brani più lievi) nel quale rinchiudersi per ritrovare se stessi, con in sottofondo il battito della natura e quelli elettronici provenienti da un laptop sulle ginocchia. C’è poco o nulla dell’esuberanza e del massimalismo avant pop di lavori come Homogenic o Post, in questi brani sottesi a ritmi minimali e guidati da una voce sussurrata, quasi disincarnata, e con il contrappunto di “suoni della realtà” campionati (passi sulla neve, fruscii di carte). L’intensità è la medesima, tuttavia. L’album più intimo e commovente dell’artista islandese.
“Love and Theft” Bob Dylan (settembre 2001)

I tempi stavano di nuovo cambiando, per dirla dylanianamente, e non per il meglio. La suggestione legata alla data di uscita di Love and Theft (11 settembre 2011) è indubbiamente forte, ma al di là della casualità storica l’album si è ritagliato la sua nicchia nel monumentale corpus dylaniano in virtù dei suoi meriti artistici. Si dice che dopo gli anni ’70 Bob abbia pubblicato un capolavoro a decennio, e per quanto riguarda gli anni Zero la questione si chiude qua, proprio agli inizi e proprio in parallelo a uno dei più tragici momenti di svolta nella storia americana. Il futuro premio Nobel, che sfodera qui per la prima volta il baffetto alla Errol Flynn, lascia da parte l’enfasi apocalittica e il senso di mortalità che aveva caratterizzato il precedente Time Out of Mind per immergersi nuovamente nelle viscere del Sud degli States e nella tradizione folk-blues-rock’n’roll, suonando ispido e “roots” ma anche profondamente ispirato.
“The Argument” Fugazi (ottobre 2001)
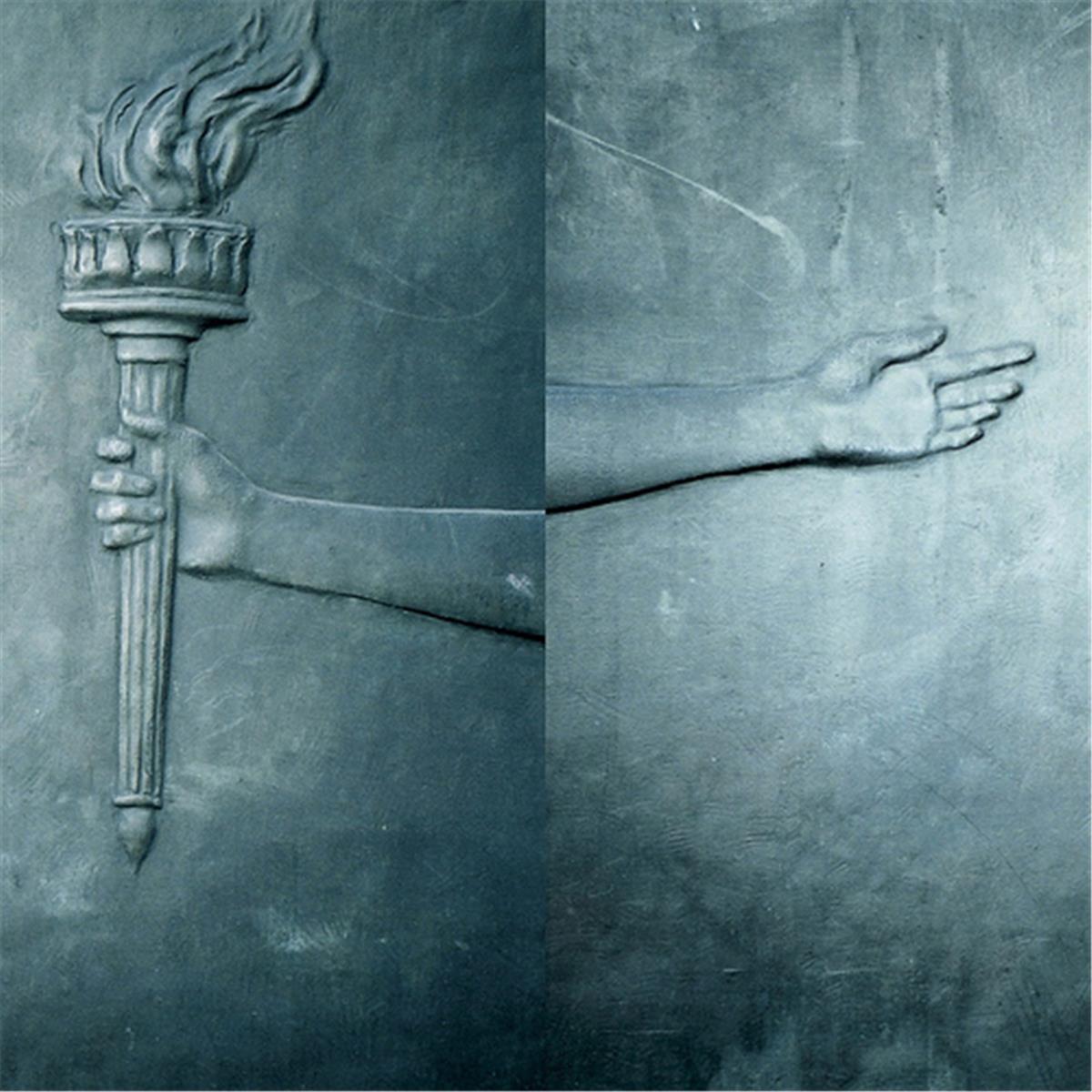
Per una band con lo sguardo costantemente rivolto in avanti, non è strano che l’ultimo album sia anche il migliore della carriera. Dopo The Argument i Fugazi non hanno più inviato dispacci dal fronte: formalmente non si sono sciolti, sono una cellula punk dormiente che forse un giorno tornerà attiva, o forse no. Certo che in questi vent’anni avremmo avuto un gran bisogno di loro. Vent’anni di guerre infinite e drammi sociali su cui Ian MacKaye, Guy Picciotto, Brendan Canty e Joe Lally avrebbero avuto molto da dire, alla loro maniera. Qui il tema della “discussione” è proprio il conflitto, l’eterna anima guerrafondaia degli Stati Uniti. Disco politico al pari e forse più degli altri album dei Fugazi, musicalmente rappresenta una ulteriore evoluzione del classico suono post hardcore, con inediti spunti melodici, costruzioni originali dei brani, strumentazione inedita che include piano, archi e persino una doppia batteria. Se davvero resterà l’ultimo atto della storia dei Fugazi, è stato il migliore congedo possibile.
















