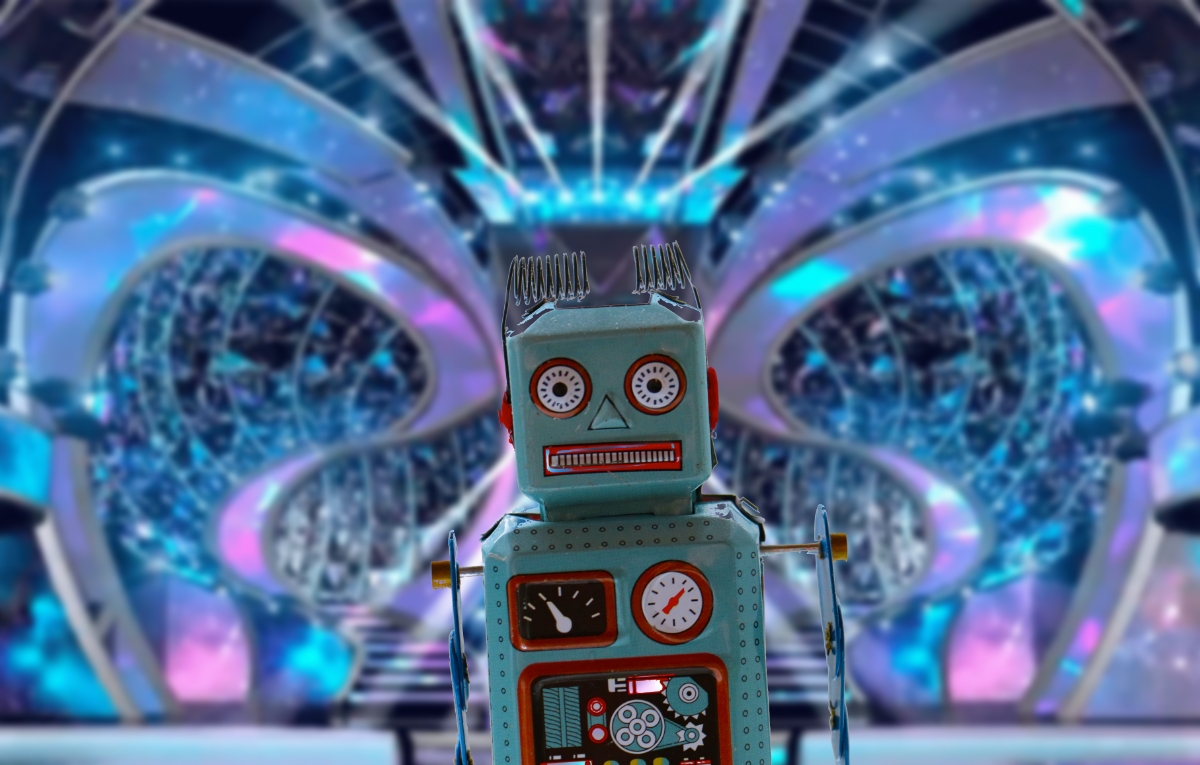Contrariamente a quello che si potrebbe pensare, la musica non è un linguaggio universale. Tra le canzoni più discusse di questo 2022, ad esempio, c’è quella presentata da Dargen D’Amico a Sanremo, Dove si balla. C’è chi l’ha amata tantissimo (ad esempio chi vi scrive, che oltre ad essere una sua grande fan nutre anche una certa perversione per il sound zarro dei tagadà di provincia) e chi invece è rimasto interdetto (perché si aspettava ben altro da una delle penne più colte e letterarie del rap italiano).
L’ascolto in anteprima del suo nuovo album, che esce venerdì e si intitola Nei sogni nessuno è monogamo, ha generato un vivace dibattito tra gli addetti ai lavori, gli unici che per ora hanno avuto la possibilità di sentirlo. Il motivo risiede nel fatto che contiene sì la sua grande e inconfondibile vena poetica, ma è soprattutto un disco pop, in un certo senso più vicino a progetti come D’io che a exploit astratti e artistoidi come Bir Tawil o Variazioni. E quindi: che fine ha fatto il Dargen di una volta? Si è venduto al sistema? È stata l’influenza di Fedez e degli altri grandi nomi del pop mainstream per cui Dargen presta la sua opera come autore? La vera domanda, però, forse dovrebbe essere un’altra: perché mai Dargen D’Amico dovrebbe limitarsi a essere una cosa sola? Non ha forse il diritto di sfornare anche lui qualche canzonetta/tormentone ogni tanto? Di questo e di molto altro abbiamo parlato con il diretto interessato, partendo proprio dalla pietra dello scandalo, se così vogliamo definirla.
Sei consapevole del fatto che alcuni, avendo imparato ad amarti per i tuoi brani più complessi e sperimentali, erano sul punto di chiamare un esorcista quando hanno sentito Dove si balla?
Al di là del fatto che rifletterò sulla necessità di un esorcismo, Bir Tawil è un disco che ho scritto nella primavera del 2019, quindi in un’epoca molto distante da quella in cui viviamo. Forse è il fatto che è cambiato tutto, ad avermi portato a fare qualcosa di diverso. Sono stato per molto tempo fin troppo conservativo, e avevo bisogno di un’occasione di rottura, per riaprire le valvole. Tutto quest’album, realizzato nei due mesi successivi all’annuncio del cast di Sanremo, va visto proprio così: come il lavoro di una persona che, prima di quel momento, aveva meditato seriamente di mandare in pensione il progetto Dargen D’Amico. E quindi ha tirato fuori un sacco di questioni derivate di quella riflessione.
Ci avevi pensato concretamente ad archiviare Dargen? Non è solo un modo di dire, quindi?
Ci avevo pensato, sì. Non è obbligatorio continuare ad andare avanti, se non ci sono più le condizioni. Il progetto rischiava di non avere più una ragion d’essere, e di non stare in piedi neanche in termini di economie. È sempre stato molto piccolo, e si stava rimpicciolendo ulteriormente. Magari voi ragazzi di Rolling ci eravate affezionati e lo avete anche sostenuto, ma se le cose fossero continuate così sarebbe stato inevitabile abbandonarlo. Fino a quando si poteva ancora suonare, aveva senso: facevo il mio disco e lo portavo in giro, dopodiché mi prendevo una pausa, viaggiavo un po’, tornavo in studio carico di nuovi stimoli, registravo un altro disco e il giro riprendeva. L’equilibrio pre-pandemico era perfetto. Non rinnego nulla, però la persona non è l’artista: se non fosse arrivato Sanremo avrei probabilmente fatto altro, come d’altronde hanno fatto i due terzi delle persone che avevano un pubblico di nicchia e facevano musica in Italia prima del Covid. Nel nostro Paese è molto complesso fare questo mestiere, come tutti sappiamo.
Sei stato tra i pochissimi a parlare apertamente di questa difficoltà, anche dal palco dell’Ariston: l’ultima sera, prima di cantare, hai “ringraziato” il governo italiano che «tende a dimenticarsi delle piccole realtà musicali: dobbiamo trovare delle alternative, e quindi sono qui. Spero che nel futuro prossimo le cose cambino».
Era una battuta dettata dal momento, però è la realtà. Probabilmente, se il mio progetto non avesse rischiato di affondare, non sarei neanche andato a Sanremo: nella vita ogni azione è causa e conseguenza di qualcos’altro. È una catena, come cantava Dalla.
Forse lo stupore è dettato anche dal fatto che era da un po’ che non ti producevi in pezzi del genere, un po’ alla Bocciofili, che pure hanno sempre fatto parte del tuo repertorio…
Beh, dal mio punto di vista tutti i miei exploit degli ultimi mesi – dall’esibizione di Sanremo a Nei sogni nessuno è monogamo – non sono niente di nuovo: l’avevo già fatto in passato. Su quel palco sono stato me stesso, né più né meno. Molte delle canzoni che ho firmato assomigliano a Dove si balla, che è simile a tanti altri miei pezzi ballabili, o a La bambola, che è perfettamente in linea con la mia idea di cover.
Ascoltando La bambola in effetti è impossibile non ripensare al progetto Macrobiotics, in cui insieme al produttore Nic Sarno rifacevi in chiave electropop classici come La guerra di Piero o Impressioni di settembre.
La bambola mi ha sempre fatto impazzire, come pezzo: ha una dimensione sospesa che non è assolutamente facile ricreare, infatti non so se ci sono riuscito, ed era perfetto anche per attualizzare la narrazione con una mia strofa. Per me fare dischi dev’essere uno stimolo: ho sempre cercato di prendere direzioni diverse, e di non seguire mai una strada già battuta. Può essere un grave errore dal punto di vista strategico, ma sono fatto così. La coerenza artistica appartiene agli Artisti con la A maiuscola; io mi considero uno che fa musica perché ama scrivere, e vuole continuare a farlo in un modo o nell’altro. Voglio creare un’economia circolare legata alla parola.
A conti fatti sei contento di essere andato al Festival, e di esserci andato con Dove si balla? O a posteriori rischia di diventare un trauma infantile, come capita a tanti altri?
Infantile sicuramente, perché la mia età cerebrale è rimasta all’infanzia, il che è uno dei motivi per cui faccio musica. Trauma non direi. Sapevo a cosa andavo incontro, anche perché conosco i racconti di tanti altri che ci sono stati prima di me. Egoisticamente ero curioso di fare quest’esperienza, che secondo me è quasi d’obbligo almeno una volta nella vita per vedere di nascosto l’effetto che fa, volendo citare un altro grande della musica italiana. In fin dei conti sono davvero soddisfatto, anche di essere riuscito a portare a casa un album così omogeneo in due mesi. Una volta non avevo il trip di dover per forza concludere, e bene, ogni disco che cominciavo. La prendevo con molta più leggerezza, oggi non riuscirei. Forse è l’età. Ho fatto talmente tanti dischi, prima di arrivare a questo, che vivo ognuno come un tassello importante.
In effetti questo è il decimo. La cifra tonda ti fa effetto?
Abbastanza, soprattutto se penso che il primo, quello che ha dato origine a tutto, era un non-album: Musica senza musicisti era semplicemente il catalogo dei miei svariati tentativi di fare canzoni, racimolate tra il 2004 e il 2006. Ai tempi era stato Francesco Gaudesi (suo manager e socio nell’etichetta Giada Mesi, nda), che è sempre stato con me, a dirmi: «Ma perché non proviamo a raccoglierli e ad autoprodurci un disco?». Mi sento una persona molto diversa dal ragazzo di allora.
Beh, è normale, è passato un sacco di tempo.
Non lo so: comincio a pensare che non ci sia davvero niente di normale, nella vita.
Da vicino nessuno è normale, diceva Franco Basaglia. A proposito, come mai il titolo Nei sogni nessuno è monogamo?
Penso che ci sia un’elasticità naturale nella programmazione della nostra vita che parte proprio dai sogni. Ed è anche un po’ una sfida che faccio a me stesso: negli ultimi anni ho smesso di ricordare i miei sogni, di parlarne la mattina successiva, di ricamarci su e fantasticare. Essendo ormai abituati a pensare solo all’interno del recinto, anche il materiale onirico ne risente, ma per me è sempre stato importante cercare le basi del giorno successivo nella notte precedente. Volevo ricominciare a viverla come il punto di partenza della giornata, e non semplicemente come la chiusura di una giornata.
Sembra quasi un concetto da mindfulness.
Non mi sento molto mindful, a dire il vero, ma magari dall’esterno mi percepiscono così.
Nell’album apparentemente hai messo tanti episodi personali, molta vita privata, molti sentimenti concreti e pochi concetti astratti. È effettivamente così?
Le canzoni contengono episodi che mi sono successi, o momenti che ho captato in qualche bar di periferia, ma spesso sono un puzzle di cose avvenute in situazioni molto distanti tra loro, di cui magari non ero neanche il protagonista. Non credo che vadano lette come una cronaca: o meglio, forse sono la cronaca dell’anima, in cui il soggetto e l’oggetto tendono a confondersi.
Alcune, però, sembrano raccontare degli episodi di vita vissuta, come Ma noi, su una rimpatriata con i tuoi ex compagni delle superiori in cui ritrovi una vecchia amica per cui hai sempre avuto una cotta…
Quello è un brano assolutamente figlio di Sanremo, in realtà, anche se non sembra. Come d’altra parte è stato per quasi tutto il disco. Quando il 4 di dicembre il telegiornale ha annunciato che avrei partecipato al Festival, ho ricevuto un sacco di messaggi di miei ex compagne di scuola o persone con cui in passato avevo avuto dei feeling inespressi. È una kermesse che scatena un vero sentimento popolare e quindi persone che magari non mi avrebbero mai scritto si sono fatte vive all’improvviso, per condividere un ricordo o un momento del passato. Da lì è nata l’idea, ma la trama è frutto dell’immaginazione: a una rimpatriata del liceo non ci andrei mai. Amo molto le persone che ho conosciuto all’epoca, ma non quel tipo di situazioni: mi farebbe piacere rivederli separatamente, tutti insieme a una cena è un po’ troppo. La viltà degli autori di canzoni sta proprio nel raccontare cose che in realtà non avrebbero mai il coraggio di fare. E poi, oltre a essere un esercizio di fantasia, è anche un esercizio di stile. Come si sa, mi diverto come un bambino a giocare con le parole: avevo già fatto un brano intitolato Ama noi, ho tolto una vocale ed è rimasto Ma noi. Il prossimo passo potrebbe essere A noi, ma forse è eccessivo.
Ti immagini che ad ascoltare quest’album “figlio di Sanremo” sarà un pubblico nuovo, che ha conosciuto il Dargen di Dove si balla sul palco dell’Ariston, o il tuo affezionatissimo zoccolo duro di fan?
Non saprei, e tra l’altro non so neanche se l’affezionatissimo zoccolo duro è davvero tale: se il progetto stava perdendo la sua ragion d’essere è anche perché gli ascoltatori di sempre, giustamente, a un certo punto si erano anche rotti le balle. Chissà se Sanremo ha riacceso l’affetto oppure no. Alcuni mi hanno scritto dicendosi molto contenti per me, ma c’è stato anche chi sosteneva che non verrà mai più a un mio concerto, perché non vuole mescolarsi con chi non conosce i miei primi album (ride). Tutte istanze comprensibilissime, per carità. Io sono il primo a non essere sicuro che andrei a un concerto di Dargen D’Amico. Non mi sono ancora fatto un’idea chiara su quello che mi piace. Forse preferisco la musica strumentale.
Mi verrebbe da dire che sei logisticamente obbligato ad andarci, ai tuoi concerti.
Sì, ma se non fossero miei, non so se mi ascolterei. Per me avere uno spazio sicuro in cui scrivere è stato un’ancora di salvezza, mi ha generato una sorta di obbligo a cercare di stare bene, ma è molto complesso giudicarsi dall’esterno. Tornando al discorso di prima, comunque, credo che la spinta fortunata di questa canzone si esaurirà, prima o poi. Con i tempi che corrono, oltretutto, non sta scritto da nessuna parte che se ti piace un pezzo, ascolterai anche un album intero di chi lo canta. Oggi il rapporto con un artista può limitarsi anche solo all’inserimento di un suo brano nella tua playlist.
Vero, ed è vero anche che forse non tutti lo hanno capito fino in fondo, Dove si balla. Quasi nessuno, ad esempio, ha colto il tema dell’immigrazione che è nascosto in piena vista in molti dei versi della canzone. “Tra i rottami, balla / per restare a galla / negli incubi mediterranei”; e poi ancora “Che brutta fine, fermi al confine / la nostra storia che va a farsi benedire”, “Non si può fare la storia se ti manca il cibo”…
Però in fondo è umano trovare ciò che si cerca, in una canzone e in tutto il resto. Se sai già cosa stai cercando, è difficile che tu veda altro. Il brano ha un’innegabile allure da trenino di capodanno: sicuramente è stato quello che ci ha fatto divertire così tanto quando eravamo in studio a registrarlo, ma tende un po’ a mascherare il resto. Al di là di questo, credo che obbligare le persone a individuare tutto ciò che ho inserito nella canzone sia pretendere troppo, anche perché io stesso non sono sicuro di individuare quello che gli altri artisti inseriscono nelle loro. L’importante è sentire il bisogno di ascoltarle, anche quando lo si fa con il proprio punto di vista, con la propria forma mentis.
Tornando alla prima spinta che ti ha portato sul palco dell’Ariston: come ti senti a poter tornare finalmente a suonare dal vivo?
Molto bene, devo dire. Per me era molto complesso immaginare di riprendere a suonare, prima di Sanremo. E non salire su un palco per così tanto tempo è come stare per molto tempo da solo: è difficile saltare di nuovo in sella e riallacciare rapporti, dopo. Non essendo più un ragazzino, so che se voglio continuare non devo smettere, devo cercarmi attivamente le occasioni. Quindi ricominciamo in punta di piedi, compatibilmente con la situazione, ma con l’intenzione di andare avanti.
Come vedi la situazione dei live?
La vedo esattamente com’era prima: non mi sembra che abbiamo ancora ricevuto segnali chiari, a livello istituzionale e strutturale. Le cose cambieranno quando chi di dovere prenderà delle decisioni in merito, ma non credo accadrà né in primavera, né in estate. Forse, con il rientro nei ranghi autunnali, avremo finalmente qualche risposta.