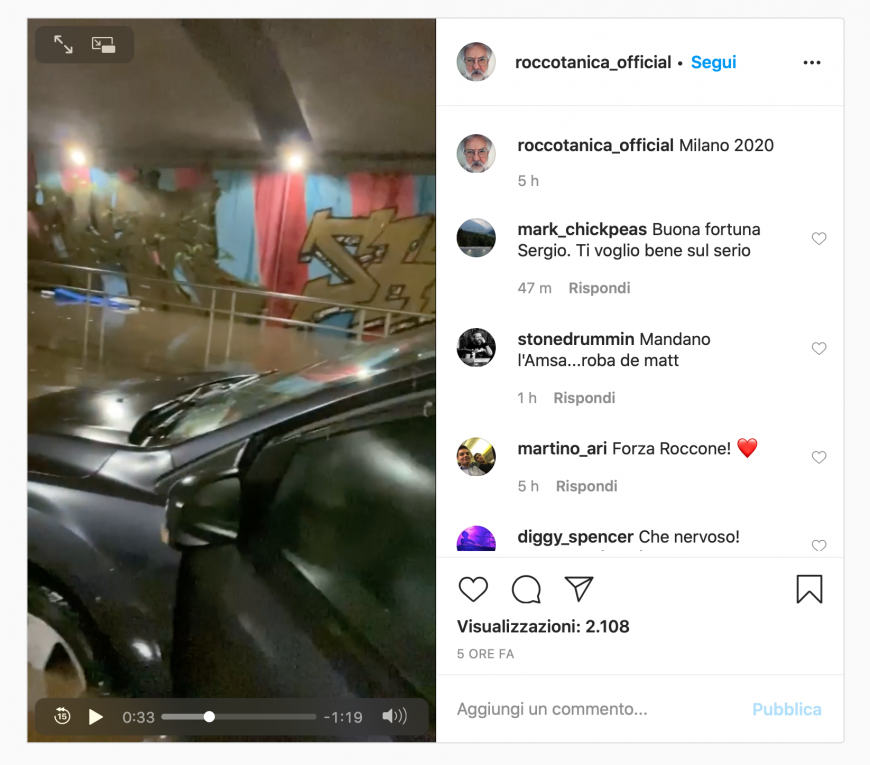Rocco Tanica ha pubblicato il suo terzo libro. Si intitola Non siamo mai stati sulla Terra ed è di fatto un lungo dialogo filosofico tra la sua scrittura e quella semi-automatica di un’intelligenza artificiale. È il primo esperimento letterario italiano di questo tipo. Le due voci narranti, una stampata in carattere serif e l’altra in bastoni, ma non certo priva di grazia, si ispirano a vicenda, si contendono l’attenzione e l’ammirazione del lettore, si afferrano e si lasciano andare come acrobati della sintassi nel circo che hanno messo su insieme a una compagnia di antichi egizi, bambini ragno, donne con gli occhi a lucciola e surrealisti russi.
Il libro comincia con una falsa partenza (da Milano a una Milano immaginaria, fondata nel 1831, a detta della macchina scrivente, dal magnate tessile Giovan Battista Milano) e si conclude con uno strepitoso manifesto poetico sul concetto di nascita, che segue immediatamente la morte a sorpresa di un sicario. Sono talmente tanti i picchi qualitativi del libro che è più sintetico citarne uno quantitativo: la brevissima ricetta per fare le foglie, che funziona come un pezzo di bravura di prosa ritmica oppure, per farla breve, proprio come una poesia.
Col Maestro Tanica abbiamo parlato di tutto questo, di podcast, di televisione, di social e del suo ultimo concerto con gli Elio e le Storie Tese.
Un breve disclaimer: nel corso di questa intervista potremmo essere colti da desiderio di emulazione. È lo stesso che succede con le onomatopee pistolere che volano dentro casa quando rientri dalla visione di film western. Dopo 272 pagine di Non siamo mai stati sulla Terra non vorresti fare altro che sparare metafore saggistiche a sfondo surreale.
Tra l’altro nel libro c’è qualche neologismo a sfondo Far West: “film a orientamento cauboide”. Spero sempre che un giorno l’Accademia della Crusca scriva di parole come questa: “Non accettabile nella versione… bla bla bla… anche se se ne attestano casi illustri come in Non siamo mai stati ecc…”.

Donna olandese controlla i messaggini. © Rocco Tanica 2022
Per iniziare come si deve, sia citandoti che paragonandoti a Dio (cfr. “Intervista a Dio o come vattelappesca si chiama”, p. 139): preferisci cominciare con la domanda che abbiamo preparato o hai un tuo tema preferito?
Dato che ho appena scoperto dalla tua viva voce che “vattelappesca” si scrive con due “p” e non con una come ho fatto nel libro – e che quindi dovrò mandare al macero migliaia di copie – vai con la domanda che hai preparato.
Molte opere d’ingegno sincere partono da una difficoltà di fondo ad accettare la realtà per quella che è. Ci sono ad esempio dei romantici che la migliorano apposta o degli umoristi che la peggiorano per esigenze di copione. Tu che rapporto hai avuto con la realtà scrivendo questo libro?
L’intenzione non era tanto migliorarla o peggiorarla quanto proporne una mia interpretazione. Mi interessa la teoria degli universi paralleli, mi piace l’idea che ne esistano di vari e distanti: alcuni plausibili e confortevoli, altri fantastici o visionari, persino disturbanti. Credo che la normalità degli uni esalti la particolarità degli altri. La normalità rende più sensibili alle novità sconcertanti, e l’abitudine allo sconcerto rende la normalità qualcosa di consolatorio. Ho sempre amato saltare da una parte all’altra dell’argine, sperando di non finire nel fiume. Lo facevo anche da ragazzino, nei temi: le professoresse più illuminate mi facevano i complimenti e quelle più rigorose me lo segnavano come errore.
Abbiamo capito un po’ meglio la tua poetica mentre rileggevamo il tuo lavoro con in sottofondo un disco di Chopin nella cui copertina il pianista, enorme e bellissimo, si prendeva tutto lo spazio a disposizione, mentre il compositore era un polacchino microscopico evocato solo da una scritta con un font neanche tanto eccezionale. Il pianista si chiamava Benjamin Grosvenor, come la piazza superlussuosa di Londra: chiaramente un nome falso dei tuoi, se non fosse stato verissimo. L’epifania sta nel fatto che tutto ciò non era meno assurdo di una tua descrizione del passato fantastico, urbanisticamente glorioso, di Asti (cfr. “L’impiant Fantàsdch”, p. 39). La domanda è, infatti, parafrasando Pablo Picasso: se il mondo non ha senso perché scrivere saggi che ne hanno?
Credo che il mondo abbia parecchio senso. Talvolta espresso in brevi momenti di bellezza, talvolta attraverso storture, emergenze, aberrazioni. Non cerco di fuggire dalla realtà, ma di darle un colpo di pennello, una botta di colore. Lo abbiamo fatto tante volte in musica con gli Elio e le Storie Tese, rileggendo il pop contemporaneo (per il quale non è che avessimo una passione sfegatata), il jazz-rock, la disco, cercando di fornire una nostra versione dei fatti. Mi fa piacere poterlo fare anche nella scrittura, dove con la realtà mi faccio i fanghi: ci sto dentro, ci sguazzo; dopo un po’ sento gli effetti benefici ma anche la puzza di zolfo.
Sei riuscito a forgiare l’anello di congiunzione tra il saggismo – cosa confermata dal fatto che l’editore qui è il Saggiatore – e la demenzialità – cosa confermata dal fatto che ridiamo dall’inizio alla fine come ascoltando una tua canzone. E lo hai fatto anche facendoci anche commuovere a metà strada, mannaggia a te, come con la storia di quel cavolo di cavallo Giacomo (cfr. “Il cavallo Giacomo”, p. 127). Ne riportiamo l’incipit a beneficio dei lettori: “C’era una volta, tanto tanto tempo fa, un cavallo chiamato Giacomo che viveva nel villaggio di Prato Séttile. Giacomo era benvoluto e ammirato da tutti per il suo temperamento mite e l’incedere personalizzato. […] La coda candida creava un mirabile contrasto con il corpo color cavallo”.
Oh povero cavallo Giacomo! Simpatico e bonaccione. Ho pianto anch’io. Mi sono commosso anche per una delle mille trovate dell’intelligenza artificiale. Nel capitolo “L’uomo d’alabastro”, quando per il tizio geneticamente mutato si mette male e arriva questa figura compassionevole, la “donna nera”. L’ha battezzata così la macchina, o almeno credo; mi diverte e mi spaventa al tempo stesso dover avere il libro davanti per ricordare chi ha pensato cosa.

Due amici e un’amica si ispirano a Elvis. © Rocco Tanica 2022
A chi immagini sia rivolto questo libro?
Ho scritto per me stesso e per quelli che mi fermano per strada dopo aver letto il mio precedente (Lo sbiancamento dell’anima, ndr) e mi dicono: «Mi è capitato di leggerti in momenti di allegria e l’allegria è aumentata. Ti ho letto in momenti di tristezza e l’umore mi è migliorato. Ho letto quelle pagine e ho ricordato un luogo in cui andavo in vacanza; ho letto quelle altre e mi sono commosso pensando a mia nonna». Mi rifaccio a un collega musicista, Georg Friedrich Händel, che diceva: «Scrivo musica perché la gente si senta meglio dopo averla ascoltata». Scrivendo spesso divago e mi soffermo su dettagli apparentemente non necessari. Lo faccio, 1) perché non so controllarmi, 2) perché vorrei che il libro fosse fruito a strati: la prima volta badando all’orecchiabilità, la seconda volta al carattere dei personaggi, e via dicendo; proprio come nei videogiochi in cui devi sbloccare varie abilità – destrezza, potenza, carisma – a mano a mano che procedi. Vorrei che l’esperienza del libro fosse differente di volta in volta per chi avesse il desiderio o il coraggio di rileggerlo. Il libro come una casa dove sono tutti, o quasi, benvenuti: qualcuno si troverà bene a piano terra, qualcuno in mansarda, altri si spingeranno – a proprio rischio – in cantina.
Quali sono state le tue fonti di ispirazione letteraria nello scrivere questi testi?
Esco pazzo per Italo Calvino. Certo non posso aspirare a tali altezze, ma credo che si debba copiare da quelli bravi, non dalle mezze seghe. In Calvino la ricchezza del vocabolario, la musicalità delle frasi, la costruzione dei personaggi sono inarrivabili. Leggerlo equivale a un massaggio al cervello. Voglio citare anche il collega Maurizio Milani, che considero il mio maestro di “scrittura malata”. E infine è stato importantissimo il surrealista Daniil Charms, tant’è che il libro all’inizio avrebbe dovuto intitolarsi, a mo’ di dedica, proprio Surrealismo russo; quello poi è diventato un singolo macro-capitolo, gli argomenti sono aumentati di numero e ho cambiato il titolo.
Che metodo di lavoro hai usato nello scrivere ed editare i tuoi testi e quelli della macchina?
Questo libro l’ho scritto in cinque o sei mesi e ho impiegato almeno un anno per correggerlo. ShortlyAI.com (la piattaforma che ho scelto, una delle tante che utilizza il modello di linguaggio GPT-3), nel produrre nuovo testo tiene conto solo dei 3500 caratteri precedenti. Esempio: parti scrivendo che ci troviamo a Parigi di notte; poi aggiungi – diciamo – 4000 caratteri. La macchina, quando sarà il suo turno di scrivere, non “ricorderà” più il paragrafo della notte parigina in quanto troppo distante, e magari proporrà una scena nuiorchese in pieno giorno. Durante i primi esperimenti, quando non mi era ancora del tutto chiaro il funzionamento, inserivo degli input molto brevi: titolo e poche righe. La macchina, conoscendo poco del contesto, rispondeva con scemenze improbabili, da cui quel senso di “disconnessione” e vertigine tipico di Charms. Per me alcune di quelle scemenze erano particolarmente divertenti, alla fine molte le ho tenute. Insomma, di necessità virtù.
E poi, quando tu e la macchina vi siete capiti meglio?
I capitoli dall’italiano più fluente, come quelli dedicati alle fiabe, sono nati dopo aver nutrito il sistema di intere pagine già edite: brani di racconti di Buzzati, Pavese, Calvino e altri. La macchina non copia concetti o vocaboli degli scrittori ma ne acquisisce i modi e lo stile, usandoli come propellente. Per il capitolo dedicato agli haiku (che sono tutti opera della macchina) ho inserito nel sistema una cinquantina tra haiku autentici, belli e poetici, e altri un po’ coglioni inventati da me. Il risultato è quel misto di versi seriosi e ispirati e di altri idioti (come: “CASA AVITA. Al vento / sbatte la finestra / il nonno sacramenta“). L’intelligenza artificiale lavora attraverso calcoli probabilistici: se scrivi “il cielo è azzurro, le nuvole sono…”, lei proseguirà più probabilmente scrivendo “bianche”, e non “metalliche”. Ma che scriva “metalliche” è possibile, anzi molto frequente, e ciò rende il processo imprevedibile, non è quasi mai “buona alla prima”. C’è una funzione che si chiama rewrite – appunto ripeti, riprova – che ho dovuto e voluto utilizzare molto spesso.
Cosa che del resto avviene anche nella scrittura non semi-automatica.
Esattamente. Se la macchina va a cazzo di cane io posso decidere di tagliare oppure tenere. È capitato che paragonasse l’epica del Far West a “Quando nel Guglielmo Tell di Rossini il dimostratore di macchine a vapore Roberto Risso si produce in un rombo d’orgoglio“; io ho riso molto e ho pensato fosse un’immagine meravigliosa.
Comunque, al di là di questi affascinanti tecnicismi che rifondano nel 2022 la scrittura automatica dei surrealisti della prima ora; al di là anche dell’accortezza tipografica di distinguere nei font il tuo testo e quello della macchina, ciò che il lettore esperisce è OutOmat-B1 come metafora del tuo cervello, cioè il cervello di un autore con la battuta pronta e con l’ipertesto facile. Il lettore può fondere i due narratori in un uno solo, perché anche laddove ci sia un forte contrasto di natura surrealistica tra la realtà – te – e la finzione – la macchina – quel contrasto non è stridente se non quanto ci si aspetti che strida un testo, appunto, dichiaratamente surrealistico.
C’è stato un dibattito con i tre diversi editor che si sono succeduti nel lavoro sul libro. In principio pensavamo di lasciare alla fantasia del lettore il compito di immaginare chi avesse scritto cosa, tra me e la macchina. Alla fine ha prevalso l’idea di distinguere le due voci usando due caratteri tipografici lievemente diversi, permettendo al lettore di distinguere le differenze solo se lo desidera, altrimenti di lasciarsi andare al flusso narrativo.

Il vinile preferito di Jackie Chan © Rocco Tanica 2022
Tra i temi portanti di questo libro ci sono l’orrore della normalità, l’ansia da intrattenitore, il no alla competitività moderna, il sì al calcio quattrocentesco, le amicizie improbabili, gli amori impossibili, la fratellanza davanti alla morte, l’ironia che aiuta a superare il dolore. Sembri voler dimostrare per assurdo, ancora una volta, che non esista saggismo che non sia comunque profondamente autobiografico. Non siamo mai stati sulla Terra è un tuo ritratto non meno veritiero di quello che hai prodotto nella tua reale autobiografia?
Ti detesto perché sì, è così, e non ci avevo mai pensato. Sono colpito da questa affermazione, come uno che si prende un inaspettato cazzotto. Sono numerosi i tratti ricorrenti, lo noto solo ora. L’amicizia confermata o tradita, il rapporto con Dio – che esista o meno –, lo sfottò della morte e la paura della morte, l’amore per le fiabe non per forza a lieto fine. C’è tutto, e riaffiora come in una seduta dallo psicologo; tra l’altro così risparmio cento euro a botta.
Sono tanti i personaggi di questo libro che non dimenticheremo facilmente. Come il sicario del sicario, il metasicario che, pur professando la sua dottrina di ascolto e attesa (“L’ascolto determina la gerarchia delle urgenze; l’attesa ha lo scopo di renderlo evanescente, spettrale. Questa è la specialità del sicario, la sua grazia. Egli non è mai intempestivo o affrettato”), non ha ascoltato né atteso il suo, di sicario, che lo coglie alle spalle, in un chi la fa l’aspetti tra realtà e finzione, o tra due livelli di finzione. A quale dei tuoi personaggi pensi o temi di somigliare di più?
Veramente ti odio. Mi hai beccato di nuovo. Penso di essere quello che alla stazione tira i sassi alla morte per farla scappare. Ma anche entrambi i contendenti che si ingarbugliano con le parole al punto di perdere di vista il loro obiettivo, cioè un duello.
Quasi tutti?
Beh, di certi personaggi sono contento di fare solo la descrizione, come il bambino calciatore grande obeso Porfirio Cancellini.
Tra tutti i livelli di significato del tuo scritto, tra cui dobbiamo ammettere che ci è piaciuto perfino quello anagogico, il migliore in assoluto è quello letterale. Ma il suo titolo stesso è annuncio di un combattutissimo derby tra realtà e finzione. Noi tifavamo come ultrà per il pareggio. Chi ha vinto alla fine?
Aspetta, devo cercare il significato di “anagogico”. […] Okay, per questa risposta aspetto di incontrare per strada il lettore di prima. A me piace l’idea del pareggio. Ho un riferimento cinematografico che continua a influenzarmi dopo trent’anni: Forrest Gump. Quel film mi ha sempre affascinato per come riesce a creare collegamenti plausibili tra elementi lontanissimi tra loro: ad esempio l’apparecchio ortopedico di Forrest bambino che ispira le mosse pelviche di Elvis. La narrazione è fatta di incastri tra elementi di fantasia ed elementi reali. L’episodio del libro in cui mi colloco da imbucato alla festa di compleanno di David Bowie nasce da questo.
Questo concetto è presente anche nelle tavole che illustrano il libro, che sembrano la versione glorificata, da museo, dei fotomontaggi che pubblichi su Instagram, in cui ti photoshoppi a mo’ di artista o committente di pala d’altare dentro la pala d’altare dell’attualità.
Ci tengo a dire che sono immagini del tutto sintetiche, non photoshoppate ma realizzate con un’applicazione grafica dell’intelligenza artificiale. Sono ottenute inserendo nella macchina sinossi o parole chiave dei capitoli di riferimento e uno spunto sullo stile rappresentativo da usare: che so, Cappuccetto Rosso, Canaletto, John Constable, colori a olio o foto anni ’60 in bianco e nero.
Quando il mostro Gaele, nell’introduzione al capitolo sul panico, esegue l’incantesimo di affiatamento e confidenza, non abbiamo potuto non pensare a Dungeons & Deejay e all’esperienza del tuo alter ego MORBEGNIO PEERLA LEGALITÀ.
Forse si è trattato di involontaria autosuggestione (mia).

Nigel, il flautista dei Kiss. © Rocco Tanica 2022
Tornerai nel mondo dei podcast? È una dimensione che ti interessa?
Si sta parlando di una seconda stagione di Dungeons & Deejay. Per quanto riguarda il mezzo utilizzato: il podcast per me esisteva già negli anni ’70, quando registravo l’audio delle puntate di Alto Gradimento per riascoltarle a piacimento. Per questo oggi non ci vedo miracoli di tecnologia o di comunicazione. Per me il podcast è semplicemente radio in differita della quale si possono ottimizzare i tempi e i modi, soprattutto grazie all’ingegno e alla cura di un conduttore che una visione chiara e col vento in poppa come Francesco Lancia.
Sembri un umanista rinascimentale perché declini la tua idea del mondo attraverso un numero imprecisato di mezzi e contesti, di volta in volta di massa o di varie nicchie. Come fai a essere sempre Rocco Tanica perfino in ciascun fotogramma della Dottoressa Giò?
Forse sono come Abatantuono, che è Abatantuono sempre, anche in un costume del ‘700. A parte gli scherzi, riguardo alle mie prove attorali, delle due l’una: o riesco a mettere qualcosa di mio in ogni cosa che faccio o sono semplicemente un cattivo attore. A me non dispiace andare a copione quando sento che il materiale è solido: mi è successo in particolare lavorando alla serie La compagnia del cigno di Ivan Cotroneo, dove faccio l’insegnante di violino al Conservatorio di Milano. Ma mi è capitato spesso anche in musica: ho partecipato a diversi dischi imprevedibili, da Pierangelo Bertoli a Demis Roussos, in cui facevo solamente il pianista-tastierista seguendo le istruzioni dell’arrangiatore/produttore. Morale: se non ho il controllo totale su quello che faccio non mi dispero; mi va bene mettere le mie capacità completamente a disposizione degli altri, purché mi fidi davvero di loro.
Deve essere per via di una parola oggi non tanto di moda: professionalità. Non ami improvvisarti. Tornerai in televisione?
Potrebbe esserci una seconda serie, da autore, del programma Michelle Impossible di Michelle Hunziker, una che ha le idee chiarissime ma, al contempo, è un’entusiasta che si lascia conquistare dalle idee altrui. Lavorandoci ho scoperto che canta bene, balla bene e mi fa spaccare dal ridere. Scrivere, che so, un numero canoro per lei e Ilary Blasi non è qualcosa che mi sarei aspettato di fare. Però, quando mi sono trovato con loro, la cosa è venuta fuori senza sforzo.
E che novità ci potrebbero essere per le altre arti in cui sei versato?
Ogni tanto penso che mi piacerebbe organizzare una mostra di immagini sintetiche come quelle contenute nel libro. Ci sono però degli egregi concorrenti in termini sia quantitativi che qualitativi. Per ora mi piace molto stare col computer in mano, a scrivere, magari su una panchina in un parco o a letto, col gatto che mi cammina addosso.

La redazione del giornale musicale. © Rocco Tanica 2022
Sui social media una parte – predominante per Instagram – della tua linea editoriale ricorda in pillole il terreno surreale ma ficcante, tagliente ma in pace con sé stesso, su cui ti muovi in questo libro. Un’altra parte – riversata su Twitter – non disdegna di entrare in polemiche.
Sì. Tempo fa ho dato del coglione a Mimun rispondendo a un suo tweet che conteneva una puttanata stellare; l’ho fatto senza motivare. Poi ho cancellato e riformulato, precisando che se Mimun intendeva il concetto A okay, era perdonato; se intendeva il concetto B, confermavo il primo tweet.
Da dove viene fuori questo Rocco, che qualche volta non mantiene il consueto piglio distaccato e britannico che notoriamente lo contraddistingue?
In genere i post un po’ rissosi sono il risultato dell’ira del momento, che fatico a contenere. Così faccio la cosa che fanno molti sciocchi, al pari di me: litigare su Twitter, che è diventato un luogo di cattiveria e ignoranza oceaniche. Ha abituato le persone a formattare temi sensibili in 140 caratteri. Ogni concetto enunciato è indebolito dalla brevità dell’esposizione, così come le possibili repliche. Alla fine è il quadro generale a scomparire nel rumore di fondo. Comunque sia non mi risparmio quando leggo cose imperdonabili scritte da persone spregevoli. Il periodo in cui sono stato più attivo in questo senso è stato durante il Covid pesante: frequentavo pagine di negazionisti con centinaia di migliaia di follower per trollarli fingendomi d’accordo con loro. Li ringraziavo per i consigli e suggerivo falsi nomi e indirizzi di medici che rilasciavano certificati tarocchi di avvenuta vaccinazione. Tali medici non esistevano – almeno quelli che mi ero inventato – ma adoravo l’idea che qualche coglione partisse alla ricerca. Preferisco Instagram perché lì in genere le persone hanno un nome e un cognome, anche se spesso è un nome d’arte, come nel mio caso; almeno non si tratta dei milioni di account anonimi di Twitter.
Ti va di chiudere parlando dell’ultimo concerto di quest’estate a Bergamo?
Il principale motivo che mi ha indotto a lasciare le scene pubbliche nel 2013 è stato di natura neuro-psichiatrica. Sono diventato claustrofobico e agorafobico insieme. In questi anni i miei colleghi sono stati molto protettivi nei miei confronti, tenendomi il posto e attendendo i miei tempi di recupero. Non potrò mai essere grato a sufficienza ai miei “parenti” di Elio e le Storie Tese per come mi hanno tutelato. Ed è stata proprio questa semplicità di approccio che mi ha consentito di risalire sul palco di Bergamo senza patemi. Quella sera non ho patito. Un po’ perché loro hanno fatto la parte dura del concerto – due ore e mezza – e io venti minuti. Mi sono trovato a mio agio in un ambiente da famiglia allargata che comprendeva gli 8000 in festa giù dal palco. In festa perché era la loro e la nostra festa, che vantava oltretutto la solidissima causa promossa dal Trio Medusa, il sostegno ai profughi ucraini.