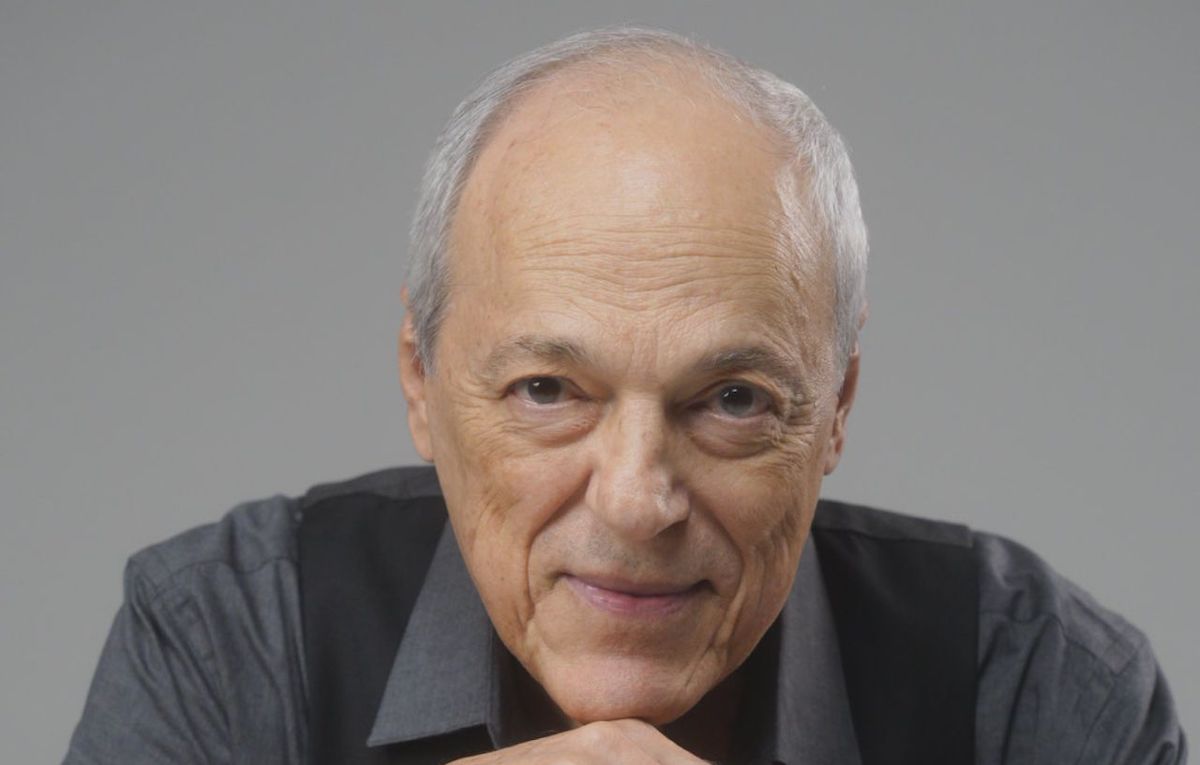Se Terraforma è diventato un festival di culto, se un evento che si indirizza a della musica abbastanza esoterica (la techno più intellettuale, la sperimentazione più ardita, le destrutturazioni più sistematiche, la contaminazione più imprevedibile) è riuscito a farsi amare da così tante persone da diventare perfino appetibile per i grandi marchi della moda come partnership e da vantare un pubblico profondamente internazionale (una rarità, in Italia), è merito di come sono state fatte le cose in questi anni.
Parlare con Ruggero Pietromarchi, che il festival l’ha creato e cresciuto via via con l’aiuto di sempre più persone, restituisce veramente un quadro chiaro e nitido dell’attitudine-Terraforma. Un’attitudine che sa anche essere senza filtri: perché in una storia di crescite e successi, anche le parziali battute d’arresto (come in parte accaduto l’anno scorso) non vengono nascoste. Presentando l’edizione 2023, che si terrà dal 9 all’11 giugno come sempre alle porte di Milano, a Villa Arconati, saltano fuori a ruota libera molte considerazioni significative, parlando di passato, presente, futuro. E di istituzioni che continuano maledettamente a non esserci o quasi: un marchio di fabbrica meravigliosamente nazionale.
Anche grazie ad amici in comune, a me è capitato di veder praticamente nascere l’idea di Terraforma, questo prima ancora che la prima edizione si svolgesse davvero. Avendo quindi in mente le origini, anzi, addirittura le premesse del festival, mi viene da chiederti: in tutti questi anni cosa è andato secondo le previsioni? E cosa invece ne è andato al di là? E intendo: al di là sia in positivo, che in negativo.
È un momento molto particolare a livello storico per eventi di un certo tipo. Noi siamo arrivati ormai all’ottava edizione: ti dirò, quello che più mi ha colpito è come sin dall’inizio siamo riusciti a comunicarci ed imporci con un profilo ben definito, riuscendo a mantenere costante questa caratteristica. Tant’è che in uno spazio di tempo relativamente limitato, perché otto anni per un festival non sono così tanti, siamo riusciti a farci una nomea importante. Poi tra le cose di cui andare orgogliosi c’è sicuramente il nostro pubblico, la community che si è formata. Una community molto internazionale: ed anche questo è un traguardo non semplicissimo da raggiungere per un festival italiano. È community parecchio interessata alla musica ma lo è in un modo sano, che si accompagna cioè ad un grande senso di condivisione e di rispetto degli spazi in cui il festival si svolge. Le direttrici che abbiamo scelto sin da subito (una musica soprattutto sperimentale ed una grande attenzione alla sostenibilità ambientale) non sempre sono facili da “leggere”: se non sei bravo a veicolarle e realizzarle, possono dare adito a molti fraintendimenti. Invece, mi pare proprio sia stato tutto capito alla perfezione. Ma tu vuoi sapere anche cosa non è andato perfettamente bene, in questi anni…
Ma guarda: non per forza quello che non è andato bene, anche solo quello che è andato contrariamente alle aspettative. Magari pure in positivo, eh.
No, no: parliamo invece di cosa non è andato nel modo giusto. È importante parlarne. Allora: il primo problema, e questa risposta l’avrai già sentita tantissime volte, è il contesto italiano.
Effettivamente non è una risposta che mi suona inedita…
Un contesto che fa grandissima fatica. Detto onestamente: dopo tutti questi anni, dopo tutti i riconoscimenti e i risultati raggiunti, ci saremmo aspettati decisamente un po’ più di supporto dal punto di vista istituzionale. Supporto che invece non è arrivato. E, sinceramente, non credo arriverà mai.
Mai? Drastico.
Ma sì. Del resto le istituzioni stesse sono sempre più in difficoltà, sempre più in crisi, dura aspettarsi qualcosa in più da loro. Non sto puntando il dito su qualcuna di loro nello specifico, è proprio un discorso generalizzato. Però il dato di fatto è innegabile: in Italia chi fa cose di un certo tipo è lasciato allo stato brado. E questo rende le cose molto difficili. Perché finché hai 25 anni non ci pensi e ci metti tutta la tua passione e la tua energia, e va bene; ma quando di anni inizi ad averne 35, qualche domanda te la fai. Sai, ci terrei a sottolineare che le difficoltà di organizzare un festival particolare come Terraforma sono notevoli – e tra l’altro sono difficoltà che, se non si è proprio addetti ai lavori, non è così immediato percepire. Per intenderci: Terraforma si svolge all’interno di un bene architettonico storico come Villa Arconati, no? Ecco. Questo significa doversi rapportare di continuo con la Soprintendenza ai Beni Culturali, e significa non poter piantare nemmeno un palo per terra, per allestire. Tutto questo in un luogo che, di suo, non è in alcun modo attrezzato: non c’è corrente, non c’è acqua, non c’è internet. Li dobbiamo portare noi. Facendo comunque attenzione ai limiti di cui prima. Questo si traduce, molto semplicemente, in costi di produzione straordinariamente alti. Molto più alti rispetto ad un evento standard. Ci sta che questo il pubblico non lo veda, non lo sappia, non lo consideri: giustamente quello che a lui interessa è il risultato finale. Ma noi, che in mezzo a questi problemi ci siamo da sempre, abbiamo iniziato a farci delle domande.
Ovvero?
Da un lato le uniche forme di sostegno sono quelle che generi tu stesso, ovvero la biglietteria, il bar, il grande lavoro nelle partnership con gli sponsor, ricade tutto su di te; dall’altro devi avere a che fare con delle difficoltà pratiche ed operative che sono molto sopra la media. Non ti nego che tutto questo ci sta facendo riflettere molto, sull’eventualità di trasformare il festival.
Mi stai dicendo che state prendendo in considerazione l’idea di lasciare Villa Arconati, la vostra location fin dagli esordi?
Certo. Assolutamente.
Siete rimasti un po’ scottati anche dall’esperienza dell’anno scorso? Per chi non c’era: è stata una edizione di grandissimo successo numerico, ma proprio questo successo – soprattutto il primo giorno, poi le cose sono decisamente migliorate – ha creato non pochi problemi logistici: file all’ingresso mai viste prima, problemi continui ai pagamenti elettronici, code infinite ai punti ristoro…
L’anno scorso, soprattutto il primo giorno, è stato traumatico un po’ per tutti: a partire da noi che il festival lo creiamo. Perché appunto: è un progetto che nasce prima di tutto dalla passione, dalla voglia di seguire traiettorie ben precise. Quindi è un festival che almeno ci dovrebbe dare tanta soddisfazione morale. Se però ci metti dentro tanto impegno e tanto lavoro e quello che ti torna indietro è solo merda, beh, allora diventa dura. Sicuramente quella dell’anno scorso è stata una edizione molto, molto complessa. Era quella del ritorno post-Covid, il che significa che c’erano grandi aspettative da parte di tutti. Non averle pienamente soddisfatte è stato traumatico. Ci sono state delle sfighe molto concrete: il sistema dei pagamenti on line che in certi momenti è crollato, e già questa da sola è una difficoltà enorme, ma poi è anche successo che pochi giorni prima dell’inizio del festival abbiamo scoperto – non ci era stato comunicato – che c’erano stati dei lavori alle tubature di Villa Arconati, con la conseguenza che non era possibile garantire (come invece era sempre stato fatto in passato) acqua potabile a tutti. Il fatto poi che fosse una edizione post-Covid, dopo una serie di stop forzati nei due anni precedenti, ha tra le altre cose fatto sì che le presenze complessive fossero diventate per forza almeno un migliaio in più: perché non potevi lasciare fuori quelli che avevano comprato il biglietto per le edizioni precedenti che non si erano svolte. Questo ha generato una notevole pressione antropomorfica. Noi per primi ci tenevamo a fare un festival riuscito: abbiamo fatto una campagna promozionale molto convinta ed aggressiva. Risultato? Alla fine ne siamo usciti piuttosto scottati. Esausti noi, e in parte scontente le persone che sono venute al festival.
Vero.
Ma quest’anno vogliamo andare nella direzione esattamente opposta.
In che modo?
Lo spunto nasce da un libro uscito un paio d’anni fa, Organic Music Societies, edito da una casa editrice di New York, la Blank Forms. Libro dove si parla della grande storia d’amore, ma anche avventura artistica ed esistenziale, del grande jazzista Don Cherry con la sua compagna Moki. Anni ’70, Don fugge da New York per scappare anche dal giro dell’eroina, e nel suo girovagare si innamora di Moki, giovane visual artist svedese. Assieme fondano una comune in campagna dove iniziano ad organizzare workshop, concerti, performance, installazioni: è uno dei momenti più interessanti e particolari della carriera di Cherry, che pure aveva avuto già prima vette eccezionali. È in quel momento che si apre come non mai ad altri mondi, creando scintille artistiche sorprendenti. Ecco perché nel cartellone di Terraforma 2023 ci sono The Master Musicians Of Jajouka, che con Cherry hanno proprio collaborato, o il progetto di Beatrice Dillon col grandissimo maestro di tabla Kuljit Bhamra, perché lo stesso Cherry si era incuriosito tantissimo della musica indiana in quegli anni. Ecco: tutta questa esperienza è stata la suggestione più forte per pensare al programma di Terraforma 2023. E non è solo questione di line up musicale, perché un centro nevralgico del festival sarà il Dome, una struttura geodetica molto particolare che ricalca esattamente quella che Don e Moki avevano fatto costruire all’interno di un museo a Stoccolma, museo che aveva loro affidato nel 1972 una residenza artistica di tre mesi dando carta bianca assoluta: loro ne approfittarono per trasportarci dentro tutta la loro comune, e ricreare incontri, simposi, pratiche quotidiane… È così che dentro il “nostro” Dome, ci sarà tutto quello che nell’edizione dell’anno scorso volutamente non avevamo messo: talk, workshop, panel…
Ecco, questo mi interessa: perché li avevate tolti? Erano sempre stati un momento molto connotante dell’esperienza-Terraforma…
Toglierli era stata una precisa dichiarazione d’intenti. Per due anni c’avete tolto la possibilità di stare insieme, assembrarci, ballare (che poi bisognerebbe parlare di questa demonizzazione del ballo…)? Bene! Noi faremo allora esattamente questo e solo questo, ora che finalmente possiamo tornare a fare il festival!
Ha senso.
Quest’anno chiaramente la situazione è ovviamente diversa, non c’è più bisogno di dichiarazioni d’intenti di un certo tipo e siamo tornati a concentrarci su un’offerta che avesse una forza ed un significato a trecentosessanta gradi. Ci siamo confrontati molto con la nipote di Don e Moki, Naima (figlia di Neneh Cherry, ndi), che tra l’altro si esibirà anche al festival. L’attenzione era ed è quella a non fare qualcosa che sia noioso, didascalico… troppo didattico insomma. E per essere sicuri di fare le cose a modo, abbiamo anche rintracciato l’architetto che aveva costruito il Dome originario nel museo di Stoccolma, un incredibile architetto fricchettone svedese plurisettantenne, chiedendogli consigli ed indicazioni (e coinvolgendolo nella nostra classe che curiamo alla Domus Academy). C’è insomma il suo contributo fondamentale nel costruire il Dome di Terraforma così come lo vedrete; ma ci sarà anche quello di Matteo Ghidoni di Salottobuono, o del designer Enzo Mari. È un lavoro collettivo.
Ma esistono in Italia delle realtà simili a quella che era la comune di Don e Moki Cherry negli anni ’70?
Sono convinto ce ne siano. Non so, mi viene ad esempio in mente l’esperienza notevole di Zuma: un festival a cui non sono mai andato, ma che mi è sempre sembrato incredibilmente interessante e non a caso il suo creatore, Dome della Black Sweat Records (che recentemente ha anche ristampato dischi di Don Cherry: nulla accade per caso), curerà la selezione musicale per la nostra area campeggio.
Ormai l’idea di festival in Italia ha attecchito parecchio, comunque. Se ci pensi, quando tu hai fatto la prima edizione di Terraforma era invece ancora qualcosa di esotico, di strano, di inaspettato. Una terra abbastanza vergine e poco esplorata. Ora invece di festival ce ne sono ovunque, e ne nascono continuamente di nuovi: non è che rischiano di diventare troppi? Rischia cioè di diventare una soluzione troppo inflazionata…
Secondo me, no. Secondo me evviva che ce ne sono tanti di festival, in Italia, sapendo anche le difficoltà che si hanno nel nostro paese ad operare nel campo di un certo tipo di cultura e di musica. Guarda: un paio di settimane fa ero in Belgio, e mentre ero lì nell’arco di un singolo weekend c’erano tipo 6 festival diversi. Capisci? Ora: è vero che creare dei festival e parlare di festival è diventato un po’ un trend, ma stiamo vivendo un momento molto strano per la musica in Italia, almeno per un certo tipo di musica dal vivo, per non parlare poi della club culture che dalle nostre parti sembra quasi completamente morta. Meno male quindi che la scena dei festival è in ascesa. Siamo secondo me ancora molto lontani dalla saturazione.
Però intanto le fee degli artisti stanno schizzando verso l’alto in maniera incontrollata, proprio grazie all’hype attorno ai festival, un hype che gonfia a dismisura il mercato. È un problema che tocca anche voi, o voi operate entro un circuito particolare, diverso da quello dei grandi eventi pop, rock e dance?
Mah: nì. Perché anche noi abbiamo ricevuto delle richieste che, sinceramente, erano fuori dalla grazia divina. Ma lì, molto semplicemente, basta dire «No, grazie». Sì, c’è questo fenomeno della crescita decisa dei costi: fenomeno che in Italia non è sostenibile perché, come dicevamo all’inizio, da noi non c’è il sostegno al settore cultura che c’è in altre parti del mondo e, altra componente del problema, da noi la gente non è abituata tanto ad andare ai concerti – ed a pagare per farlo. Vedi, proprio giorni fa ero in contatto con l’agente dei WITCH – We Intend To Cause Havoc, e lui mi spiegava che ok, manco in America c’è supporto delle istituzioni per un certo tipo di scena, ma almeno la gente ai concerti ci va, paga il biglietto per farlo, e poi sostiene le band facendo incetta del merchandising a fine show. In questo modo il sistema sta in piedi. Da noi, invece, non ci sono le istituzioni a dare una mano e non c’è nemmeno una scena solida e strutturata per quanto riguarda i concerti. Quindi non possiamo andare da nessuna parte. Ma è vero: c’è effettivamente una corsa al rialzo dei cachet degli artisti. Ma noi, semplicemente, abbiamo deciso di sfilarcene.
È possibile farlo.
Sì, è possibile. Anzi, ti dirò di più: è anche salutare per tutta la scena farlo. È un segnale che è giusto lanciare. Non si può crescere all’infinito, questo è il punto. E noi lo sappiamo bene: per non incappare negli errori e nelle criticità dell’anno scorso abbiamo preso una serie di precauzioni, tra cui il ridurre la capienza rispetto all’edizione dell’anno scorso. Vogliamo che il nostro sia un festival sostenibile sotto tutti i punti di vista: anche quello umano, non solo quello economico e quello ambientale.