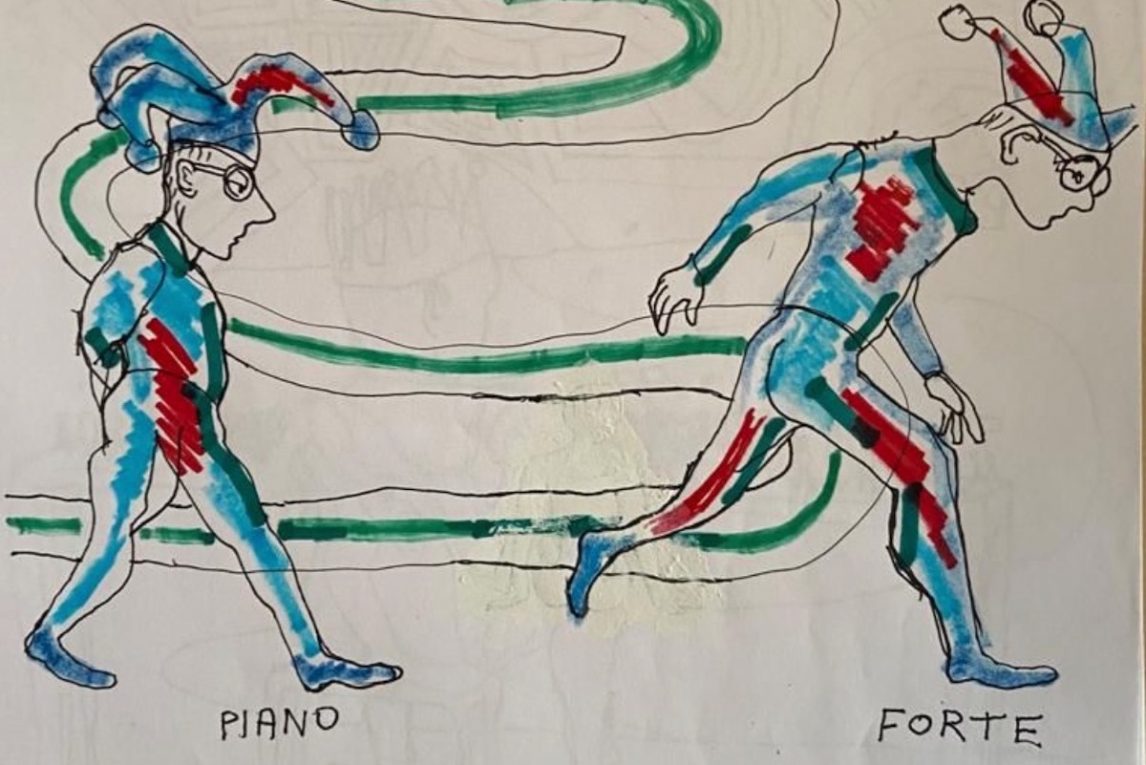In Esterno notte, Aldo Moro si carica sulle spalle un crocifisso, in quella sognante Via Crucis su sfondo di apparato DC (Andreotti, Cossiga, ci sono tutti) con cui affronta la passione che gli è politicamente, esistenzialmente toccata in sorte. In Rapito, è Cristo stesso a staccarsi dal crocifisso, di fronte allo sguardo di un bambino che la passione non sa cosa sia, ma il cui romanzo (di formazione) sarà parimenti un calvario. In entrambi i casi, il martirio è un atto imposto dal credo di qualcun altro: il terrorismo politico, la conversione (correzione) religiosa.
È «l’aspetto terribile e in qualche modo coerente della religione di allora», ha detto Marco Bellocchio, regista di entrambi, che però torna continuamente sulla religione di “adesso”, sulle ore di religione che politicamente, esistenzialmente toccano in sorte a questo Paese, nei secoli dei secoli amen.
L’ora di religione di Rapito – presentato in concorso a Cannes, in uscita nelle sale il 25 maggio – scocca la sera del 23 giugno del 1858. Edgardo Mortara, nato in una famiglia ebrea della media borghesia bolognese, viene strappato ai genitori dalla curia locale. Sostiene, la Chiesa tutta, che è stato battezzato da una servetta secondo i sacramenti di Cristo Nostro Signore, e che dunque deve ricevere un’educazione cattolica. Un rapimento in piena regola, che sconquasserà le due diverse confessioni, e il Papa, la politica, la società del tempo, con tanto di svolta legal in stile processo Dreyfus. Mentre si prepara l’Unità d’Italia, il caso Mortara diventa – in questo film ancora di più – il simbolo di un’Italia condannata a restare disunita.
Bellocchio, lo pensiamo in tanti, è uno dei registi più giovani di questo Paese. «Ho 83 anni e sono ancora vivace, mi piace ancora fare il cinema, l’entusiasmo non mi manca», ha detto l’altra sera a Fazio prima della partenza per Cannes. «Finché c’è questo, e prima la mente e poi anche il corpo funzionano, si può continuare». Si può continuare nell’indagine analitica e psicanalitica che è, da sempre e per sempre, quel suo “fare il cinema”.
Rapito, in questo senso, sfida ancora di più il pubblico. È uno studio documentatissimo tra carte, dispacci, cause e concause, ma anche stavolta attuato secondo la ricostruzione immaginifica propria del regista. Che dentro ci mette la pittura risorgimentale di Fattori, dei fratelli Induno, e – per sua stessa ammissione – anche il libro Cuore, coi suoi sentimenti impudichi, popolarissimi.
La ricostruzione (anche digitale) di quest’Italia in costruzione mi ha ricordato La nobildonna e il duca, uno dei Rohmer finali, con gli stessi sfondi pittorici sfacciatamente “finti”. Entrambi sono film dialettici, pieni di dubbi, su Paesi in subbuglio (là c’era, ovviamente, la Rivoluzione francese) sul cui sfondo ribolle una frattura che non sarà mai sanata, nemmeno nelle epoche a venire.

Fausto Russo Alesi e Barbara Ronchi sono i genitori di Edgardo Mortara. Foto: Anna Camerlingo/01 Distribution
Un film sul caso Mortara Bellocchio voleva farlo da tempo, ma poi ha saputo che alla stessa storia stava lavorando Spielberg – «Non che avessi un complesso di inferiorità, semplicemente stava facendo la stessa cosa e allora ho mollato. Poi lui ha rinunciato e siamo tornati sul progetto. Ora il film gliel’ho mandato, mi ha detto che lo vedrà, ma non mi ha ancora fatto sapere niente» – e chissà cosa ne sarebbe venuto fuori.
La versione di Bellocchio è razionale e mai faziosa, nonostante il fiero ateismo che i suoi quasi sessant’anni di cinema hanno strenuamente presidiato. Certo che la Chiesa rapisce e distorce e piega la (sua) realtà, ma qui hanno tutti torto, cattolici ed ebrei e politici e azzeccagarbugli assortiti, tutti hanno il peso di quel crocifisso sulle spalle, nessuno riesce a svincolarsi dai chiodi. Nemmeno Cristo, quello che in fondo perde più di tutti: non c’è pietà, non c’è perdono, non c’è nulla in questo cupo affresco storico e privato.
In Rapito torna gran parte del cast di Esterno notte – inappuntabili, al solito, Fausto Russo Alesi, Fabrizio Gifuni, Paolo Pierobon, più la bravissima Barbara Ronchi, già diretta da Bellocchio in Fai bei sogni, Filippo Timi e un giustissimo Paolo Calabresi – e ci sono tanti lampi del cinema dell’autore, i suoi simboli, i suoi slanci onirici che sembrano a loro volta aver ispirato qualcun altro, qualcos’altro: quando il Papa viene spinto per terra, pare la (re)installazione di Maurizio Cattelan con Giovanni Paolo II colpito dal meteorite. C’è una musica (molto bella, di Fabio Massimo Capogrosso) con archi che lampeggiano in stile Bernard Herrmann, un incalzante procedere thriller dentro un ritmo forse più calmo, e la solita, instancabile voglia di dialogo, di confronto, di messa in discussione: anche, soprattutto, di sé stessi. Finché in questo disgraziato e disunito Paese c’è Bellocchio, c’è il cinema.