Arieccoli: testardi e dinamitardi, i Public Image Limited sono tornati con un nuovo album, End of World e si preparano a portarlo in tour. John Lydon è reduce dalla morte della compagna di una vita Nora, ma è indomito, inarrestabile nel suo volere a tutti i costi far parte della storia. I PIL non si sono arresi mai e hanno messo sul tavolo le loro carte senza mai barare. O meglio, se l’hanno fatto, l’hanno fatto molto bene. Possiamo verificarlo analizzando la loro discografia, che qui presentiamo dal disco meno riuscito al migliore in assoluto. Comunque lo si rigiri, il suono PIL si farà beffe di voi.
What the World Needs Now...
2015
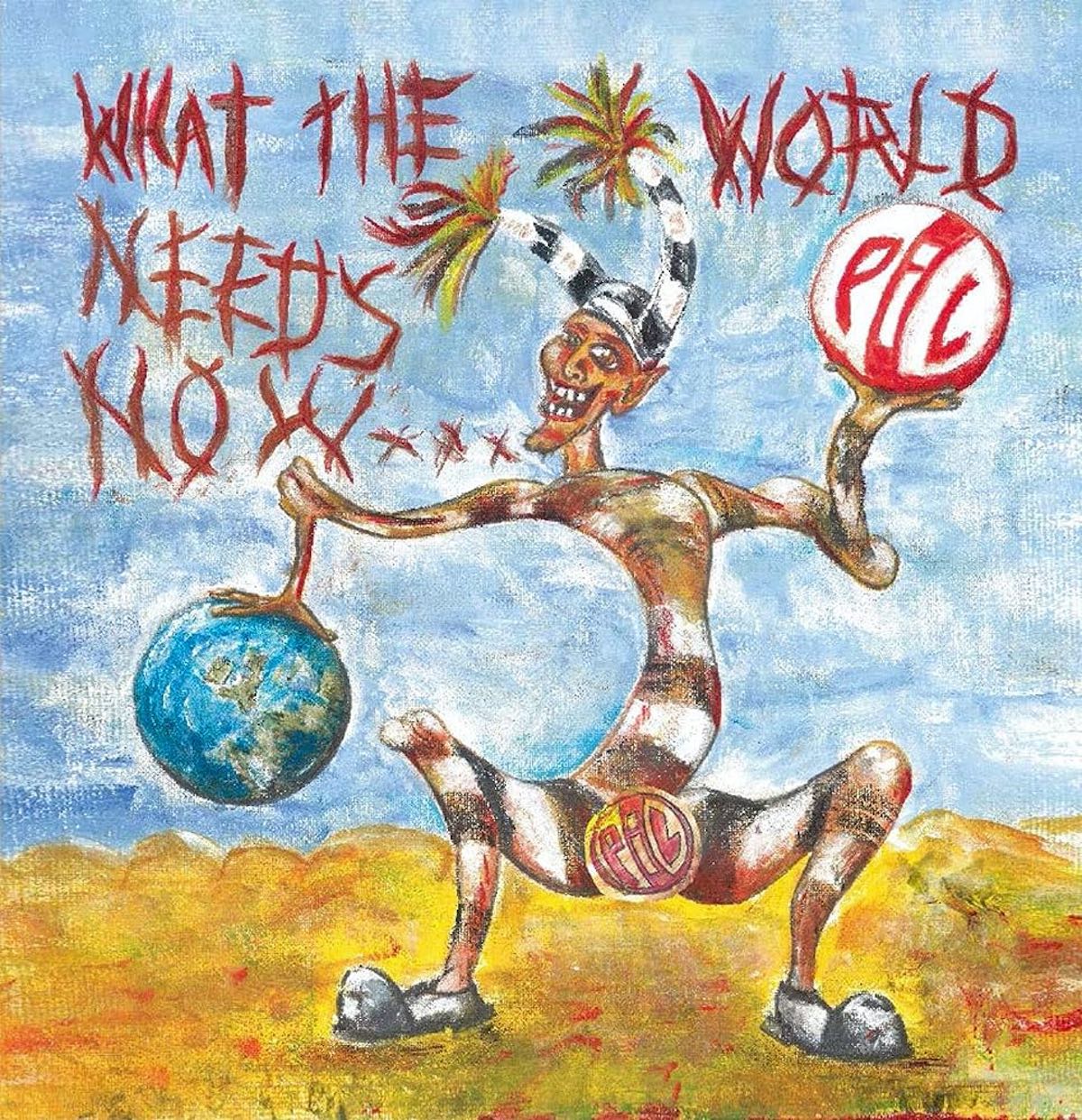
Di certo il mondo non aveva bisogno di questo disco. Il gruppo fa video in serie in cui sono in studio con zero creatività e con un’attitudine che chiamare amatoriale è un complimento (e poi le cover art ottenute dai dipinti di Lydon alla lunga stuccano). Nei dischi le cose vanno oggettivamente meglio, ma mai come in What the World Needs Now… si ascolta il riciclo del riciclo del riciclo. I PIL sono tornati, ma non fanno un passo in avanti. Se nel precedente This Is PIL vince l’effetto sorpresa del rientro in pista e la voglia di sapere cosa succederà dopo, ora ci si chiede cosa sta succedendo alla band. Il singolo Double Trouble ad esempio, nonostante sia incazzato, è la descrizione di un alterco con la moglie sul cesso rotto. Know Now non è male, ma è tipo noise rock fatto da gente che imita i PIL. Forse il gruppo si è seduto sul proprio mito come se volesse esprimersi per forza anche se non ha granché da dire. What the World Needs Now… è quasi un bignami dello stile PIL assemblato per le nuove generazioni, un riassunto probabilmente fin troppo asciutto pensato per chi non sa nulla della loro storia. Per chi la conosce, invece, tanta è la delusione nel non sentire evoluzione alcuna quanta è la stima per Lydon che continua a strapazzare le corde vocali in nome della sua libertà d’azione. In sostanza, se il mondo non ha bisogno di lui, lui non ha bisogno di noi: e va bene così, lunga vita ai PIL.
This Is PIL
2012

Clamoroso ma vero, i PIL pubblicano un album 20 anni dopo il controverso That What Is Not. L’effetto curiosità è assicurato, ma il risultato finale rende perplessi soprattutto per il fatto che dal vivo i nuovi pezzi risultano stanchi e sgonfi a differenza di quelli storici che invece vengono interpretati con una furia tale da sembrare appena composti. Ma comunque i grandi vecchi ci provano: si riprendono quello che gli Sleaford Mods gli hanno preso, tentano delle bizzarrie semi-nonsense come Lollipop Opera, ma soprattutto sembrano un gruppo jazz. Il che non è di per sé un handicap, ma sicuramente la scelta di autoprodursi impedisce una visione dei pregi e difetti, e il tutto suona troppo edulcorato. Il nuovo arrivo Scott Firth al basso ha una responsabilità in questo senso: suona difatti in una band jazz, gli U-sonic, ma il suo curriculum di session man lo vede al fianco di gente come le Spice Girls. I PIL si sono “imborghesiti”, anche se per registrare l’album Lydon ha messo tutto di tasca sua in piena botta DIY, cosa che se di per sé è molto punk, ma ci fa pensare che forse un motivo c’è…
End of World
2023

L’album rivela già dal titolo che il mondo citato nel precedente album è giunto al termine. Una sensazione di fine che ha preso piede in alcune vecchie glorie (basti pensare all’imminente Songs of a Lost World dei Cure), ma in questo caso difficile non pensare alla circostanza della morte di Nora Forster, compagna di una vita di Lydon che ci ha lasciati a causa dell’Alzheimer. Vero è che nonostante le controversie intorno alle dichiarazioni del cantante – le uscite pro Trump ad esempio – Lydon da un po’ di tempo gioca a fare il bastian contrario, come del resto succedeva negli anni ’70 quando imbottito di anfetamina rispondeva in maniera incoerente e strafottente alle interviste televisive. È come se il leader dei PIL fosse tornato in forma, almeno in questo senso: è incazzato contro la vita a prescindere e questo rende le sue performance vocali tese come non mai, basti sentire Penge che è la versione vichinga di Four Enclosed Walls. Anche quando in Being Stupid Again si beffa del woke dando a tutti dei fricchettoni sembra riecheggiare le invettive “ad antipatia” della vecchia The Suite. Ma è quando Lydon smette di fare il personaggio che accade la meraviglia. Hawaii è senza dubbio il miglior singolo della band da Rise, in cui l’arrangiamento psycho-esotico sembra vapore uscito da geyser ancestrali e le melodie vocali sembrano impossibili. Il testo è finalmente uno spaccato dell’umanità di Lydon, un canto d’amore per la moglie Nora che rievoca una loro vacanza alle Hawaii, ricordo di felicità in mezzo alla tragedia. Peccato che nel disco John non si sia concentrato solo su questioni esistenziali e autobiografiche mettendo da parte la polemica.
9
1989
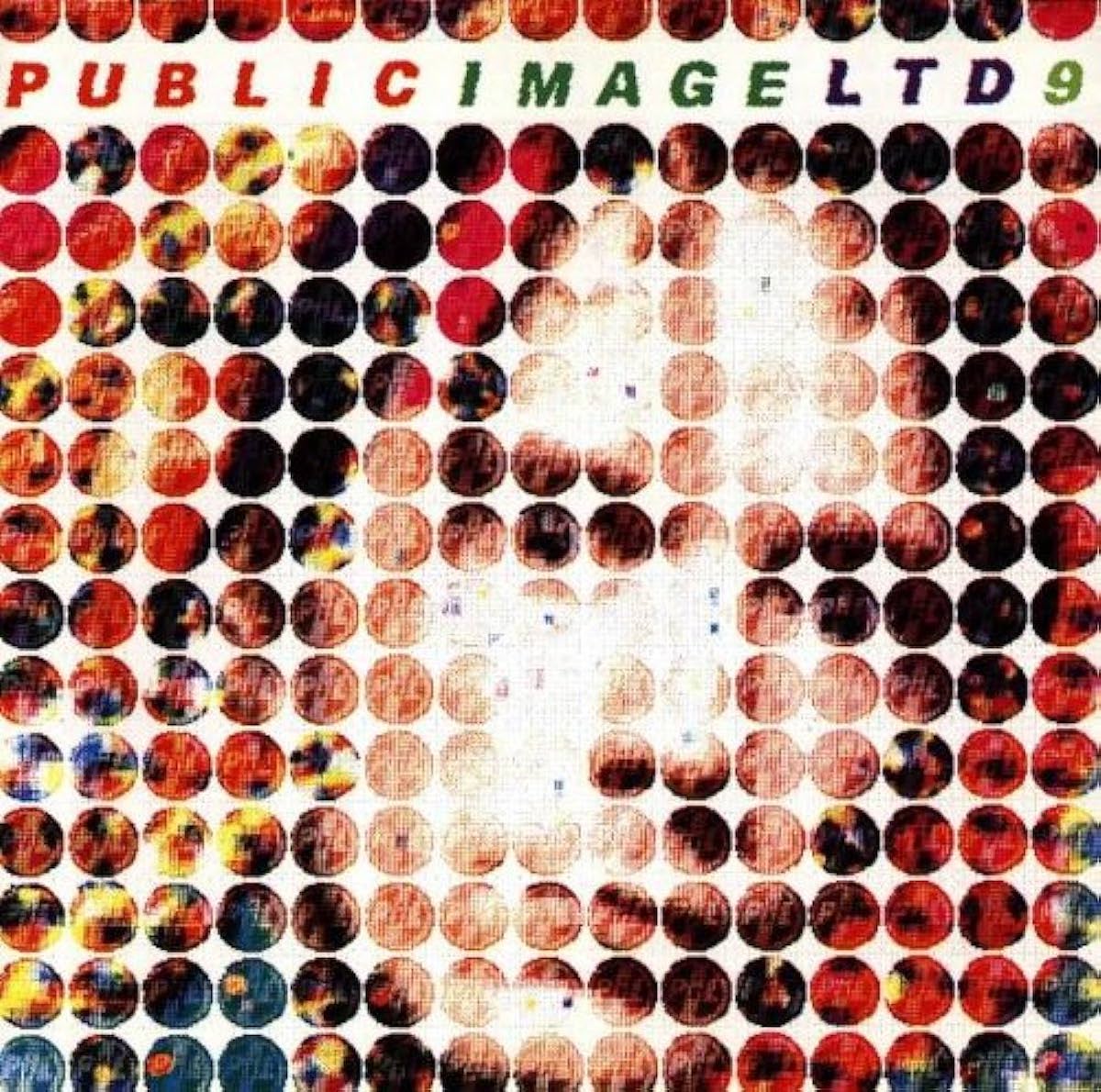
Annoiato già dal titolo, 9 è il nono disco dei PIL, che vengono dallo scivolone di Happy? del 1987. Ragion per cui Lydon (o meglio, la Virgin che lo pressava) pensa di tornare da Bill Laswell, solo che Laswell gli dice letteralmente che i pezzi fanno cagare e che dovrebbe licenziare quasi tutti i membri della band. A quel punto Lydon invece di seguire un consiglio saggio fa di testa sua, chiama alla produzione Stephen Hague scegliendo la via del suono computerizzato, quello con cui in pratica i nostri avevano composto i provini. Il produttore, noto per il successo di Pet Shop Boys e New Order tra i tanti, non sembra a suo agio nel trasformare i PIL in una roba pop elettronica e il tutto risulta forzato verso una direzione visionaria, ma poco aderente alla realtà del gruppo. Per dirla in poche parole, 9 tenta quello che è riuscito proprio ai Pet Shop Boys con Very, anno 1993: se c’è qualcosa di buono in 9 è proprio l’aver individuato una direzione, quella del suono “plasticoso” che dai ’90 ci traghetterà nei 2000, con il limite di una band che oramai si è infilata in un impianto rock, orfana tra l’altro del grande talento di Lu Edmonds, costretto a lasciare a causa di un tinnitus che non gli dà scampo. Era meglio, per dirla con Laswell, farne un disco heavy metal: e infatti – anche se parzialmente – i PIL applicheranno questa dura lezione nel successivo That What Is Not.
Happy?
1987

Mai titolo fu più azzeccato: felici di cosa? Sicuramente non di questo album, che il bassista Allan Dias col senno di poi considererà «un prodotto anni ’80». Proprio nel momento in cui i PIL sono tornati ad essere una vera band (e che band: con John McGeoch ex Siouxsie and the Banshees, Lu Edmonds ex Damned e Bruce Smith ex Pop Group), la magia in studio finisce. L’effetto Album si è trasformato in un boomerang, Lydon si affida completamente al produttore Gary Langan – ex membro degli Art Of Noise – ed è praticamente come se non fosse nel disco se non per la voce. Ma Langan non è Laswell, tant’è che prima di Happy? produce Belouis Some e gli Spandau Ballet, che poco c’entrano con la storia dei PIL. Il risultato è un disco con ambizioni commerciali nel quale la band vuole fare più rumore possibile senza poterselo permettere, annullando così nello stesso tempo sia la possibilità di arrivare a più orecchie, sia quella di accontentare i fan duri e puri. Ci sono però bei momenti come la aggressiva The Body a tema aborto, Rules and Regulations e la preveggente Seattle che scruta all’orizzonte già il mood grunge in avvicinamento. Paradossalmente il limite del disco è il fatto di avere dei pezzi scritti, pronti e inscatolati prima di entrare in studio, pratica “militare” che non è proprio quella dei PIL profeti dell’entropia, anzi.
That What Is Not
1992

Nel 1992 i PIL se ne escono con l’album più bistrattato della loro carriera, quello che a un certo punto li porterà allo scioglimento (prima di ripartire bisognerà aspettare il 2012, praticamente un’eternità), quello che dividerà la critica che parlerà del disco come di un album blando e privo di idee. Non è proprio così e ascoltandolo col senno di poi That What Is Not rappresenta un coraggioso tentativo di rispondere al grunge, senza dimenticare che esce nell’era dei campionamenti, del grebo, del crossover. C’è un grosso lavoro in questo senso, soprattutto da parte di McGeoch che da camaleontico geniaccio delle sei corde si reinventa ancora una volta con delle potenti chitarre alt rock a volte anche piuttosto industriali. Pezzi come Acid Drops, con l’autocampionamento ironico del “no future” dei Sex Pistols o il singolo Cruel sono visioni talmente “pilcentriche” da risultare bizzarre a tal punto da essere lontane da codifiche prescritte. Addirittura la pazzoide Emperor sembra prevedere il ritorno del punk-rock in una versione più accessibile, ma ovviamente con i soggetti in questione tutto si ottiene tranne che qualcosa di facilmente assimilabile. Per questa ragione That What Is Not rimane uno dei dischi dei PIL più “disgustosi” nel senso buono: alla fine basta guardare la copertina di Armando Testa per capire che l’intenzione non è quella di fare cassa…
Album
1986

Il disco del post Levene sulla carta sembrerebbe una cagata: Lydon circondato da session man di lusso che non c’entrano nulla l’uno con l’altro, Ginger Baker accozzato con Steve Vai, Sakamoto con Terry Williams. L’unico appiglio al nome PIL è Johnny con la sua inconfondibile voce beffarda. Ma alla produzione e al basso c’è Bill Laswell e l’esperto capoccione dei Material fa il miracolo di riuscire a far funzionare tutto. Se ascoltiamo le demo registrate prima del suo arrivo è evidente che la wedding band messa insieme da Lydon per accompagnarlo nel progetto Live in Tokyo (fatta da gente che coverizzava i Pistols e null’altro) non è assolutamente in grado di dare un apporto creativo all’album, tanto che l’unico brano interessante è Animal, provinato dal solo John, stranamente escluso dalla track list finale. Che i pezzi ci siano o meno però non ha importanza: con la line up di Album vengono suonati da dio, anche qui con la strategia del “buona la prima” applicata persino a un ipertecnico come Vai che – per sua ammissione – ottiene qui i migliori soli e la migliore performance della sua vita. E onestamente basta la presenza di due mega anthem come Rise e Home (uno con in mente la lotta contro l’apartheid e l’altro un affondo anarchico alla politica mondiale ipocrita) per farne un classico. Ecco, per l’appunto: Album nasce per farne un classico del rock “maturo” anni ’80, che esce dai cliché paradossalmente sfruttandoli tutti. Qui sta la genialità ma anche la grandissima paraculaggine dell’operazione (culminata nel probabile plagio del concept “minimale” del titolo, scippato ai Flipper). E infatti nelle successive prove si noteranno i problemi di quella che apparentemente è una formula vincente.
This Is What You Want... This Is What You Get
1984
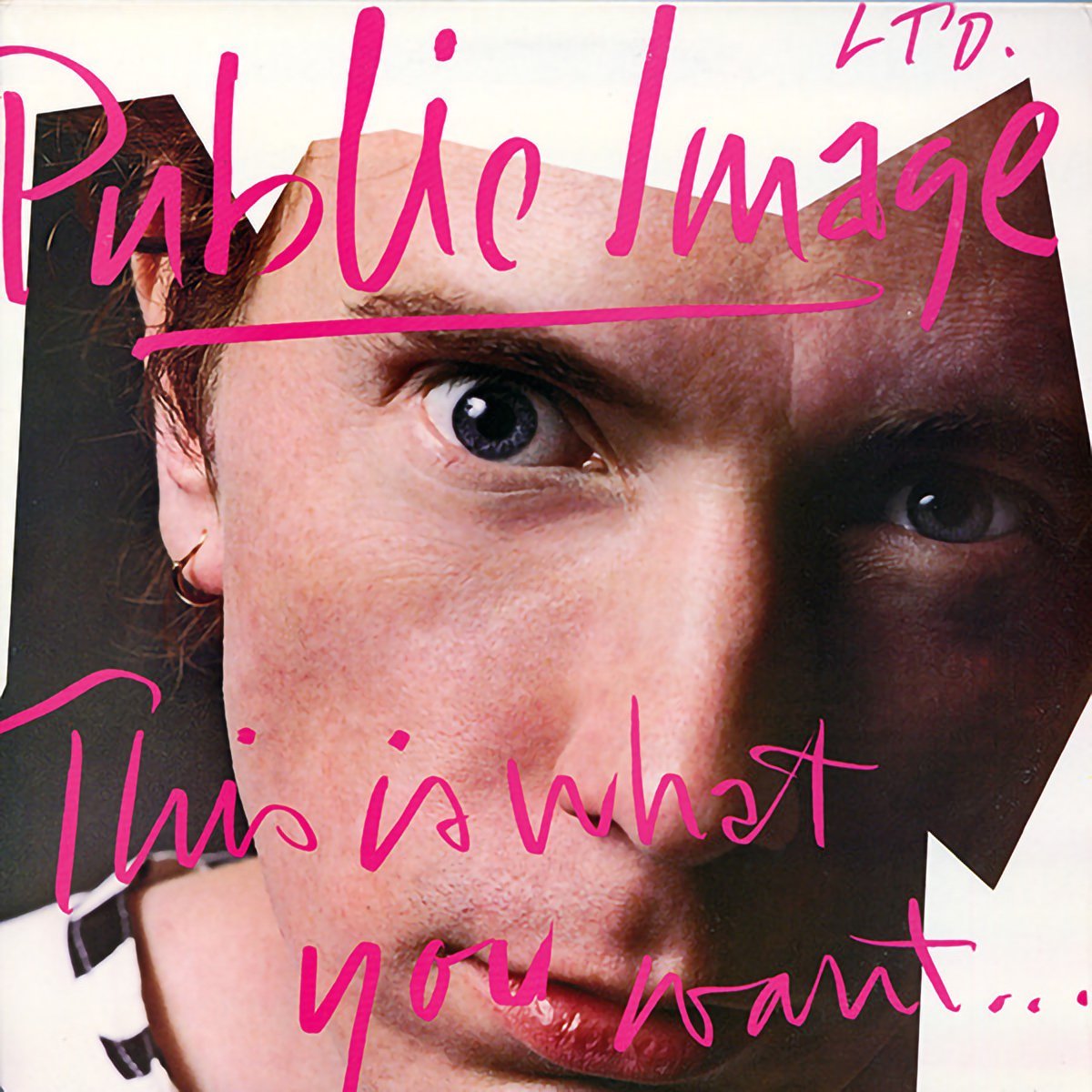
Non deve stupire che questo album (anzi, questi due album visto che Commercial Zone fu pubblicato in maniera clandestina da Levene mettendo insieme le demo, tra le quali anche dei gustosi inediti come Miller High Life), venga considerato qui tra i migliori. Innanzitutto perché alla scrittura c’è ancora Levene, che nonostante venga cacciato per motivi di ego inconciliabili mantiene i credits su cinque canzoni su otto, e poi perché Martin Atkins rimane ai tamburi sviluppando una serie di tricks (come ad esempio la batteria triggerata coi synth) che lo porteranno presto a diventare un paladino dell’industrial coi Pigface. Ma anche perché quello che all’epoca era considerato uno scherzo poi è diventato pane per gente come Björk (vedi The Pardon o Where Are You?) e per tutto il giro dance punk stile Chk! Chk! Chk!. È un funk bianco contaminato da sperimentazione acida e sprazzi di world music presa a sassate, praticamente il contrario esatto dei Talking Heads, ma giocato nello stesso playground: potremmo dire che preferiamo Commercial Zone per la sua ruvidezza piuttosto che l’iperprodotto This Is What You Want… (che prevede per la prima volta l’uso dei fiati), ma è anche vero che la tarda pubblicazione dell’album ha reso certe idee – almeno all’epoca – non al passo con l’ambizione di corrodere la pop music offrendone una propria versione, e si sa che le mode cambiano velocemente. Detto questo, This Is What You Want… rimane l’ultimo guizzo dei veri PIL, quelli che ancora vogliono rompere – giustamente – le palle. Quello che seguirà è frutto di una band completamente diversa, che della vecchia ragione sociale ha solo il nome. Non che sia un problema, ma tocca averne consapevolezza: per ora fa notizia il fatto che un brano come This Is Not a Love Song sia riuscito ad arrivare al quinto posto della classifica UK. È il chiaro segnale di una svolta in avvicinamento…
First Issue
1978

La prima prova dei PIL meriterebbe il pari merito in una delle prime due posizioni solo per l’anthem Public Image, un brano il cui chitarrismo ha rivoluzionato tutto il post punk successivo (vero The Edge?), e per la devastante Theme che mette la parola fine all’esperienza Sex Pistols spazzandola via come tartaro dal dentista. Dei residui della “creatura” di McLaren però sono ancora presenti, ad esempio Low Life, una dedica velenosa all’ex manager, o Religion, stoccata al cattolicesimo rifiutata dai Pistols: segno che ancora i nostri non hanno dato il massimo. Ma è nella conclusiva Fodderstompf, fatta di suonacci casuali, sberleffi ai neoromantici (“we only wanted to be loooved”) e suonata a braccio dopo essersi letteralmente fumati il budget, che il gentile pubblico è avvisato: da questo momento i Public Image Ltd “non vogliono essere più trattati come proprietà”.
The Flowers of Romance
1981

A un certo punto Jah Wobble scompare dall’orizzonte per le inevitabili e classiche divergenze e il timone rimane in mano a John Lydon e Keith Levene, la cui relazione è turbolenta tanto che imploderà da lì a poco. Ma in questo momento tutto funziona a dovere: anzi, a dire il vero “non funziona” a dovere, e meno male. Nei brani c’è un nichilismo che schiaccia le ossa, sono per lo più abbozzi, deliri sparpagliati di tossicomani: è la colonna sonora di chi si aggrappa stancamente a una corda per non cadere in un burrone. Il genio sta nell’amplificare questa sensazione, nel sottolineare che le cose stanno proprio così, che come diceva Barrett in Jugband Blues, “sono obbligato a chiarire che non sono qui”. E infatti il vuoto prodotto dall’assenza di Wobble viene esplicitato dalla scelta di non usare il basso se non in alcuni brani (suonato al minimo sindacale) e lasciare tutto alla batteria del metronomico Martin Atkins, perfezionando la tecnica del gate reverb codificata casualmente da Phil Collins e Hugh Padgam durante le registrazioni di Peter Gabriel 3. Il risultato è volutamente claustrofobico, ostico, un esaurimento nervoso in musica. Eppure, un singolo impossibile come la title track riesce, nonostante sia basato su una sola nota dronica, a sdoganare il salmodiare stile muezzin nelle classifiche inglesi, raggiungendo il 24esimo posto, segno che i PIL sono perfettamente sintonizzati con il loro tempo, o meglio con le sue macerie presenti e future (i Liars per esempio sapranno chi ringraziare per They Were Wrong, So We Drowned, ma anche il nostro Faust’O con Love Story non la contava giusta).
Metal Box
1979

La scelta del miglior disco dei PIL cade sul leggendario Metal Box. È inevitabile: tutto in questo album (che poi non è neanche un album, ma tre 12” inclusi in una confezione di metallo stile contenitore per le “pizze”) è talmente deforme da risultare perfetto nel suo esserlo. Jah Wobble ribalta le budella con i suoi bassi, Keith Levene trapana i timpani con i medio-alti gracchianti della sua chitarra di alluminio programmando synth impazziti, John Lydon pare uno schizofrenico con microfono in mano e leggio che a malapena tiene gli appunti, con un andirivieni di batteristi che suonano buona la prima e una volta registrati vengono accompagnati alla porta a pedate. È anche il disco in cui Levene si rende conto di poter fare tutto da solo (vedi Radio 4) e nel quale Lydon è in stato di grazia a livello di testi, toccando tutti i nervi scoperti possibili del sentire comune, demolendolo. Sarà proprio da questa dualità che i PIL prenderanno poi – perso il tellurico Wobble – una direzione totalmente minimale e dissanguata. Più che un disco, Metal Box è una dichiarazione di guerra precisa ed efficace contro il mondo, rispetto agli esordi in cui la furia era parzialmente tenuta a bada dalle scorie punk-rock. È un disco per gran parte improvvisato, basato su una urgenza che non ha niente a che fare con le regole dello show business, ma neanche con il post punk del periodo, fin troppo autoindulgente. I PIL qui, invece, non fanno sconti a nessuno, in primis a se stessi, diventando degli anti guru della no wave, del noise rock, di qualsiasi depravazione sonora che verrà.












