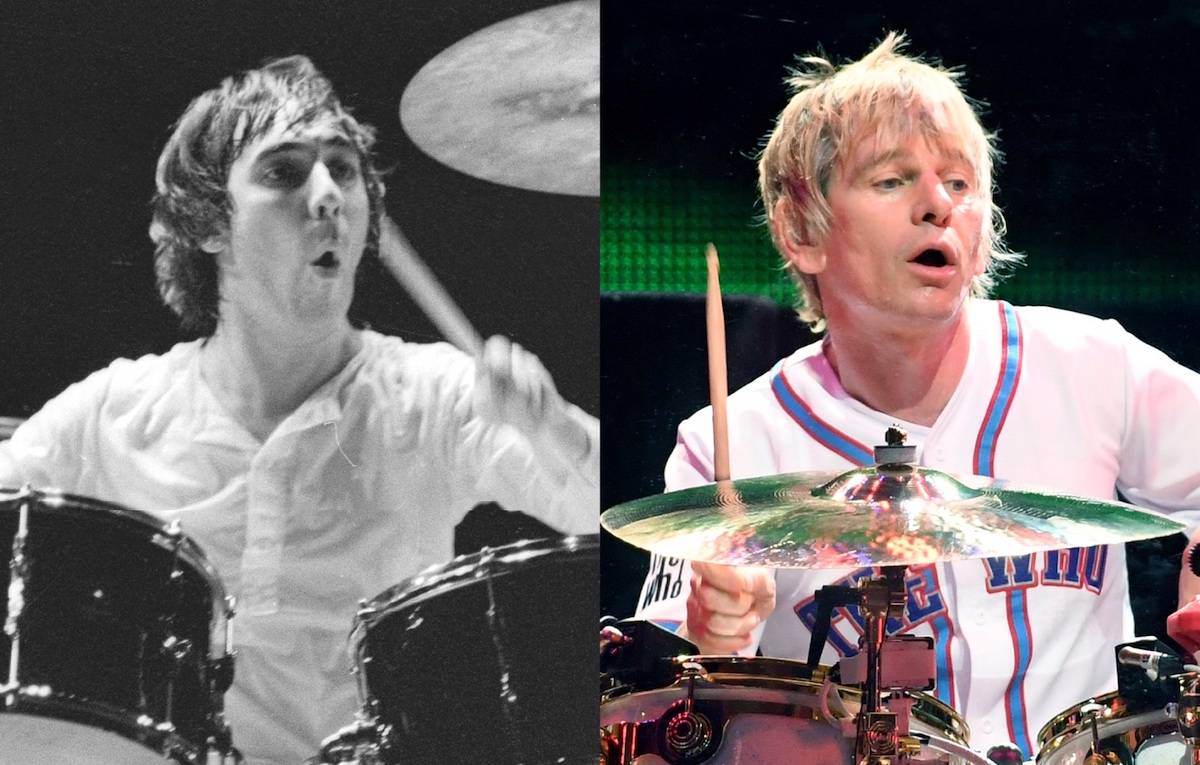Non puoi bagnarti due volte nella stessa acqua. Allo stesso modo, a meno che tu non disponga di un’infinita quantità di pazienza, tempo e fortuna, non potrai vedere due volte la stessa versione di Eno, il documentario presentato pochi giorni fa al Sundance.
È una cosa voluta. A Brian Eno (ex Roxy Music, produttore leggendario, amico di Bowie nel periodo berlinese, pioniere dell’ambient, nonché l’uomo che negli anni ’70 indossava il kimono come nessun altro) non piace rivangare il passato o essere incasellato. L’idea di un film che ripercorra i suoi 50 anni di carriera dietro tastiere e mixer, o peggio che preveda la sua partecipazione, gli pare un controsenso. «Facendolo, diventi la storia di un regista», ha detto Eno, «e io non voglio essere la storia di nessuno». Preferisce scrivere la colonna sonora di un documentario piuttosto che vederne girare uno sulla sua vita.
È il motivo che l’ha portato a incontrare Gary Hustwit. Il regista gli ha chiesto di comporre la musica per Rams, un documentario del 2018 sul designer industriale Dieter Rams. Dopo quella collaborazione, Hustwit gli ha proposto qualcosa di completamente diverso: usare un software di cui gli aveva riferito un programmatore in grado di remixare immagini video in tempo reale. Il film-base sarebbe stato montato e completato, il programma avrebbe poi elaborato di continuo e in modo casuale l’ordine delle sequenze. Alcune scene sarebbero state fissate all’inizio e alla fine, tutto il resto poteva essere lasciato al caso.
Non era diverso dal procedimento con cui Eno ha creato la cosiddetta musica generativa. Che cosa accadrebbe se la sua opera (musica, dischi, video sperimentali, cinque decenni di arte incredibilmente feconda) non venisse passata in rassegna in ordine cronologico, ma rimescolata? E se un documentario musicale sulla vita di qualcuno somigliasse non a un LP, ma a un mixtape curato dal fato?
Presentato in anteprima il giorno d’apertura del Sundance Film Festival, Eno è uno squarcio sulla vita di Brian Eno, un ritratto d’artista tratteggiato grazie al capriccio di un algoritmo. Vederlo è un’esperienza singolare, impossibile da replicare, senza alcuna pretesa di esaustività da nessun punto di vista, in particolare riguardo il protagonista. Se si tentasse di fare una cosa del genere con qualunque altro soggetto, il risultato sarebbe troppo stravagante. Ma applicato a un musicista concettuale come Eno (che non sapeva suonare alcuno strumento quando è entrato nei Roxy Music e ha scelto il synth perché era nuovo e dunque «non esistevano regole su come non andava suonato»), sembra essere l’unico approccio possibile. «Davvero, non so cosa faccia in studio», dice Bowie nella sequenza girata durante le session di Heroes. «È più un approccio filosofico». Anche Eno funziona così, solo che delega l’approccio filosofico all’intelligenza artificiale invece che al genio musicale.
Se avete fortuna, quel segmento con Bowie sarà nella versione di Eno che vedrete. Potreste anche godervi Eno che introduce i Talking Heads alle gioie dell’afro pop, portando così agli arrangiamenti di cori che ricordano una sezione di ottoni in Remain in Light; oppure gli esordi dei Roxy, con Eno che sfoggia il secondo mullet da alieno più grande della storia del glam o ancora un aneddoto eccezionale su Eno che piscia nell’opera di DuChamp Fontana, quando era in mostra al MoMA; e magari un Eno ormai settantacinquenne che fa il nonno ballerino su Get a Job dei Silhouettes. Sono alcune delle scene migliori viste alla prima al Sundance, anche se non è possibile sapere se vi siano sequenze ancora più importanti che l’AI ha momentaneamente lasciato, diciamo così, sul pavimento della sala di montaggio. Succede quando un documentario musicale non è costruito come una raccolta di greatest hits, ma in modalità shuffle. Durante il Q&A dopo la proiezione, qualcuno ha domandato perché non si fosse parlato della Portsmouth Sinfonia, un progetto che coinvolgeva orchestrali che non sapevano suonare i propri strumenti. Hustwit ha risposto: «Venite domani! C’è qualcosa a riguardo, potrebbe comparire in quella versione».
Eno si è collegato dal suo studio di Londra. Il suo viso sullo schermo incombeva come Dio, o forse come il Grande Fratello, su Hustwit e gli altri componenti del team (stiamo parlando di uno dei pochi lungometraggi ad avere nei crediti sia un direttore della fotografia che un direttore della programmazione). Ha risposto alle domande del pubblico, ha spiegato perché trova frustranti i documentari musicali, ha parlato del processo di realizzazione e ha ragionato sul piegarsi alle richieste di un’intelligenza artificiale rispetto a quelle di un regista.
A un certo punto, ha risposto a una domanda su com’è stato lavorare con una certa persona, ripetendo quasi parola per parola una cosa che dice nel film. «Guarda che questa l’hanno già sentita, Brian», ha scherzato Hustwit. È il rischio che si corre quando si fanno questi esperimenti, ha ribattuto Dio/Eno. «Onora il tuo errore come fosse un’intenzione nascosta», dice nel documentario. Soddisfatto di avere involontariamente dimostrato il suo punto di vista, Eno si è limitato a sorridere. Un altro momento unico che probabilmente non si ripeterà mai più.
Da Rolling Stone US.