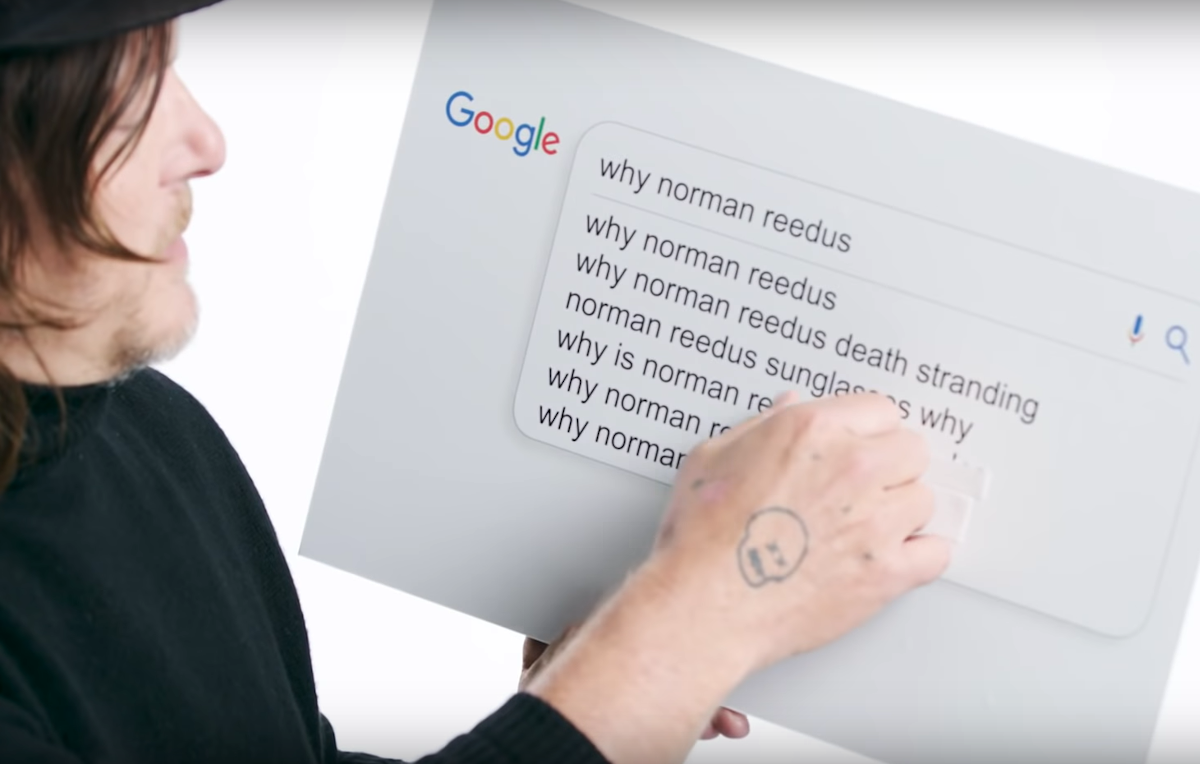Quando lo scrittore americano Raymond Carver iniziò a tenere corsi di scrittura creativa, in una delle sue tante lezioni una volta disse una cosa verissima: “Ci sono scrittori che di talento ne hanno tanto; non conosco scrittori che non ne abbiano. Ma un modo di vedere le cose originale e preciso e l’abilità di trovare il contesto giusto per esprimerlo, sono un’altra cosa”. Perché che si tratti di scrivere romanzi, comporre canzoni, fare arte o dirigere film, la sostanza rimane quella: per conquistare un posto nel cuore della gente, bisogna che la propria visione delle cose, delle persone e del mondo, sia qualcosa di diverso da quanto già letto, sentito, visto. Bisogna prendere le esperienze e le emozioni che gli esseri umani vivono e sentono da secoli e, in qualità di persona dalla vita unica e irripetibile, saper raccontare e raccontarsi come nessuno ha mai fatto prima. C’è forse qualcosa di più difficile? Non a caso, tra tanti talenti in circolazione, solo pochi possono dire di avercela fatta. Pochissimi, di riuscire a mettere le proprie ossessioni dentro a qualsiasi cosa facciano, e senza che per noialtri questo costituisca un noioso cliché. Semmai, una prova di sensibilità. O un particolare vezzo.
Quentin Tarantino
I piedi
Se doveste condensare il cinema di Quentin Tarantino in alcune immagini, quali vi verrebbero in mente? A qualunque cosa stiate pensando, quel che è certo è che da qualche parte del vostro cervello si sono palesati loro: i piedi. Che siano curati come quelli della Sposa/Black Mamba Uma Thurman, in Kill Bill – Vol. 1 (2003), o decisamente sporchi à la Margot Robbie e Margaret Qualley in C’era una volta a… Hollywood (2019), poco importa: per Tarantino i piedi meritano sempre un primo piano. Feticismo? Giammai: “Ci sono un sacco di piedi in molti buoni film di registi”, si è giustificato una volta il regista in un’intervista per GQ. Eppure, Quentin, sappilo: è dal 1996 e da “quella” scena del film Dall’alba al tramonto che coviamo qualche dubbio. O dobbiamo proprio chiedere ai piedini di Salma Hayek?
Wes Anderson
Le palette di colori
È automatico: quando si pensa al cinema di Wes Anderson, si pensa al modo in cui vengono inquadrati i soggetti (spoiler: sempre centratissimi). Eppure, basta osservare oltre questo dettaglio per capire che la vera ossessione del regista di Fantastic Mr. Fox (2009) e Moonrise Kingdoom – Una fuga d’amore (2012) è un’altra. Ossia: le palette. A ben vedere, infatti, l’universo di Wes Anderson si modula su uno studio attentissimo dei colori, dove quelli primari (il giallo e il rosso più di tutti) vengono sapientemente modulati nel proprio DNA: tonalità, saturazione e luminosità. Avete fatto caso che a ogni personaggio viene associato un colore principale? E che spesso l’oscurità di un passato difficile o di un presente avverso viene presentata con una luminosità più accentuata? Guardare I Tenenbaum (2001) o Grand Budapest Hotel (2014) per credere.
Sofia Coppola
L’adolescenza
Sofia Coppola ha due meriti: quello di essersi levata di dosso il titolo di nepo baby (benché lo sia) con un film come Lost in Translation – L’amore tradotto, che nel 2004 le vale un Oscar per la migliore sceneggiatura originale; ma anche quello di aver elevato a it girl praticamente qualsiasi attrice abbia girato con lei (in primis Kirsten Dunst). Il fatto è che quando prediligi le storie che hanno a che fare con giovani ragazze nel pieno dell’adolescenza, è facile che altre giovani ragazze là fuori ne rimangano stregate. Qualcuna sentendosi capita nella vulnerabilità che accompagna le protagoniste del Giardino delle vergini suicide (1999); qualcun’altra adorando la vacuità della quattordicenne Marie Antoniette (2006); e chi ancora agognando la scaltrezza della Rebecca Ahn di Bling Ring (2013) o la passione violenta dell’Edwina Morrow dell’Inganno (2017). Qualcun’altra invece vorrebbe solo essere (stata) la giovanissima Priscilla (2023), che bacia e abbraccia Elvis Presley (nella versione che ne dà Jacob Elordi). Punto e basta.
Christopher Nolan
Il tempo
È il 2020, avete appena visto Tenet e siete sicuri di una cosa soltanto: non ci avete capito niente. Tutto nella norma, perché con quel film il regista dell’oggi favoritissimo candidato all’Oscar Oppenheimer gioca a tal punto con la propria ossessione per i salti temporali che noialtri spettatori abbiamo finito per perderci, manco fossimo nel terzo livello di Inception (2010). Che amarezza! Ci eravamo tanto allenati: prima con Memento (2000), poi con tutta la trilogia del Cavaliere oscuro (2005-2012) e The Prestige (2006); scervellandoci infine del tutto con Interstellar (2014). Ma non è bastato. Per fortuna con Oppenheimer è stato più facile correre dietro al continuo switch tra passato e presente che gasa così tanto il regista di Dunkirk (2017: e anche lì…). Però, Nolan, suvvia: diamoci una calmata.
Guillermo del Toro
I meccanismi a orologeria
“Adoro tutto ciò che funziona con meccanismi a orologio”, ha confessato una volta Guillermo del Toro, il regista messicano del pluripremiato fantasy La forma dell’acqua (2017). A dirla tutta, qualche sospetto ci era venuto già a partire dagli esordi nel 1993 con il film Cronos, dove una sorta di meccanismo-insetto rende vampiri; avendone poi la conferma col nazista meccanizzato (leggi: Karl Ruprecht Kroenen) di Hellboy, nel 2004. Che dire poi degli ingranaggi che nel 2013 stanno sotto ai piloti Jeager di Pacific Rim? O di quelli che aprono (con il produttore del Toro presente) il Cabinet of Curiosities dell’omonima serie targata Netflix? Anche se il massimo si era già raggiunto nel 2008 in Hellboy: The Golden Army, con la stanza del trono fatta di ingranaggi giganti e circondata da robot a orologeria.
Tim Burton
Il goth
Figure alte, sottili, pallide e talvolta inquietanti: qualcuno (a ragione) le ha definite un incrocio tra il Dottor Caligari e i soggetti delle opere di Egon Schiele. Avete capito chi sono? Ma certo: le creature di Tim Burton. Colui che, sin dagli esordi nel 1982 con il cortometraggio Vincent (targato Disney e tratto dal racconto Il corvo di Edgar Allan Poe), mette subito in chiaro che questa propensione al goth non solo c’è, ma gli piace e lo diverte. E infatti ecco che qualche anno dopo Beetlejuice – Spiritello porcello (1988) apre le porte a quel mondo, con i successivi Batman (1989) e Edward mani di forbice (1990) a confermare quei personaggi che, di lì in avanti, definiremo “burtuniani”: tutti i protagonisti a dir poco grotteschi di Mars Attacks! (1996); il pallore e la magrezza in versione stop-motion della Sposa cadavere (2005) e Frankenweenie (2012); quel Willy Wonka così inquietante nella Fabbrica di cioccolato (2005); e quella regina dalla testa deforme in Alice in Wonderland (2010). Fino alla più recente versione decisamente burtuniana di Mercoledì Addams, nell’omonima serie Netflix. Con Tim, bisogna fare solo una cosa: scegliere il nostro (goth) fighter.
Steven Spielberg
I padri assenti
Avete presente il cliché del padre che esce per andare a comprare le sigarette e poi non torna più? Questa storiella deve aver colpito parecchio Steven Spielberg, che di padri che svaniscono nel nulla ha riempito mezza sua filmografia. Giusto per fare qualche esempio, c’è quello che se ne va a incontrare (o combattere?) gli alieni in Incontri ravvicinati del terzo tipo (1977) e La guerra dei mondi (2005); l’eterno assente che però ricompare e prova a recuperare il rapporto col figlio, come Henry Jones Sr. (Sean Connery) in Indiana Jones e l’ultima crociata (1989); quello che finisce per superare la diffidenza e la paura verso la paternità, come fa Alan Grant (leggi: Sam Neill) in Jurassic Park (1993). C’è stato mai padre più universalmente biasimato di quello di Spielberg? Per fortuna i sottilissimi riferimenti sono serviti, e papà Arnold ha vissuto gli ultimi anni della sua vita in pace col figlioletto.
Darren Aronofsky
Il fallimento
Prendere il senso del fallimento. Sezionarlo. Sviscerarlo. Raccontarlo. Piaccia o meno, a oggi c’è un solo regista in grado di gestire così bene la miseria umana: Darren Aronofsky. Sia che si parli di autodistruzione – come nel caso di The Wrestler (2008) o del Cigno nero (2010) – sia che si scavi nelle dipendenze (dalla droga, dall’amore, dalla professione) – come succede in Requiem for a Dream (2000) e in The Whale (2022) – ecco che, nel raccontare il fallimento, il cinema di Aronofsky sembra sempre focalizzarsi sulla solitudine dei suoi personaggi, spesso vittime di sé stessi. Con noi spettatori che un po’ vorremmo evadere da quel senso di isolamento che creano i primissimi piani alternati alle riprese a grandi distanze; e un po’ vorremmo continuare a farci del male, indagando quell’umana disperazione ancora di più.
Zack Snyder
La violenza
Siamo cresciuti con l’idea che la violenza sia una cosa brutta e cattiva (e lo è): ma allora com’è possibile che siamo qui a dirci che può essere pure un bello spettacolo a cui assistere? Non fraintendeteci: è che con 300 (2007), Watchmen (2009) e Sucker Punch (2011), Zack Snyder è riuscito in ciò che ci sembrava impossibile. Ovvero: rendere la violenza una vera e propria esperienza artistica, lontana dalla bassezza della realtà. Complice la grafica e i soggetti che prendono spunto dall’universo delle graphic novel (vedere i film di cui sopra), Snyder gioca infatti tanto sull’esagerazione e sulle messe in scena stilizzate da portarci qualcosa che è più un’immagine (d’arte) che una sostanza (grezza) della violenza. Fino a farla diventare addirittura una cifra stilistica, che lo rende un regista riconoscibilissimo, dall’Alba dei morti viventi (2004) a Man of Steel (2013).
Alice Rohrwacher
La terra
“Quando noi ci rifacciamo alle nostre radici, ci colleghiamo alle radici di tutti, perché in genere si pensa che scavare nelle proprie radici sia un modo per parlare della propria individualità. Ma io penso proprio il contrario: è un modo per connettersi a una collettività”. Così in un’intervista di pochi mesi fa Alice Rohrwacher spiegava il suo essere una regista dal respiro internazionale, ma dallo sguardo ancorato alla sua terra. A ben vedere, però, in quelle parole si può leggere anche altro. Ossia, il motivo per cui nel cinema di Rohrwacher la terra non solo c’è sempre, ma arriva pure ad assumere un significato altro, metafisico. Questo già a partire da Corpo celeste (2011), con il ritorno alla terra natìa che diventa anche un ritorno a sé stessi; poi con Le meraviglie (2014) e Lazzaro felice (2018), in cui la realtà rurale è custode e teatro di un’innocenza perduta. Infine con La chimera (2023), dove la terra dei tombaroli diventa immagine di un passato svuotato e di un presente svenduto. Ma anche di qualcos’altro: un futuro diverso. Ancora tutto da scrivere.
Michael Bay
Le esplosioni
Bandiere a stelle e strisce, scene al tramonto, inseguimenti mozzafiato e primi piani di donne bellissime: signore e signori, benvenuti nel mondo di Michael Bay. Una realtà dove chi si ferma è fottuto, perché per il regista di Armageddon – Giudizio finale (1998), Pearl Harbor (2001) e Transformers (2007) il movimento è la conditio sine qua non del suo cinema. Un po’ come le esplosioni, che per lui sono il profumo della vita (cit.), o forse una vera e propria ossessione. D’altronde, solo lui avrebbe potuto piazzarne così tante in un film come Pain & Gain – Muscoli e denaro (2013); e di così inutili un po’ dappertutto. Ma non stiamo a fare i pignoli, e lasciamo spazio al maestro del dinamismo: l’unico capace di farci scivolare via come niente un inseguimento di due ore in un film come Ambulance (2022). Esplosioni annesse, of course.