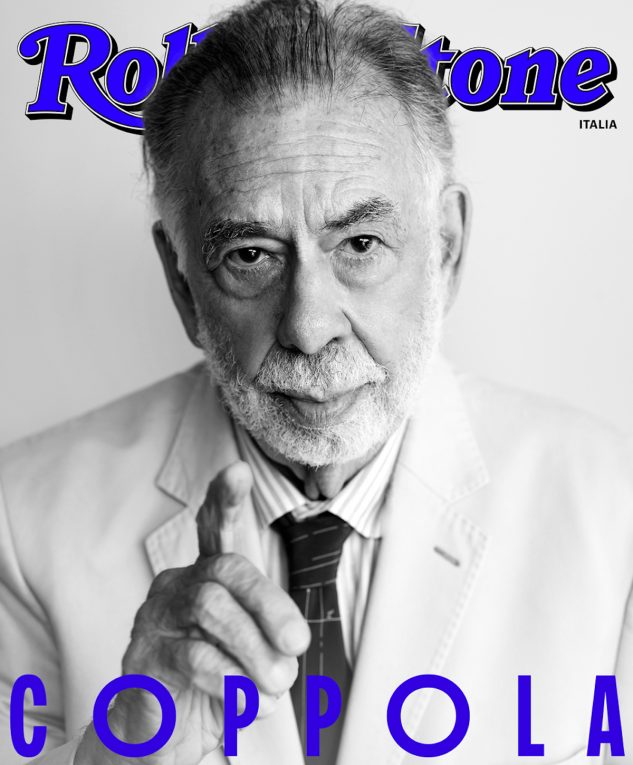Gazzelle è il fenomeno meno incastonabile della musica italiana: con il suo modo di scrivere essenziale e diretto naviga senza difficoltà tra il pop più mainstream, che gli è valso una partecipazione a Sanremo, e il cantautorato post 2010 che portava la firma de I Cani e Calcutta.
Indi è un disco intimo, personale, dove ha scelto di non avere featuring nonostante la sua carriera sia costellata di collaborazioni con la scena del momento, da Marco Mengoni a Thasup. «Mi interrogo su cosa voglia dire avere 35 anni, su che tipo di essere umano voglio essere». Ma Indi non è un disco di risposte, se sperate di scoprire voi stessi attraverso di lui. È un album che parla di quanto sia spiazzante aver perso i riferimenti con cui sono cresciuti i nostri genitori (la famiglia, il lavoro fisso) e che ci invita a concentrarci sul presente perché tanto, della vita, non capiremo mai niente. Lo abbiamo incontrato a Milano ed è stato come guardarci allo specchio.
Ciao Flavio, come stai? In che periodo della vita ti trovi?
Cito Frassica da Tintoria quando gli chiedono «come stai?» e lui risponde «sto bene, però ho attraversato un periodo in cui stavo benissimo». No, in realtà sto bene davvero. Il 2024 è stato un anno intenso. Questo che è appena iniziato lo sarà un po’ meno. Il 2024 è stato più intenso perché ho fatto Sanremo, ho fatto due tour e ho scritto canzoni come Noi no. Ho lavorato per un anno al nuovo disco. Sono felice che esca un nuovo capitolo di questa serie tv infinita che è la mia vita. Alla fine le mie canzoni parlano della mia vita, è sempre un miracolo che c’è gente a cui interessi. A me piace quando qualcuno mi racconta i fatti suoi. Io ho trovato magari una formula che permette a chi ascolta di empatizzare con le mie storie. Credo che viviamo tutti la stessa vita, però a volte c’è un amico che riesce a raccontarti bene quel problema e tu empatizzi meglio con lui, no? A volte riesci tu a dare un consiglio, a volte lui riesce a far capire qualcosa a te. Soprattutto in questa fase della vita più delicata, dalla giovinezza alla fascia intermedia, che è tremenda.
Il tuo percorso secondo me è molto interessante. Sei entrato nella scena indie un po’ dopo artisti pionieri di questo genere: Forse… di Calcutta è del 2012, i Thegiornalisti e I Cani hanno pubblicato il primo disco nel 2011. Ma nel giro di pochi anni sei arrivato al concerto del Primo Maggio, a Sanremo e poi a San Siro. Cosa ha di diverso la tua musica secondo te rispetto alla scena pop-indie italiana?
Penso di essere un artista molto produttivo rispetto ad altri, ho tenuto un buon ritmo, a volte anche troppo. Mi ritrovo a fare uscire il quinto disco in otto anni di carriera. Ho tirato fuori quasi 70 canzoni. Una media di 10 canzoni all’anno, quasi per dimostrare a me stesso che questo è veramente diventato il mio lavoro, per rivendicare il mio posto nella musica italiana. Adesso penso di essere arrivato a un momento in cui non devo più dimostrare che faccio questo lavoro, ma che lo faccio bene. Che ho qualcosa da dire sempre. Poi non lo so qual è il segreto per riuscire ad emergere, a rimanere, a consacrarti, poi a ritornare. E comunque anche se lo sapessi non lo direi perché è un segreto. Io faccio questo lavoro per raggiungere obiettivi grossi, per prendermi dei rischi, come annunciare uno Stadio Olimpico dal nulla.
C’è qualche artista arrivato prima di te che vorresti ringraziare per averti fatto scegliere questo genere?
Sicuramente Niccolò Contessa. È stato un grande apripista. Perché in quel periodo secondo me la musica italiana era un po’ in stand-by a livello di freschezza, era un po’ tutto stagnante. Nomi vecchi, gente molto grande che faceva ’sto lavoro da vent’anni. Lui ha aperto una porta con il linguaggio e le sonorità. Prendeva un po’ dal punk elettronico, che comunque era fresco, non era quello dei CCCP. Ma soprattuto ha iniziato a mettere il suo sguardo su cose dove altri artisti non lo mettevano. La canzone italiana era un po’ impelagata nella canzone d’amore standard, obsoleta. Lui è arrivato e ha iniziato a parlare a uomini di 18 anni. Ha iniziato a parlare degli hipster che arrivavano in Italia, a scrivere d’amore in un altro modo. Ha messo lo sguardo su cose più real, più pragmatiche. È stato una lente di ingrandimento sulla società in quel preciso momento. Iniziavano ad esserci i social. C’era l’urgenza di scrivere del mondo che cambiava. A me quella roba ha dato un break.
Poi è uscito Tommy (Tommaso Paradiso coi Thegiornalisti, ndr) con Fuoricampo e mi ha aperto la faccia col suo sound. Io ero abituato a scrivere canzoni con la chitarra perché non avevo altri mezzi, non facevo questo di lavoro. Stavo solo aspettando che qualcuno che aveva i mezzi, che era più avanti, lo facesse succedere. Quando ho sentito il sound dei Thegiornalisti ho pensato: voglio fare anch’io musica con uno slancio più elettronico. Pure Calcutta mi ha incuriosito all’epoca perché ho capito che si poteva scrivere in un altro modo. Ho percepito che c’era un fermento nell’aria, che si stava aprendo una breccia. Non sapevo neanche bene come farlo, ma dovevo andare. Lavoravo al bar e volevo fare il cantante. In quel momento ho capito che stava cambiando qualcosa rispetto agli ultimi 10 anni. Penso di essere riuscito a durare perché sono riuscito a prendere un posto solo mio, riconoscibile. Il mio modo di scrivere canzoni non è troppo complicato, è anche facilmente copiabile. Però poi si sente che non è la stessa cosa.

Foto: Simone Biavati
Per lanciare il nuovo disco hai fatto piazzare a Roma e Milano dei manifesti neri con una scritta lapidaria: “L’Indi è morto”. Secondo me più che morta, la scena si è frammentata e ha inglobato altri generi. Tra chi fa ancora musica indie mi vengono in mente nomi come Lamante o Emma Nolde, che hanno fatto tra i dischi più belli del 2024 e sono estremamente punk, cariche nell’approccio al palco, ma anche indie vere nell’autogestione della loro carriera. Indie alla fine era un modo di fare le cose più che un genere: indipendente, senza istituzioni, senza spalle coperte. È ancora possibile fare musica in questo modo secondo te o è sarebbe naïf pensarla così?
Non a caso il mio Indi è senza la e. Perché questo indie qua è un’altra cosa. Questa frase, «l’indie è morto», l’ho sentita tante volte insieme a «la trap ha ucciso l’indie», «l’indie è il nuovo pop», «la trap è il nuovo pop», «il pop è morto», «il pop è bello». Ho scritto questi cartelloni come una provocazione, è evidente che per me non è morto. Non mi sento un cantante così alternativo come quelli che hai citato. E poi anche per far ridere perché questo è il mio primo disco in licenza con una major, pure per quello l’ho chiamato Indi.
La provocazione di quei cartelloni è per dire il contrario. Un po’ ci credo che è morto e mi rammarico, ma allo stesso tempo penso che non lo sia finché io e qualcun altro avremo voglia di fare musica con un approccio più cantautorale, più legato alla sincerità e alla necessità di scrivere e non solo a fare i soldi. Mi piaceva prendere per il culo le persone che hanno detto più di una volta che l’indie è morto, ma l’ho detto anch’io quindi prendo per il culo anche me stesso. Per anni mi dicevano «tu fai l’indie, l’indie, l’indie» e io rispondevo sempre «sono un cantautore e faccio musica, e pure abbastanza pop». Alla fine mi sono anche accollato il fatto di essere un cantante indie e chiamare il disco così per me è stato come fare un manifesto. L’ho fatto ora però, non sette anni fa quando è esploso. Ora, col senno di poi, in una fase in cui obiettivamente va meno di moda, ho voluto dire: io sono questo, io faccio questo, e questo disco è il manifesto di quello che sono e di quello che ho fatto fino ad oggi. Ma anche per ribadire che finché c’è qualcuno come me, e qualche altro artista che si conta sulle dita di una mano, che porta avanti questa filosofia, questa attitudine alla musica, l’indie non è morto.
Non mi vedi e non mi senti, sto lontano dai social, non vado in televisione quasi mai. Ovviamente nelle mie ambizioni c’è che la mia musica diventi sempre più popolare, e non succede se te ne stai a casa tua. Cerco di trovare sempre un compromesso tra il massimo dei risultati e il minimo sputtanamento. Non sono mai andato a fare le marchette agli eventi aziendali o il concertone a caso, ho detto tanti no, cerco di mantenere un approccio alla creazione puro. Citando Forrest Gump, ero un po’ stanchino e volevo tornare a casa. Vivo questo doppio stato d’animo: non voglio essere una pop star, ma neanche troppo di nicchia. Da un lato voglio fare gli stadi, dall’altro non mi interessa la hit radiofonica, cerco di rimanere fedele a un approccio serio al lavoro, dormire sereno, senza pensare: ma che ho fatto? Voglio scrivere canzoni e cantarle, tutto il resto è fuffa. Se fossimo stati nel 1975, o andavo in tv, o mi facevi una foto, o non sapevi dov’ero e magari vivevo in barca come Lucio Dalla. Adesso è tutto diverso, ce l’accolliamo, ma io cerco sempre di fare le cose a modo mio. Con questo disco volevo divertirmi a sbagliare qualcosina, a scombussolare gli standard che ho creato, volevo cercare di sbarazzarmi di queste sicurezze che mi hanno fatto ottenere dei risultati, ma allo stesso tempo volevo rimescolare le carte.
Come ci hai lavorato?
Siamo andati in Irlanda, ci siamo staccati da Milano, da Roma, abbiamo preso una casetta, nessun villone, ci siamo fatti ispirare dalla città, comprato una chitarra da due lire, e mi è servito a ridarmi quella magia che sentivo era stata uccisa dalla quotidianità della musica come lavoro. Pensavo di non farlo neanche il disco, non volevo buttarmi in queste dinamiche ridondanti che non mi fanno amare quello che sto facendo, ho avuto una piccola crisi, figlia anche del momento, dell’assenza di quel fermento di un po’ di anni fa. Mi sembra siamo di nuovo in un momento in cui si è persa la poesia, in cui la musica commerciale domina la scena, mi sentivo fuori posto, pensavo non interessasse a nessuno un nuovo disco. Alla fine mi sono un po’ scosso da solo, non ho fatto quelle cose tipo andare in India a cercare me stesso, ma sono andato in Irlanda e mi sono lascito andare all’idea di scrivere un disco come quando avevo 20 anni, senza assecondare l’aspettativa di nessuno. Quest’album l’ho dedicato a Rino Gaetano, perché è quello che mi ha fatto fantasticare di fare questo lavoro. È il manifesto della fase di vita in cui mi trovo, è un’età particolare, di mezzo, sto per entrare nell’ottavo anno di carriera, è una presa di coscienza di quello che sono.
Questa urgenza espressiva è stata anche il motivo per cui hai scelto di non avere featuring, immagino.
È stata una scelta politica, non volevo avere feat, volevo fare un disco mio e andare contro la tendenza del periodo. Mi dà un po’ il voltastomaco vedere tutti i dischi coi feat. Nei miei dischi sono stato sempre parsimonioso: i miei primi due album non hanno feat, il terzo ha un feat, il quarto ne ha tre, ne avrò fatti quattro in totale. Poi sono stato ospite in altri progetti, un po’ per divertimento. Quando ho conosciuto Rkomi sono entrato nel suo mondo, ho capito che poteva avere un senso un featuring con lui, però adesso è diventato uno standard e mi dà fastidio. Il disco di Rkomi è stato il primo con tutti quei nomi, è stata proprio una dichiarazione d’intenti. Era interessante per me perché era una novità e infatti ha fatto il panico quell’album (Taxi Driver, ndr). Però poi da lì sono arrivato alla consapevolezza di dire: adesso questo disco è solo mio. Anche nel rap, che è il genere con più feat in assoluto, la gente sta cambiando direzione. Penso a Marra, che nell’ultimo disco non ha collabo, ha usato solo campioni.
Non c’era spazio secondo me in Indi per altri artisti, anche se ci sono persone che stimo, con cui collaborerei. È come quando ti fai i viaggi con gli amici e la ragazza, ma arriva un momento nella vita in cui decidi che vuoi andare due mesi da solo a New York o in Thailandia, o a Perugia. Non ho immaginato nessuno che potesse salire a bordo su questa cosa. Sulla copertina c’è una formica, ce n’è una sola, non ci sono quindici formiche. Spero che anche altri artisti inizino a cambiare, per tornare a sentire il gusto di una collaborazione. A me non interessava fare un po’ di streaming in più, preferisco che faccia meno numeri, ma che il messaggio arrivi per quello che è. Chi lo ascolta dirà: questo è Flavio, questo non è Flavio. Volevo fare un disco più cantautorale, più fedele a quello che è il mio modo di scrivere. Volevo tornare un po’ alle origini.

Foto: Simone Biavati
Parlando di trap, ho letto da qualche parte che hai fatto lo stesso liceo di Tony Effe e Wayne Santana. Vi frequentate o vi siete mai frequentati in passato?
Abbiamo fatto solo un anno assieme nella stessa scuola. Con Tony ci sentiamo, ci siamo sentiti pure a Capodanno.
Cosa pensi di quello che è successo per il concertone di Capodanno?
L’ho trovato un po’ imbarazzante. Da una parte non penso si possa parlare di vera censura perché secondo me quella è un’altra cosa. Rispetto Tony, gli voglio bene perché è un amico ed è anche una persona molto intelligente, oltre ad essere un bravo ragazzo, ma non penso che si possa parlare di vera e propria censura perché la censura è quando non ti permettono di esprimerti e in quel caso mi arrabbierei pure. Invece se ti dicono «tu non suoni» è più una scelta secondo me. Tony non è censurato, può uscire dove vuole, può fare la musica, può fare i concerti, andrà a Sanremo, la censura è un’altra cosa, può dire quello che vuole nella propria musica, se ne assume le responsabilità. Però d’altra parte è stato imbarazzante il fatto che tu organizzi un concerto, inviti un artista e poi cambi idea.
Ci sono anche altri generi dove si dicono cose del genere, penso al metal, al punk di cui sono megafan. Penso anche al primo Vasco, su Colpa d’Alfredo dice delle cose che sono gravi rispetto agli standard di oggi. Io domani posso scrivere una canzone, come faceva De André, dove dico che ho ucciso una persona, ma non è detto che sia vero. Non penso che Tony Effe picchi le donne o le tratti male, credo che sarebbe uscito qualcosa, qualcuno avrebbe denunciato. Invece è fidanzato e sta sereno. Ma la trap è un genere dove più la dici grossa e più è figo, quindi va tutto contestualizzato.
Io credo che quello che è successo sia l’emblema del nostro tempo. Abbiamo raggiunto il paradosso per cui non si capisce se sei più progressista quando censuri quello con cui non sei d’accordo per non amplificarlo o quando lasci la libertà agli artisti di esprimersi, anche se aborri quel che dicono. Ed è partito tutto dalla sinistra, come se avessero voluto addossare la responsabilità dell’istruzione, dell’emancipazione e del progresso all’arte, invece che prendersela loro.
Sono d’accordo. Se vedi un film in cui c’è un assassino non è che non lo fai vedere. Al massimo metti un bollino, pure sulla musica rap e trap c’è scritto “explicit”. È un avviso. Penso che il 70% dei fan di Tony Effe siano femmine. Devi anche conoscere la persona: se parlassimo di uno che entra ed esce dalla galera, che ha avuto episodi di violenza, mena le donne e poi lo dice, allora sei una merda come uomo e come artista. Ma Tony Effe non è quel tipo di uomo: è un artista, ti può piacere o meno, ma è musica, è arte. Puoi anche storcere la bocca, come si è sempre fatto di fronte a un certo tipo di musica o di film. Tony è uscito più forte da questa cosa. Si è fatto il suo sold out, con i biglietti a 10 euro, ha dato il ricavato in beneficenza a un’associazione contro la violenza sulle donne. È stato solo un capro espiatorio, ci sono colleghi suoi che dicono cose molto più grevi, solo che ha fatto Sesso e samba e da lì ha avuto molta più visibilità. Se non ti piace, non lo ascoltare.
Indi è un disco introspettivo e intimista, in cui emerge una sorta di crisi di mezza età. Non hai più 20 anni, ma non ne hai neanche 40. È un disco sulle cose che non hai avuto o sulle cose che vorresti?
Sto esattamente a metà tra un ventenne e un cinquantenne, 15 anni e 15 anni di differenza. È un disco che affronta l’età che sto vivendo, ho 35 anni e scrivo come una persona della mia età. Questo mi rende un artista credibile. È un disco legato a una fase della mia vita, della mia carriera: da una parte ho delle problematiche simili a quelle dei miei amici, dall’altra ne ho meno perché faccio un lavoro che mi piace, mi fa guadagnare bene, che mi permette di vivere la vita con una certa libertà. È un disco con delle domande più che con delle risposte perché in questa fase così sto, penso di aver capito qualcosa della giovinezza, dell’adolescenza che ormai è terminata, ho capito degli errori che ho fatto e che mi hanno portato ad essere quello che sono oggi, però ho tante domande su quello che sarà il mio futuro a livello umano.
Mi chiedo che tipo di uomo sono e sarò, cosa voglio dalla vita, dalla musica, come voglio realizzarmi dal punto di vista personale, non tanto lavorativo perché lì mi sento realizzato, dove voglio andare a parare come essere umano. E non ho le risposte. Quando ho compiuto 30 anni, ho avuto un periodo di crisi, ansia e attacchi di panico in cui ho perso dieci chili e mio fratello, che è più grande di me di otto anni, mi ha detto: «Ti vedo un po’ magro, tutto bene?». Io ho detto: «Non lo so, ho degli episodi di ansia e dissociamento che non so spiegare». E lui mi ha detto di esserci passato a sua volta e di essere molto più sereno a 40 anni che non a 30. Io ci sono un po’ rimasto perché, nella mia testa, più invecchi e più è peggio e lui invece mi ha fatto riflettere sul fatto che sei in un momento della vita tra i più complicati e delicati. Sei fottutamente e anagraficamente in un fase di passaggio turbolenta, soprattutto in questo momento storico in cui la mia generazione è cresciuta con dei riferimenti che non esistono più. I miei genitori alla mia età avevano due figli, una vita più inquadrata, ma adesso non è più così. Io ho il mio lavoro, la mia casa, i miei coetanei sono completamente allo sbando, ma non per scelta. C’è una precarietà lavorativa ed emotiva nell’aria, non sappiamo bene cosa vogliamo, ma ci sentiamo in colpa perché pensiamo che a 35 anni si debba essere un certo tipo di persona solo perché siamo cresciuti con quei riferimenti, ma il mondo è cambiato e ci sentiamo confusi. Non sappiamo bene come si fa e cosa dovremmo essere a questa età. Non siamo liberi di dire che a 35 anni ancora non abbiamo una relazione, comprato casa, scelto un lavoro fisso.
Capisco mio fratello che mi dice che ora è riuscito a capirci un po’ di più perché magari a 40 anni fai le cose che prima si facevano a trenta, ti realizzi, fai un figlio, ti compri una casa se riesci. A 30 viviamo in questa fase un po’ intermedia, un po’ angosciosa, però bisogna sempre trarne anche il bello. Secondo me è pure un’opportunità il fatto che a 35 anni non sai ancora bene che cosa vuoi fare perché tutto sommato hai meno catene, meno responsabilità, ti puoi godere la vita, ti puoi fare dei viaggi, puoi lavorare su te stesso. Ho iniziato a non tormentarmi più su tutte queste domande o a pensare a cosa c’è alla fine.
Questo aspetto si sente tantissimo nel brano Il mio amico si sposa. Alla fine, crescere vuol dire per forza sposarsi e fare figli?
Secondo me è cambiato talmente tanto il mondo che la cosa più punk che puoi fare oggi è sposarti. Ho deciso di scriverci una canzone perché è il mio primo amico che si sposa e comunque fa strano perché in un gruppo di 15 amici lui è il primo, nessuno ha figli, poi magari è la mia bolla perché siamo tutti un po’ artistoidi e sbandatelli, la mia bolla però conta per me perché è quello che vedo. Quando mi ha detto che si sposava ero molto felice: «Cazzo, sei un grande, ti stimo per il coraggio, ti stimo perché stai a fare una cosa da uomo», non nel senso di maschio, ma una cosa da adulto, e ho deciso di scrivere una canzone per fermare nel tempo questo momento e renderlo almeno per me e per lui indelebile.
Ero super contento, però mi ha fatto un po’ tremare la terra sotto i piedi questa cosa che il mio amico si sposava perché forse dovrei crescere pure io, quindi ho subito collegato lo sposarsi al crescere. Ma non è detto che sia così, non serve sposarsi per crescere e non serve crescere per sposarsi, però a me ha subito riportato alla mente quei riferimenti che citavamo e prima che non esistono più, ma che abbiamo comunque assorbito. Il mio amico si sposa è uno dei pezzi, pure se sembra leggero e fa ridere, a cui tengo di più. Anche Fulminacci, quando gli ho fatto ascoltare il disco, l’ha scelto come suo pezzo preferito. Quando l’ho mandato a mio padre invece mi ha detto: «È la cosa che assomiglia di più a Rino Gaetano dopo Rino Gaetano».
Alla fine mi sono trovato a chiedermi: sposarmi è quello che vorrei anche per me o lo voglio solo perché si sposa lui o solo perché ho 35 anni? Mi fa sentire più grande farmi queste domande, però mi piace, che altro dovrei chiedermi a questa età? Non mi voglio fare le domande di un ventenne, sarebbe patetico. Un giorno mi sveglio e dico «forse dovrei crescere pure io e fare una famiglia», un giorno mi sveglio e dico «no, non mi va assolutamente». Come hai detto te, è un album con una una crisi di mezza età, però detto così fa un po’ schifo, non farci il titolo con questa cosa perché non lo faccio più uscire il disco e darò la colpa a te.
Non è che mi vergogno di avere 35 anni, anzi, io mi sento molto meglio adesso di quando ne avevo 25. A 25 anni ero sotto a un treno, non sapevo minimamente che cosa fare, ero proprio uno sbandato, adesso mi sento molto più sereno, più realizzato, in pace con me stesso, non litigo più con i miei genitori come litigavo a 20 anni. È la vita, ogni età è relativa.
In Non lo sapevo invece canti: “Ero soltanto felice e non lo sapevo”. La felicità è qualcosa di cui ci si accorge sempre dopo?
Sì, assolutamente. Nel pezzo dico anche “eri soltanto infelice e non lo sapevo”, mi piaceva contrapporre insieme queste due cose, dove nonostante tutto, anche se ero in una relazione orrenda all’epoca, una relazione che mi ha fatto tanto male, col senno di poi riesco comunque a vedere il bicchiere mezzo pieno e quindi in realtà ero anche felice, sono stato felice, ma non me ne sono accorto. Mi piace sempre pensare che le cose che fai abbiano un senso, anche quelle sbagliate, anche gli errori, quindi nonostante il grande dolore che ho provato mentre scrivevo la canzone, penso sempre che sia servito tutto, perché quella storia mi ha portato ad avere una storia molto bella dopo, mi ha migliorato, mi ha fatto capire cosa non essere, dove non sbagliare. Io tendo a imparare le cose solo sbagliando e questo comporta prezzi alti da pagare, però poi riesci a migliorare come persona.

Foto: Simone Biavati
L’omaggio a Forrest Gump nel teaser, un disco che parla per immagini: sei un appassionato di cinema?
Sono molto appassionato di cinema, soprattutto anni ’90. In quel decennio sono usciti tra i film migliori per i miei gusti: Forrest Gump, American History X, Titanic, penso a Tarantino, a film tipo Will Hunting. Avevano una poetica dietro che non si è più vista. Escono ancora dei film, ma non hanno più quella poetica, quella speranza, i film degli anni ’90 finiscono sempre con positività, c’è sempre un messaggio, forse era un’epoca in cui speravano di più. Anche i film violenti erano diversi, ti lasciavano qualcosa, adesso sono violenti e basta. Il cinema è molto legato al mio modo di scrivere perché io mi faccio i film in testa, questa è la verità. Sono tutte immagini: vorrei andare in America, vorrei fare un bambino, vorrei andarmene in moto. Mentre lo scrivo, io sono lì. Mi piacerebbe pure farlo un film, non come attore e neanche come regista, ma scrivere la sceneggiatura, magari aiutato da qualcuno perché non so bene tecnicamente come si fa. Mi piacerebbe immaginare le cose che dice l’attore.
Chi sono i registi che ami oggi?
Ho apprezzato Pietro Castellitto con Enea, nonostante a parecchi miei amici non sia piaciuto. Io l’ho visto due volte, ci sono delle cose un po’ strane, però penso che Pietro, nonostante abbia solo 30 anni anni e sia figlio d’arte quindi con una potenzialità molto più commerciale, si sia accollato questa dimensione più profonda. Tra i giovani lui è quello che mi piace di più. Poi amo Sorrentino.
Sorrentino lo mettiamo tra i giovani?
No, infatti, Sorrentino lo amo a prescindere. Tra i giovani mi piacciono i fratelli D’Innocenzo, Favolacce su tutti, America Latina l’ho amato meno, e ho appena iniziato la loro serie, Dostoevskij, che però mi ha dato un po’ fastidio. Ma sono bravi, ce ne fossero di registi così. Poi seguo un altro regista giovane, Simone Bozzelli.
Che ha diretto Patagonia, opera prima molto interessante secondo me.
Molto bello. Conosco personalmente il direttore della fotografia di Patagonia, che è un amico mio, fa tutti i miei video, ha fatto pure il mio teaser basato su Forrest Gump.
Sempre nel teaser provi a parlare della vita, di cosa voglia dire affrontare qualcosa che nessuno sa esattamente cos’è mentre sta accadendo. E di fronte alla difficoltà di definire quello che viviamo, chiudi con: «È meglio se torniamo a casa». Cos’è casa per te in questo momento?
«Meglio se torniamo a casa» per me vuol dire tornare a fare musica come piaceva a me, senza pensare troppo ai risultati che questo disco porterà, senza pensare alle aspettative delle persone che lo ascolteranno, senza pensare troppo ai discografici, concentrandomi solo sul bello di fare canzoni in maniera pura, spudorata, sincera e onesta.
Non vuoi tornare né in un certo tempo né in un certo luogo specifico quindi?
Più che altro, è tornare a fare le cose in un certo modo. Torniamo a casa per me vuol dire anche andiamo verso casa, non solo proiettati indietro, ma anche in avanti. Volevo ricordarmi com’è bello fare questo lavoro, scrivere canzoni, anche se è diventata la mia quotidianità. Ma volevo anche ricordarmi di vivere perché, per come scrivo io, se non vivo, non scrivo. Ho bisogno di vivere in maniera intensa, nel bene e nel male, basta che succeda qualcosa perché quando non succede niente mi deprimo. Tornare a casa vuol dire anche riprendere in mano la mia vita, perché ho avuto dei momenti un po’ delicati, un po’ rognosi, dove ho fatto a botte con me stesso. Uno dei due ha vinto, però quello che ha vinto vorrei che adesso si godesse la vittoria.
Il 7 giugno suonerai al Circo Massimo e il 22 giugno a San Siro, il punto di arrivo più alto per qualsiasi artista in Italia. Ti ricordi invece qual è il primo locale dove hai suonato come Gazzelle?
Certo. Il ragazzetto, Flavio Pardini, dentro a un baretto a Trastevere. Nessuno sapeva che cantavo, che scrivevo. Ho detto: basta, devo dirlo a tutti e lo dico una volta sola. Quindi ho fatto un concertino in un bar dove andavo sempre a bere. Sotto c’era un magazzino, gli ho chiesto se potevamo farlo diventare una specie di posto per suonare. C’erano una trentina di persone, gli amici, qualche parente, e la gente è rimasta sorpresa, è cambiato da così a così il modo in cui mi vedevano. Ho guadagnato tanto con me stesso, però ho pure perso delle cose perché ho assunto un ruolo diverso nel gruppo, è stato un vero coming out artistico.
E poi il Monk, come primo concerto di Gazzelle, a marzo 2017, quasi otto anni fa. Il disco è uscito lo stesso giorno, erano uscite tre canzoni prima. C’erano 600 persone, all’epoca erano tantissime, io pensavo che ne sarebbero venute 100, ma tanto non avevo nulla da perdere. E invece mi ricordo il mio amico in camerino che mi ha detto che era sold out e io non ci volevo credere. Erano tutti impazziti, gente affogata, hanno cantato tutte le canzoni, che poi erano otto. Il concerto è durato poco, ho fatto i bis tante volte per farlo durare un po’ di più. Rimane il concerto più bello della mia vita perché è stato il primo e lì ho capito che stava succedendo qualcosa. Per la prima volta non c’erano solo i miei amici, c’erano altri sconosciuti che stavano lì per me.
L’anno scorso hai pure partecipato a Sanremo, quest’anno no. Riprendendo il tuo titolo, non è che l’indie è morto quando è arrivato su quel palco?
Non lo so, comunque non sono stato il primo a portarcelo, quindi in caso non l’ho ucciso io. A Sanremo ho portato una canzone che mi piaceva tantissimo (Tutto qui, ndr), che secondo me è tuttora una delle più belle del disco, non è una hit, però sono andato lì per cercare un po’ di orecchie in più per quello che faccio, quindi va bene così. È un’esperienza forte, certo non la farei tutti gli anni. Se ci vai tre volte in quattro anni invece è un altro discorso, ma se ci vai una volta nella vita è come andare in Giappone…
Un’esperienza esotica.
Esatto.