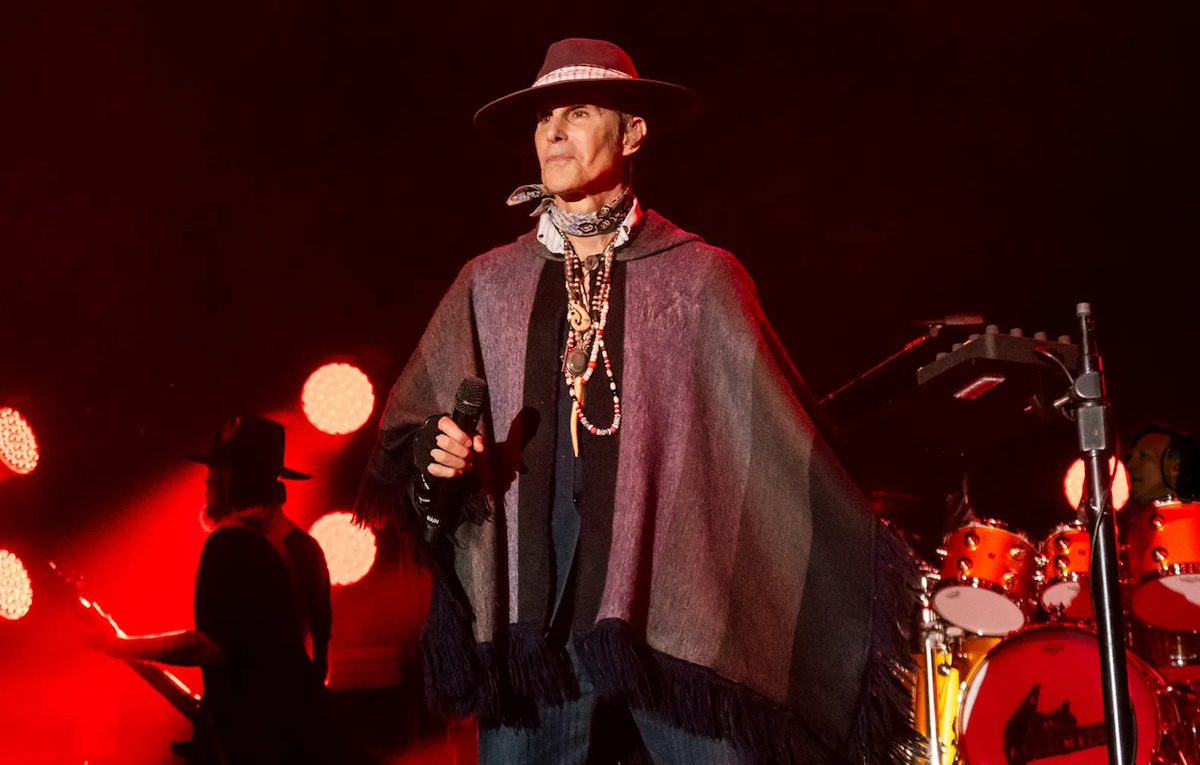Chiedi chi erano i Velvet Underground. Cioè io, ad esempio, non ho nulla contro i Måneskin: anzi, mi sono simpatici. Non so a voi, ma secondo me funzionano, sono fighi, hanno talento. Si capiva già da X Factor. Poi però senti loro: tipo qualcosa come un battito, un ronzio, un suono che non puoi decifrare, che lavora dentro, che avanza di continuo. E ti risveglia energie e sentimenti che pensavi smarriti. E allora ciaone. Ascolta pure i Måneskin, ma – s’il vous plait – chiedi chi erano i Velvet Underground. Più che una band, un manifesto: un riferimento culturale che su un palco (de)scrisse un’epoca. Quelli di Heroin, di Sunday Morning, di Venus in Furs: gli stessi che “rubarono” a un frigorifero la frequenza fondante della loro musica e che ai loro concerti tra il pubblico si ritrovavano Nureyev a ballare. E che di successo commerciale pochino, ma in quanto a mitologia…
Insomma, sì, una bella storia: che adesso racconta, esaltandone la svolta radicale e la rivoluzione ipnotica, il documentario di Todd Haynes (prossimamente su Apple TV+), uno che con l’ambiente musicale (da Velvet Goldmine ai mille Dylan di Io non sono qui – I’m Not There) ha sempre avuto un feeling particolare. E che qui non si smentisce, rielaborando in modo affascinante e per nulla scolastico un ricchissimo e variegato materiale di repertorio, affiancando attraverso l’uso insistito dello split screen, alla ricerca delle tessere che compongono il mosaico, i volti e le suggestioni di allora alle testimonianze attuali di reduci e sopravvissuti. Alternando le canzoni anche alle parole (messaggi vocali dall’altrove) di chi – come Lou Reed, Nico (l’iconica bionda di ghiaccio a cui Susanna Nicchiarelli ha dedicato un bellissimo film) o David Bowie, che del gruppo fu un grande estimatore – è nel frattempo andato avanti.
Ne viene fuori, oltre che alla genesi e alla trasformazione (sino allo scioglimento) di una band destinata a creare sonorità mai udite prima che cambiarono il corso della musica, lo spaccato di uno periodo di estremo fermento e ispirazione, dove le arti – musica, cinema, pittura, fotografia… – comunicavano come non avevano mai fatto prima e non avrebbero mai fatto nemmeno dopo. Un’osmosi fortunata e irripetibile che trovò la sua massima espressione nella Factory di Andy Warhol, padrino di una band che aveva nell’ombroso e carismatico Lou Reed e nel genio avanguardista di John Cale i Lennon e McCartney della controcultura, che poi era l’unica cultura che contasse davvero qualcosa.
Intellettuali, antiborghesi, capaci di farti dialogare l’R&B con Wagner, i Velvet, fenomeno profondamente newyorchese in total black (in contrapposizione ai coloratissimi hippie e figli dei fiori che spopolavano sulla West Coast, dove loro invece venivano visti come degli alieni), subirono l’influenza benefica della Beat Generation, andando però anche molto oltre. Non sfugge che la loro (specie prima dell’uscita di Cale, “licenziato” da Reed) fu la colonna sonora del cambiamento: che Haynes rievoca andando alla fonte, facendosi accompagnare nel viaggio dai protagonisti, grandi e più piccoli, di quel momento. Una famiglia che si sfaldò restando comunque una famiglia: portandosi dietro qualche incomprensione, ma rimpianti nessuno.