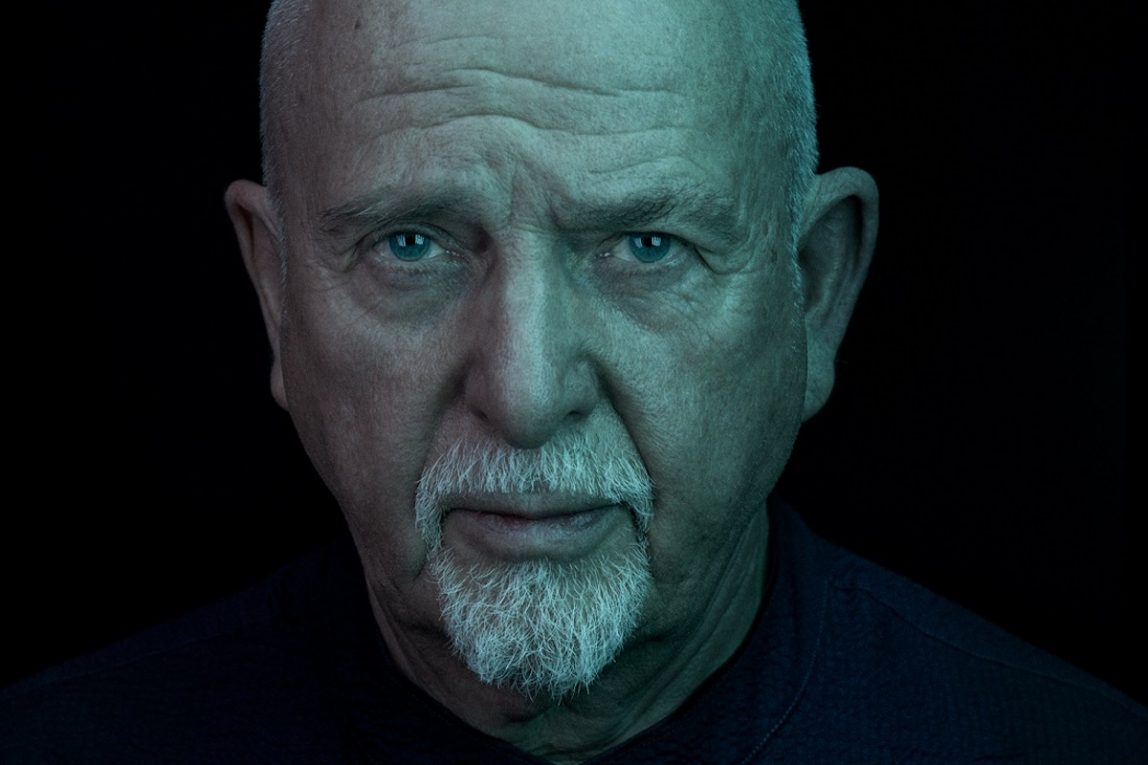Quanto tempo ci vuole per scrivere una canzone? Forse sette anni, forse quindici minuti. I sette anni sono quelli serviti a Leonard Cohen per Hallelujah, il quarto d’ora è quello che sarebbe servito a Bob Dylan per scrivere una qualunque delle sue. Lo avrebbe detto lo stesso Dylan, smargiasso, a Cohen, un giorno degli anni Ottanta, in un caffè di Parigi. La rivalità/amicizia tra i due è andata avanti fino alla fine.
Un mese prima di morire, nel 2016, Cohen presentò il suo ultimo album You Want It Darker nei giardini del consolato canadese a Los Angeles. C’ero anch’io, insieme ad altri giornalisti. Cohen era fiaccato dalla malattia, e si vedeva. Ma restava il gran figo e l’uomo elegantissimo che è sempre stato: il completo scuro, la camicia, il cappello. E il sorriso misterioso e sapiente di chi ha accumulato vita e saggezza (non sempre le cose coincidono). Quel giorno, proprio poche ore prima del nostro incontro stampa, era stato annunciato che il premio Nobel per la Letteratura sarebbe andato a Bob Dylan. E giù tutti a chiedere a Cohen che cosa ne pensasse. Era contento per Bob, che altro poteva dire? Disse anche che quella era una buona notizia, significava che i confini tra poesia e canzoni, invisibili per lui che aveva scritto poesie e poi canzoni per tutta la vita, adesso erano invisibili anche per tutti, anche per i signori del premio Nobel.
Hallelujah: Leonard Cohen, a Journey, a Song, documentario di Dan Geller e Dayna Goldfine presentato alla 78esima Mostra del Cinema di Venezia, entra proprio nello “specifico poetico” di Cohen. C’erano già stati almeno altri due documentari su Cohen, Leonard Cohen: I’m Your Man di Lian Lunson e Marianne & Leonard: Words of Love di Nick Broomfield. Ma, in questo nuovo, il taglio scelto è particolarmente acuto. Si è scelta la sua canzone più famosa, la più coverizzata, la più utilizzata a eventi e matrimoni, la più martoriata dai concorrenti di talent show, l’unica finita addirittura in un cartone animato (Shrek!) e se ne racconta la genesi. È una vera e propria analisi filologica.
Per quasi dieci anni, Cohen ha riempito i suoi quaderni di circa 180 versi diversi per Hallelujah. Ogni riga pare che sia stata riscritta 250 volte, in media. Mentre guardavo il film, pensavo che in futuro un lavoro del genere non si potrà più fare. Finita la civiltà della carta e dei taccuini, ogni versione cancella la precedente e dei tormenti della creazione non resta traccia, tutto è ripulito dal cursore a destra in alto delle nostre tastiere.
Quindi il film di Geller e Goldfine finisce con l’essere un omaggio a un modo di pensare e creare con le parole (canzoni o poesie o romanzi, fa lo stesso) che si è estinto. Ma è anche una biografia indiretta di Cohen, attraverso il destino inaspettato di Hallelujah che uscì per la prima volta in un album, Various Positions (1984), che però non venne pubblicato negli Stati Uniti, rifiutato dalla casa discografica. Fu la versione di Jeff Buckley, negli anni Novanta, che rese la canzone popolare. Così, al di là delle molte interpretazioni (John Cale, Rufus Wainwright, Bono), Hallelujah è diventata una sorta di preghiera moderna, senza che il suo autore l’avesse programmato.
Ci sono brani di Cohen cantautore più interessanti (per me, anche tra le famose, Bird on a Wire, immensa) e ci sono testi del Cohen poeta più profondi, eppure l’involontario appeal di massa di Hallelujah, così ben spiegato nel film, rende giustizia alla storia di un uomo terribilmente attraente nei suoi estremi: donnaiolo e spirituale, ricco eppure sobrio, ebreo ortodosso d’educazione che passa sei anni della sua vita in un monastero zen. Un uomo che non ha cercato il successo ma l’ha trovato dentro la magia di un’intuizione felice. Che cosa c’è di più poetico?