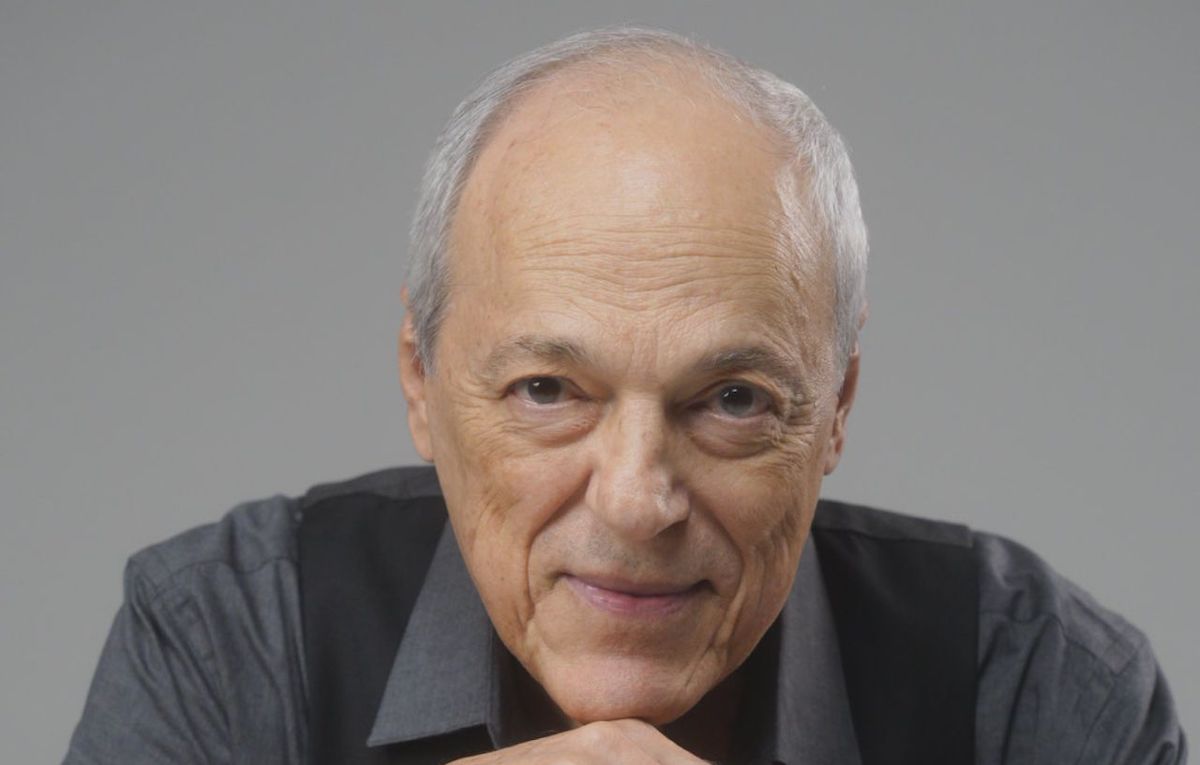Non l’ha voluto la Mostra di Venezia, non l’ha preso nemmeno la Festa di Roma, è uscito in sordina. S’era dunque sparsa voce, nel cosiddetto “ambiente”, che il terzo film diretto da Kim Rossi Stuart dopo il bellissimo esordio Anche libero va bene (2006) e il più zoppicante Tommaso (2016) non fosse niente di che. E, invece, è uno dei titoli più onesti dell’annata. C’è una passione evidente e sincera nel ritratto del “ranchero” (lo stesso regista) che ritrova il figlio (Saul Nanni, molto ben diretto). Un film italiano atipico, che insegue certe rotte da frontiera pur restando local e personalissimo. Bravo Kim.
Un solido romanzo (di Sandro Veronesi, che si è meritato il secondo Premio Strega dopo Caos calmo), una solida autrice (Francesca Archibugi), un soldissimo cast (Favino, Smutniak, Moretti, Morante, Porcaroli, and counting…). E un ancor più solido senso per il mélo classico, che, udite udite!, si può fare anche da noi. C’è il passo del cinema francese borghese (senza offesa: anzi), nell’adattamento di un libro che sembrava impossibile portare sullo schermo, considerati i continui salti avanti e indietro nel tempo. E invece è proprio quella, la (prima) scommessa vinta.
Già attrice per Gabriele Muccino (era l’indimenticata protagonista femminile di Come te nessuno mai) e sceneggiatrice nei ranghi di Groenlandia (Moglie e marito, Il campione, Marilyn ha gli occhi neri), Giulia Louise Steigerwalt debutta dietro la macchina da presa e dimostra da subito un occhio sensibilissimo, da autrice tout court. Un film corale fatto di destini incrociati e frustrazioni condivise (vedi il personaggio del sempre adorabilmente stroppicciato Fabrizio Bentivoglio), con uno sguardo fieramente femminile che è una boccata d’aria, per il nostro panorama. E la coppia Barbara Ronchi-Thony è da applausi.
Il leggero – nel senso più bello del termine – Gianni Zanasi (Non pensarci, Troppa grazia) non perde il tocco, ma si spinge in territori cupi finora inesplorati. Con un affresco sociale e politico ambiziosissimo, ambientato in una Roma deserta (causa pandemia: ma per una volta i lockdown sono stati usati bene) e minacciata da una guerra che sta per sconvolgere l’Europa (tu chiamala, se vuoi, profezia). Edoardo Leo becca un ruolo giustissimo, Miriam Leone si riconferma perfetta per la dramedy, Giuseppe Battiston regala una delle sue performance migliori. Ma il film non l’ha capito praticamente nessuno: peccato.
Altro giro, altra giovane autrice. Giornalista e documentarista apprezzata (I Am the Revolution), Benedetta Argentieri firma il suo progetto più complesso, in cui si butta in prima persona. La lunga intervista a Tooba Gondal, una delle più tristemente famose jihadiste britanniche, va al cuore di uno dei temi più caldi della situazione geopolitica attuale. Ma è anche un saggio sul documentario, che studia, approfondisce, e non si schiera. Lasciando aperte tutte le (spinosissime) domande. Magistrale.
Altro giro, altro romanzo Premio Strega (stavolta di Paolo Cognetti). Che non era, allo stesso modo, facile da adattare. Nelle mani dei belgi Felix van Groeningen e Charlotte Vendermeersch, un libro così italiano (e una produzione rigorosamente “made in Italy”) trova il suo giusto respiro internazionale. Luca Marinelli e Alessandro Borghi, di nuovo coppia dopo quel Non essere cattivo da cui per entrambi era cominciato tutto (o quasi), sono bravissimi e commoventi nella parte dei due amici che si perdono e si ritrovano tra vette letterali ed esistenziali. Regia, fotografia e musiche fanno il resto. Premio della giuria a Cannes.
Dopo l’impeccabile period piece sulla famiglia Scarpetta (Qui rido io, starring Toni Servillo), Mario Martone resta come sempre nella sua Napoli per una storia solo apparentemente più piccola, ma in realtà sempre in grado di raccontare una città e una comunità piena di contraddizioni. Dal romanzo di Ermanno Rea, viene fuori uno psycho thriller tesissimo e nerissimo, caricato non solo sulle spalle di un Pierfrancesco Favino sempre più trasformista, ma anche dei parimenti giganteschi Tommaso Ragno e Francesco Di Leva. Rimasto senza premi a Cannes 2022, è il titolo italiano scelto per la Oscar Race 2023.
Altro autore che forse non era mai stato così cupo è il nostro amatissimo Paolo Virzì. Che, in una Roma in cui non piove più (splendidi effetti visivi, per non dire della fotografia di Luca Bigazzi), immagina un affresco corale dove tutti sono miserabili, soli, incattiviti: la società di oggi? Praticamente sì. Tra fallimenti, rabbia, violenza, pochissima solidarietà sociale, ognuno dà il peggio di sé. Ma c’è (forse) una speranza. Cast grandioso (Orlando, Mastandrea, Ragno, Lietti, Bellucci, Fanelli, Marchioni, Serraiocco, Montesi e moltissimi altri) e struttura ambiziosamente altmaniana (che non fallisce mai). Anche questo incompreso da molti: problemi vostri.
“Solo” un documentario su Ennio Morricone? No. Nelle mani dell’amico e “collega” Giuseppe Tornatore, Ennio (basta il nome) viene raccontato come se si componesse la partitura della sua vita. Gli inizi, i successi, ma anche i momenti privati, e quell’abnegazione e dedizione nei confronti del lavoro che ne hanno fatto un uomo di musica come pochissimi altri del ‘900. Il montaggio è da studiare nelle scuole di cinema (vedi la sequenza sulla genesi di In ginocchio da te), la commozione arriva puntuale. Un “filmone” in tutti i sensi, giustamente premiato anche dal pubblico: chi l’ha detto che i documentari di quasi tre ore non possono funzionare al botteghino?
Un film italiano? Sì, al 100%. Luca Guadagnino, finalmente premiato a Venezia con il Leone d’argento per la regia, è davvero l’erede naturale di Bernardo Bertolucci: per lui il cinema è un atto “locale” e artigianale, ma che dalla scala italiana può (e deve) allargarsi, per diventare bigger than Rome. Dopo i grandi risultati precedenti, con Bones and All firma il suo film più sorprendente e solo sulla carta “piccolo”: una storia nata Young Adult (il romanzo di partenza è di Camille DeAngelis) che diventa il coming of age di una giovane donna (l’eccezionale Taylor Russell) e di una generazione. Il tema del cannibalismo, “usato” malamente dalla stampa, è in realtà la metafora del dark side di ognuno di noi. Ah, ci sono anche Timothée Chalamet, usato in “anti-ruolo” rispetto a Chiamami col tuo nome e uno spaventoso Mark Rylance: bravissimi entrambi. Un capolavoro, che il grande pubblico capirà col tempo.