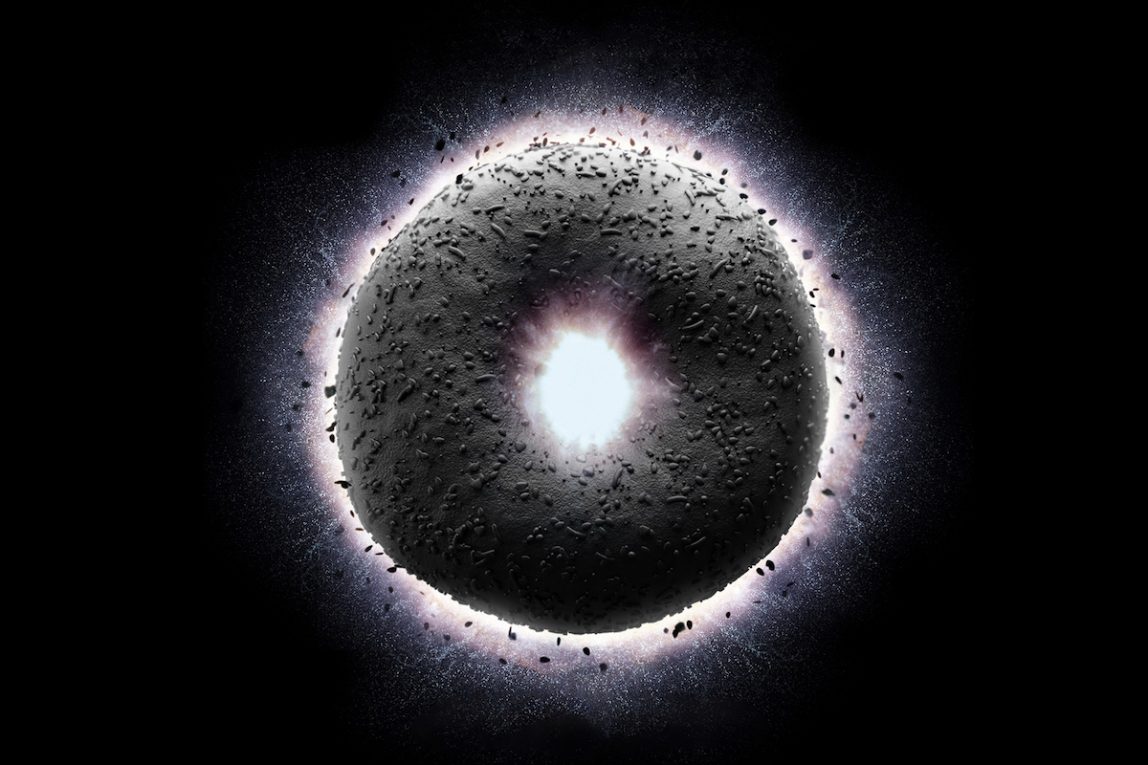Poche ore di sonno (ma stavolta hanno fatto in fretta, è durato tutto diciamo poco) e primo caffè americano come loro, ecco il commentino sugli Oscar di ieri, l’annata in cui ha vinto come annunciato Everything Everywhere All at Once e tutto è cambiato. E invece non è cambiato niente – chi l’avrebbe mai detto, eh?
Ecco le domande che tutti vi state facendo (come no): Everything Everywhere è un capolavoro? (Risposta breve: no.) Everything Everywhere è un film rivoluzionario? (Nemmeno.) Everything Everywhere riscriverà le regole di Hollywood? (Idem come sopra.) Everything Everywhere è un film con molte buone idee, un ottimo (e furbissimo) senso del tempo e, soprattutto, il talento nel farci credere che quel morticino ambulante che ci ostiniamo a chiamare cinema sia ancora vivissimo.
Soprattutto, è il titolo con cui i premi Oscar, che, come tutte le vecchie istituzioni novecentesche restano gli elefanti che sono anche con un po’ di vernice fresca rimediata grazie al bonus facciate (ogni riferimento a partiti di centrosinistra italiani non è voluto), fingono di aver fatto appunto la rivoluzione, e invece.
Everything Everywhere è il trionfo definitivo di A24, lo studio nato indie che sta dettando il nuovo mainstream hollywoodiano, rivelandosi però molto più conservatore di quel che si crede e si legge: il primo grande successo diciamo così istituzionale è stato con Moonlight, un film travestito da contemporaneo per il contenuto lgbtq e in realtà pericolosamente reazionario – così come The Whale, che si è aggiudicato due premi stanotte (trucco-e-parrucco e, soprattutto, miglior attore a Brendan Fraser).
Ma abbiamo un grande bisogno di storie, e Everything Everywhere ce ne racconta una bella ed esemplare: due dive sessantenni, Michelle Yeoh e Jamie Lee Curtis, che sfatano la maledizione di un’era forse estinta (“A Hollywood ci sono tre età per le donne: bambola, procuratore distrettuale e A spasso con Daisy“, diceva qualcuno); una scrittura e una confezione che mettono insieme la tradizione d’auteur da festivalini West Coast col multiverso da cinecomic; e, più di tutto, un arco narrativo dentro e fuori dello schermo che consente ai titolisti di tutto il mondo (noi compresi) di raccontare la presunta parabola edificante che c’è dietro.
Ecco, le storie. Nel suo moscissimo monologo iniziale, Jimmy Kimmel dice che a Hollywood storie e idee scarseggiano al punto che Spielberg, nel suo ultimo film, ha dovuto parlare di Spielberg. E invece di storie è pieno il quartetto d’attori premiato ieri: Michelle Yeoh prima diva asiatica – e celebrata in Everything Everywhere come diva reale e totale – a vincere il premio di miglior attrice; Jamie Lee Curtis che è Hollywood dynasty, mica la nepo baby che certe inchieste da scoperta dell’acqua calda (nel cinema lavorano moltissimi “figli di”, me pensa te!) ci vogliono raccontare; Brendan Fraser l’ex belloccio poi vittima (parola chiave) del Sistema e di sé stesso che finalmente può urlare “sono un attore!”; Ke Huy Quan lanciato da bambino nel cinema che contava (parlando sempre di Spielberg: Indiana Jones e il tempio maledetto, I Goonies) ma poi costretto ai ruoli etnici e dimenticato dal cinema stesso, prima di vincere stanotte come non protagonista.
Sono queste le storie che fanno i titoli dei giornali e – cosa che oggi vale ovviamente di più – i post online. Di fronte a uno scontato “Cate Blanchett ha vinto il terzo Oscar” (e Blanchett era/è la più brava di tutti, uomini e donne, senza gara) il responso generale sarebbe stato un: embè? Grazie al cazzo. E oggi il merito in quanto tale non vale più, non tira più.
Certo, una cosa probabilmente è cambiata: se una volta vincevano i film fatti di soldi (spesi e guadagnati) e di meraviglia escapista e consapevolmente naïf – dunque, tra i titoli di questo giro, Top Gun: Maverick e Avatar 2 – ora vincono invece i (pur interessanti) film che possono vantare un patentino dell’inclusione a prova di attivista di Instagram. Questo è il vero (e gattopardianissimo) cambiamento.
Quest’anno il titolo più bello (anche qui senza gara) tra i candidati a miglior film era Gli spiriti dell’isola, che non ha vinto. E tra i film più belli candidati in generale – corti o lunghi non importa, abbiamo imparato che ormai non fa più differenza – c’era Le pupille di Alice Rohrwacher, che non ha vinto. La miglior colonna sonora era quella del bistrattatissimo Babylon di Chazelle, che non ha vinto. Il più bel film internazionale, come si dice oggi, era Decision to Leave di Park Chan-wook, che non è stato manco candidato (e peraltro quello era un vero film asiatico, altro che Everything Everything e lo storytelling che ci hanno venduto).
Ma davvero volevate che gli Oscar premiassero i migliori? Davvero vi aspettavate una sorpresa, una novità, una cosa che non fosse Hollywood che continua a raccontare sé stessa, nella notte più importante di Hollywood?