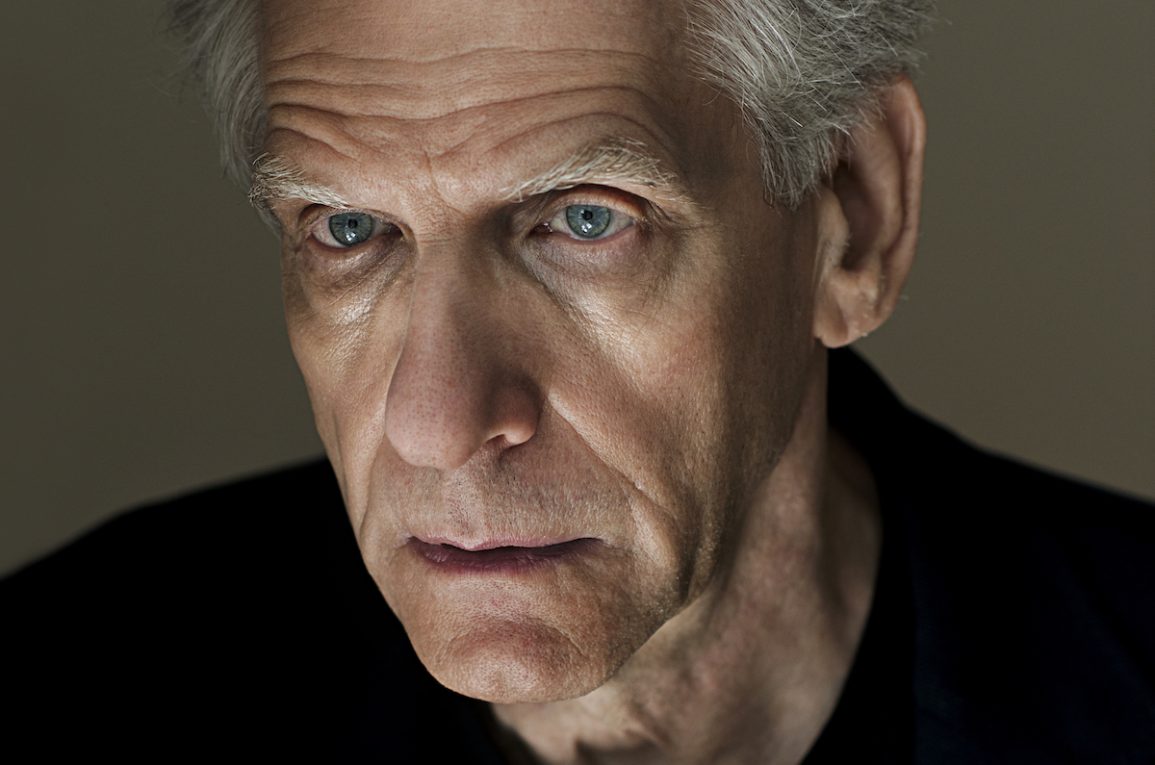«È un progetto ambizioso, sì, ma la vera fatica è quel che c’è stato attorno, la dialettica coi francesi… del resto, arriva un italiano e va a mettere il dito nel cuore del cuore della loro Storia». Gianluca Jodice va dritto al cuore del cuore della questione, e chiacchierarci è già bello per questo. Parliamo del suo film «politicamente delicato, perché non è un film banalmente sulla rivoluzione. Io scelgo l’altro punto di vista, e se lo fai in tempi manichei, per non dire idioti, come i nostri, sai fin dall’inizio che andrai a scontrarti con qualcuno». Dopo aver aperto Locarno quest’estate, Le déluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta, che ha scritto con Filippo Gravino, arriva il 21 novembre nelle sale italiane e a Natale in quelle francesi, che saranno il vero banco di prova. Intanto Jodice, che ha esordito già grandicello quattro anni fa con Il cattivo poeta, si prepara alla guerra, e forse un po’ ci sguazza.
«Era una sfida, e infatti siamo stati puniti», dice a proposito del mancato passaggio a Cannes, che sembrava la destinazione naturale di questa fotografia degli ultimi giorni, appunto, di Maria Antonietta e Luigi XVI (interpretati, per di più, da due star francesi: Mélanie Laurent e Guillaume Canet), spazzati via dalla rivoluzione, passati da dèi a uomini a morti quasi metafisici, in un racconto dove c’è la Storia, sì, ma soprattutto il nostro modo di guardarla a ritroso, cercando di leggerla con gli occhi e i codici del tempo corrente. È stato punito, diceva Jodice del suo film, «ma va bene così. Non dico che non sono stato furbo a fare questo film, perché sarebbe una frase retorica, e in più un regista non può non essere furbo, almeno un po’. Ma nel mio concepire un film non uso mai la furbizia, c’è anzi sempre la complessità. La furbizia è un modo per ottenere magari delle cose, ma ti costringe a fermarti, a non andare in fondo alle cose. Io faccio un film ogni due o tre anni, e voglio fare solo quello. È una disciplina che mi diverte, mi eccita, perciò non la lascio inquinare da cose che sono esterne, non proficue. Non è stolidità, è il mio metodo, la mia concezione del lavoro».

Gianluca Jodice sul set con Guillaume Canet. Foto: Fabio Lovino
Sono tempi manichei, forse idioti, certamente poco propensi ad accoglierla, quella complessità. E invece Jodice mi sembra il tipo che va a stanarla di proposito: prima degli ultimi re di Francia, con tutte le ombre che si portano dietro, c’era stato appunto il “cattivo poeta” D’Annunzio, rimasto nel canone letterario che studiamo a scuola ma figura oggi più che mai controversa, scomoda, quasi rimossa. «Dici che me le vado a cercare…», ride. «È che in Italia saremo per sempre condannati a questa guerra dei guelfi e dei ghibellini, che seppellisce la Storia. Ma forse succede ovunque. Uno può pensare che Le déluge sia un film passatista, e invece – lo vedo anche dalle prime proiezioni pubbliche che sto facendo – la risposta intellettuale ma anche emotiva che suscita è assolutamente contemporanea, anche se io non avevo cercato un’analogia con il presente, almeno non razionalmente. Viviamo in tempi in cui c’è la sensazione quasi apocalittica che la Storia sta voltando pagina in maniera irreversibile, c’è proprio la percezione di una sorta di strappo. Ed è forse per questo che Le déluge viene preso come un film che parla all’oggi».
Per Jodice, però, il cinema è prima di tutto una questione di stile, non di politica. «E anche lo stile, secondo me, fa pensare al pubblico di trovarsi di fronte a una storia contemporanea. Il cattivo poeta era molto più classico, era il mio primo film quindi ho giocato un po’ sulla difensiva. Qui ho rischiato molto di più, il secondo atto è tutto girato con la camera a mano, che è una scelta molto rara, se non unica, in un film storico. Ognuno dei tre atti ha un suo codice visivo, c’è molta più consapevolezza stilistica, forse anche di radicalità».

Foto: Fabio Lovino
Il primo atto si intitola Gli dèi, e qui invece andiamo forse un po’ fuori dalla contemporaneità: il nostro è un mondo senza più dèi, in cui i governanti vincono perché si travestono strumentalmente da comuni mortali, spazzini, dipendenti del McDonald’s. «Be’, quell’idea di investitura divina non può più esistere, forse l’ultima rappresentante in questo senso è stata Elisabetta, che ha saputo conservare un’aura di intangibilità. Ma era anche una donna terrena, molto più terrena di una Maria Antonietta. Mio padre, che è un professore di Filosofia ma anche un grande appassionato di cavalli, mi diceva sempre che Elisabetta era una grandissima esperta di purosangue». Un altro strappo, un altro cortocircuito che squarcia la Storia, recente o passata che sia. «Lì c’è il nucleo di tutto. Proprio a casa di mio padre ho letto questo libro che ripercorre il processo a Luigi XVI [Il prigioniero del tempio – Detenzione, processo e morte di Luigi XVI di Cléry], e la mia idea è stata subito quella di fare un film sulla sua ultima notte: l’incontro con Maria Antonietta e poi con i figli, con il prete… Una specie di requiem in tempo reale di un uomo e di un’epoca, perché mai come in lui hanno coinciso l’uomo e il regime. Poi, documentandomi, ho allargato quella storia a tutti i mesi di prigionia. Ma l’interesse verso un tema non è mai sufficiente, ci dev’essere l’innamoramento, e per me l’innamoramento è stato, sempre in quel libro, il momento in cui si racconta di questo salotto di rivoluzionari che si riunirono mentre sotto passava il corteo che portava il re al patibolo. La testimonianza raccolta da Cléry dice che c’era un’aria malinconica, tutt’altro che gioiosa; e che questo rivoluzionario a un certo punto disse: “Il re amava molto il mio cane”, che è la frase con cui chiudo il film non perché sia un aneddoto divertente, ma perché è la chiave di lettura dell’intero racconto. È il livello edipico presente in ogni rivoluzione: odi il re e lo uccidi, ma il re è tuo padre, e in questo caso è anche Dio. Puoi fare la rivoluzione solo su uccidi tuo padre, verso cui comunque continuerai, in un modo o nell’altro, a provare amore. I francesi ci sono riusciti, noi una rivoluzione non l’abbiamo mai fatta proprio perché invece siamo troppo edipici. Però tutti i film sulla Rivoluzione francese hanno mostrato i rivoluzionari con il viso sporco che chiedono il pane e uccidono i padroni, e che per questo son contenti; e questa è una falsità, o almeno solo la superficie. La mia idea di diluvio è il chiedersi: e ora? Abbiamo ucciso il re, abbiamo azzerato tutto, e adesso che succede? È l’ansia della vittoria, che è un sentimento che in pochi hanno raccontato. Per usare le parole di Giona [A. Nazzaro, direttore del Festival di Locarno], lo scandalo di questo film è che racconta la Storia nel momento in cui si svolge. Di solito i film storici risultano noiosi perché approcciano quegli eventi con valori acquisiti nei secoli successivi: sai già com’è andata e come la devi pensare. Invece quando irrompe la Storia è sempre un momento ambiguo, un trauma».
Le déluge è già stato accusato di essere monarchico, qualunque cosa significhi oggi. «È uno schematismo insopportabile, ma io sono pronto a tutto. L’idea secondo cui il passato è sempre migliore è una cazzata, ma fa parte dell’idiozia di quest’epoca in cui bisogna sempre esprimere con foga e rapidità un pensiero anche quando non lo si ha. Non è un’affermazione da intellettuale snob, la mia, è proprio la constatazione di un modo di fare che decide gli umori e vira le cose del mondo. Questa è la vera stupidità».

Mélanie Laurent e Guillaume Canet in una scena del film. Foto: Stefano Delia
L’altra eventuale accusa che viene mossa a Jodice è l’essere poco italiano, quando invece, almeno a me, sembra voler fare quel cinema che è sempre stato nostro, il cinema degli autori italiani che giravano in e per l’Europa, raccontando storie più grandi del loro salotto a Prati. Le déluge in particolare mi fa inevitabilmente pensare al Mondo nuovo di Ettore Scola. «Anche questa è una cosa molto italiana, molto provinciale. Io ho fatto il primo film in Italia e in italiano, il secondo in francese, e il terzo lo farò in inglese. Io quella sindrome non ce l’ho, ho anzi l’ansia di andare, ma non di andare per andare, lo faccio proprio perché il territorio italiano non regge come credibilità, quando devi raccontare certe cose. Di questo parliamo spesso con Paolo [Sorrentino, produttore associato del film]: ci sono storie che non puoi ambientare a Latina. Magari ci sono idee e sceneggiature bellissime, ma semplicemente non si possono fare in Italia. Anche se finora ho fatto due film in costume, io ho questa grande propensione per il contemporaneo, e allora inevitabilmente devo guardare fuori». Anche per questo Jodice – altra accusa – è sempre stato considerato un corpo estraneo, rispetto al sistema italiano: «Ma poi qual è il sistema italiano? Son due salotti, uno a Roma e uno, forse, a Milano».
Ci mettiamo a parlare di altre cose, delle serie e degli ultimi film visti, e il modo in cui lui parla, per dire, della collaborazione tra Alfonso Cuarón ed Emmanuel Lubezki mi conferma che la cinefilia è un tratto determinante del suo “fare cinema”. Lo si vede anche in quest’ultimo film. «Il primo scarto in questo film era il luogo. Avevo in mente un grande palazzo, perché non volevo fare un film in una prigione fin dall’inizio. Il primo atto doveva richiamare i fasti dell’immaginario del ’700, anche quello strettamente kubrickiano, quindi le carrellate, le simmetrie, tutta quella roba lì. Il secondo atto, ti dicevo, è tutto grandangoli spinti, macchina a mano, movimenti frenetici quasi in stile Dogma, con l’immagine sporca, granulosa. La terza parte è ambientata nello stesso luogo, cioè la prigione, ma con la macchina fissa, come se fosse quasi un requiem, una preghiera, perché ci doveva essere una vicinanza anche emotiva tra i carcerieri e i reali, un senso di pietà che è riportato anche nei quaderni di Cléry: emessa la sentenza, ci fu negli ultimi giorni un clima molto rispettoso, molto cristiano. Quindi Le déluge è come se non fosse un unico film, ma tre mini film».
E poi i costumi, le musiche… «Massimo [Cantini Parrini, il costumista] come molti geni è anche molto pigro, perciò quando gli ho fatto leggere la sceneggiatura mi ha detto: “Che bello: stanno in carcere quindi devono avere un vestito solo!” (ride). Che però è stata anche una grande intuizione narrativa: Massimo è una testa pensante, e ha avuto l’idea di lavorare sugli abiti dei reali, che avevano sempre cinque o sei strati, e spogliarli a poco a poco, che è esattamente il senso del film. Io faccio leggere i miei copioni a tutti i reparti tecnici fin dai soggetti, li mando al musicista, al montatore, tutto deve essere concepito prima delle riprese. Non esiste, per dire, che metto la musica a film finito. Qui con Fabio [Massimo Capogrosso] abbiamo iniziato a ragionare sulle musiche un anno prima».
E poi la cinefilia, ancora. «La gente vede Le déluge e mi chiede: “Hai visto Barry Lyndon?”. Ma grazie al cazzo! Lo rivedo ogni sei mesi, ma il mio unico comandamento era non rivederlo prima di girare questo film». Jodice si definisce «un cinefilo totale, come ce ne sono pochi. Ne riconosco quattro o cinque in giro, anche se magari non li conosco personalmente. Guadagnino, per dire, non è un amico, ma so che è un grandissimo conoscitore di cinema, e come lui il suo montatore Walter Fasano. Non sono molti fra i registi, e non parlo di cinefilia come erudizione, ma come disciplina viva, che sui film ti fa interrogare, e li rivedi, e li copi anche, restituendoli secondo il tuo sguardo. Che non significa un’automatica garanzia di bravura e di risultato, sia ben chiaro. Ora che sto scrivendo vedo anche dodici film a settimana, quest’estate ho battuto il mio record con i film giapponesi degli anni ’70. Davanti ad alcuni in particolare mi chiedevo: “Ma possibile che Kubrick non l’abbia mai visto?”, e invece poi mi documentavo meglio e scoprivo che l’aveva fatto. Tutto torna».
Anche il dibattito fra cinefili e intellettuali, registi, artisti, è scomparso, «e con Paolo anche di questo parliamo spesso: non c’è più la discussione, la voglia di confrontarsi. E anche qui non lo dico per nostalgia, ma a volte vorrei che succedesse come una volta, quando i colleghi di Godard gli dicevano pubblicamente che aveva fatto un film di merda. Oggi c’è molta più solitudine, solipsismo, è un’epoca senza maestri. Il dibattito pubblico è ovattato, cristallizzato, e io ne soffro perché nessuno dice mai niente su nessuna cosa, c’è un conformismo totale e ormai automatico, stiamo soffocando. Anche il cinema d’autore tende alla comfort zone, al politically correct, anche se questa è un’espressione che non mi piace, perché dice tutto e niente. Hanno tutti l’ansia di passare per anime belle, e trovo che questa sia la tendenza davvero reazionaria. Il cinema non vuole più affrontare la complessità del reale, e invece bisognerebbe provarci».