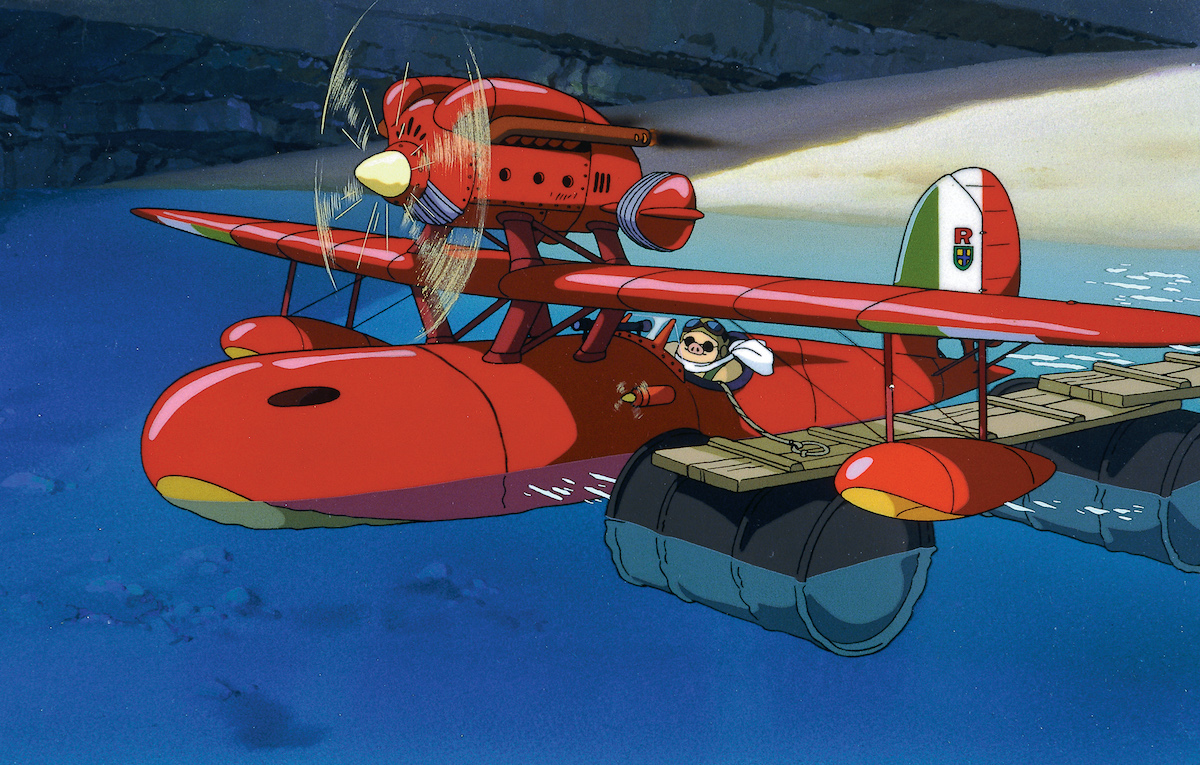Il carcere di Bollate è sulla Guida Michelin, ma tranquilli, non è il metaverso, né il pessimo scherzo di qualche Intelligenza Artificiale scatenata. La motivazione è, coerentemente, molto più semplice: all’interno dell’istituto di pena limitrofo a Milano ha aperto, nel 2015, il primo ristorante italiano situato dentro le mura di un carcere. È interamente gestito da un gruppo di detenuti e ha una madre-madrina d’eccellenza, Silvia Polleri, già attiva nella ristorazione insieme alla Cooperativa Sociale ABC La Sapienza in Tavola, servizio di catering professionale che, dal 2012, promuove il reinserimento dei detenuti di Bollate offrendo loro una formazione alberghiera su cinque anni in collaborazione con l’Istituto Paolo Frisi. Oggi quell’esperienza è mutata in InGalera, e Polleri guida un progetto che ha ricevuto il plauso della critica tanto italiana quanto straniera (abbiamo detto New York Times? Sì) e che si pone l’obiettivo di facilitare il reinserimento sociale degli ex detenuti una volta scontata la pena.
Un esempio unico in Italia, dietro il quale, però, c’è più di uno zampino: il secondo è quello del capo brigata, Davide (il cognome non è indicato), che, prima della condanna, si è formato da chef presso la scuola di Gualtiero Marchesi. Lui – e la sua interazione improbabile e divertente – con Polleri costituiscono il centro di gravità di Benvenuti in galera, documentario di Michele Rho (regista, sceneggiatore e, ma solo incidentalmente, figlio di Polleri) che racconta la quotidianità del lavoro in una brigata del tutto particolare. E che vuole incoraggiare il dialogo legato alla detenzione carceraria: la dignità.
Di questo, e altro, abbiamo parlato con il regista (che ha all’attivo, oltre a Benvenuti in galera, il lungometraggio Cavalli e il documentario Mexico! Un cinema alla riscossa), tra narrazioni di cui prendere il controllo e, soprattutto, tanta fiducia da costruire. Intanto, Benvenuti in galera, grazie all’ottimo riscontro di pubblico, rimarrà in programmazione alla Cineteca Arlecchino di Milano fino al prossimo 30 gennaio.

Courtesy of Michele Rho
La risonanza che sta avendo Benvenuti in galera sta creando un piccolo caso distributivo, di quelli virtuosi beninteso.
È stato davvero inaspettato. Parliamo di, faccio un esempio, 160 persone a proiezione, 80 la mattina durante un weekend, e per un film come Benvenuti in galera sono numeri interessanti, per non dire miracolosi. Considerando che lo stanno programmando al momento solo nella sala della Cineteca Arlecchino a Milano, si dev’essere innescato il passaparola giusto. Inoltre, si tratta di una distribuzione indipendente, che ho deciso di portare avanti da solo facendomi forza dei buoni rapporti costruiti nel tempo con vari attori del settore. Voglio che finisca nelle sale giuste, anche in virtù del fatto che, terminato il passaggio al cinema, l’obiettivo sarebbe proiettarlo nelle scuole e nelle carceri. Al momento sto parlando con diverse sale in Italia, grazie ad alcuni miei lavori passati non si tratta di un territorio da battere da zero. E poi, certamente, qualche sala sta anche cominciando a chiedermelo grazie al buon riscontro della critica.
Un lavoro a tempo pieno, insomma.
Sì, uno che però credo dia valore, e senso, a tutto quello che è stato fatto prima, durante la produzione. È la chiusura di un cerchio, del fare le cose come le si vuole. Per fortuna il tempo rimane, io lo sto usando per lavorare già a nuove idee, scrivere già i prossimi progetti. Te lo anticipo: non ne posso parlare adesso. Dico solo che sarà un riavvicinarmi alla mia casa-madre, il cinema di finzione, dopo aver dedicato tanto tempo alle vite di questi ragazzi.

Courtesy of Michele Rho
Quanto tempo sei dovuto stare “in galera”?
Per completare le riprese ci abbiamo messo tre anni, complice anche la pandemia. Forse è tanto, ma anche ciò che mi ha permesso di conoscere i ragazzi da vicino, di osservarne l’evoluzione, sia in termini personali che sul piano del loro percorso all’interno del carcere e del ristorante. Si è trattato di un progetto quasi di ricerca, e qui torna in gioco il valore del gestire il tutto in prima persona, perché non è scontato trovare un produzione disposta ad affiancare un progetto così per una tale durata di tempo. Forse è una mia cifra quando si tratta di documentario. Con i film di finzione non è andata così, erano entrate in gioco Rai e Lucky Red.

Courtesy of Michele Rho
C’è un’altra difficoltà nel tuo progetto, o una peculiarità, se vogliamo chiamarla così. Ovvero, hai lavorato a strettissimo contatto con tua madre, Silvia Polleri, ideatrice e coordinatrice di InGalera.
Esatto. Sono il primo a scherzare su questo legame, più freudiano di questo non si trova, ed è una parte fondamentale della storia, soprattutto perché io e mia madre siamo persone molto diverse. Lei è esplosiva, naturalmente, altrimenti non farebbe quello che fa, e, come in tutte le unioni lavorative, bisogna saper bilanciare le componenti umane di ambo le parti. Oltre a questo, e oltre alle battute, provavo un senso di responsabilità enorme nei confronti di questo progetto, e intendo tanto il documentario che il ristorante. Perché è la creatura di mia madre in quanto professionista e persona, lei ha dedicato una parte enorme della sua vita a questo progetto; questo da un lato. Dall’altro, perché sentivo di dover rendere giustizia ai ragazzi che ci lavorano, alle loro storie, al senso profondo del loro essere lì e continuare a mettersi in gioco. Avevo bisogno del giusto tono, della giusta delicatezza, per non tradire la loro fiducia. E il rapporto che si è creato è stato stupendo.

Courtesy of Michele Rho
Parliamo meglio di questa fiducia.
Subito ho iniziato a osservare. Andavo sul posto, stavo con loro, volevo capire il loro lavoro perché questo volevo raccontare, il loro presente già proiettato verso il futuro. Quindi registravo in silenzio, penso sia anche servito a farli abituare alla mia presenza. Volevo capire quali dinamiche, quali spunti sarebbero venuti fuori spontaneamente. Poi ho assistito ad alcuni dei colloqui di mia madre con i carcerati che lavoravano o avrebbero voluto lavorare nel ristorante. Avevo davanti a me la sfera di una dimensione sconosciuta, e un colpetto alla volta ho provato a creare un buco per osservare e comprendere, in silenzio, senza giudizio. Da lì ho dovuto selezionare, scegliere quali ragazzi seguire. È avvenuto con grande naturalezza, senza annunci in pompa magna, sempre per stare nel recinto di questa fiducia di cui parlavamo. La cosa fondamentale è una: si tratta di persone fragili, che stanno rimettendo insieme una vita fatta di cocci. Con questa preparazione, e tenendo a mente questo fatto, quando si è iniziato a parlare insieme è avvenuto con spontaneità.
Quando si parla di carcere e detenuti, arriva subito l’elefante nella stanza: la colpa che chi è costretto a risiedervi porta con sé, il fatto che diventi parte integrante della narrazione della persona.
Ed era proprio l’aspetto che non mi interessava, che volevo lasciare da parte. Parliamoci chiaro: questi ragazzi sono qui per un motivo, certo, ma è l’umanità a interessarmi, la qualità dell’essere umani, non ciò di cui la carichiamo. Quindi ho cercato di ribaltare la prospettiva, guardandoli con i loro stessi occhi, non come se fossero in un vuoto, ma usando quello che un antropologo chiamerebbe un punto di vista esterno, ma partecipante. Assolverli non era nei miei interessi, né lo era provocare il solito grido “poverini”. I ragazzi che ho incontrato non sono né diavoli, né vittime. E in tre anni, nonostante le mura a dividerci, abbiamo creato delle relazioni vere, e profonde. E qui torniamo alla fiducia, che è istintiva, la puoi costruire ma poi la senti, e basta. Lo sai. E lo sa il cinema documentario, che di fatto è una narrazione di relazioni, ed è reso possibile solo da uno sguardo basato sulla fiducia tra osservato e osservante. Nel nostro caso, poi, la sceneggiatura è stata proprio ridotta all’osso, non c’era nulla di scritto, e per costruire la storia siamo partiti dalle dinamiche che avevamo registrato. In particolare mi hanno sorpreso quelle tra mia mamma e Davide, il capo brigata. Una sintonia incredibile, a tratti proprio divertente. Così ci si stacca dalla narrazione pietista del carcere e si crea qualcosa che riesce a dire di più. O almeno, lo spero.

Courtesy of Michele Rho
Tutti sullo stesso piano, democrazia. Che è poi l’effetto livellante della cucina: o sei bravo o non lo sei, e chiunque, esercitandosi, può diventare bravo.
Del cibo trovo molto bella la metafora legata al caso specifico dei ragazzi: quando si prepara da mangiare per qualcun altro, al di là della transazione commerciale, si tratta di un ristorante, si parla comunque di un’offerta. Da InGalera, i detenuti offrono qualcosa ai commensali “liberi”, qualcosa che li può nutrire, che li può far andare a casa con il sorriso. Ed è apertura, è un essere ricompresi nell’alveo della società.
Anche le storie sono un po’ così. Si offrono come ponte di comunicazione, aprono una dimensione ulteriore nel rapporto.
Assolutamente sì. Questo lo dimostra mia madre: mi spiace tirarla sempre in mezzo, però è proprio così. Lei l’ha intuito fin dal primo minuto che c’era una storia, qualcosa da far passare all’esterno. Non per nulla sta spesso in carcere, anche a contatto con il cliente, per presentare il progetto. È una componente, quella del racconto, che aiuta a livellare la curiosità morbosa di alcuni clienti che, purtroppo ci è capitato, a volte si mostrano più interessati alle condanne e ai capi d’accusa dei ragazzi che non al cibo che hanno posato davanti a loro.

Courtesy of Michele Rho
Uno sceneggiatore (quale tu sei) lo chiamerebbe “prendere il controllo della narrazione”.
E della relazione, soprattutto, nel senso di metterla prima, davanti a tutto. Ci fa molto piacere, per esempio, vedere che i clienti non solo ritornano, ma che instaurano un legame con questo o quel ragazzo, e allora certo, magari si può anche finire a parlare di passato e di ricordi scomodi, ma lì si è creata l’intimità – e la volontà – da entrambe le parti. Sempre, vedi, torna la fiducia, l’affidarsi.
Adesso torniamo all’inizio. Che cos’è che Benvenuti in galera sta smuovendo nel pubblico, secondo te?
Mai facile da dire, in realtà vorrei saperlo. Quello che dice il mio polso è che è, alla fine, una storia universale, con appigli per tutti. Lo dico anche perché nel pubblico ci sono tanti ragazzi, ed evidentemente si sentono toccati dai temi che abbiamo messo in campo. Credo che sia merito anche del genere del film, il documentario sa toccare nel profondo, ti fa scoprire un lato nuovo del mondo e allora, ecco, scatta il passaparola. Che è importantissimo, soprattutto in un periodo in cui esce davvero tanto, tanto in sala.

Courtesy of Michele Rho
Soprattutto se pensiamo che si tratta di un documentario girato in bianco e nero.
Volevo che l’immagine fosse molto curata. La storia che racconto è di dignità, la dignità della vita, ed è un concetto che passa anche dall’immagine, che dev’essere bella per restituire quello stesso valore. Allo stesso tempo, però, volevo assolutamente evitare l’estetizzazione di quello che mostravo. Anche per questo, se ci fai caso, il cibo in realtà è solo un mezzo, un pretesto “strano ma vero”, perché per il resto lo inquadriamo pochissimo e sempre rifuggendo le logiche del food porn. Insieme a questo, c’era la volontà di evitare l’immaginario di un carcere squallido, decadente, brutale. È un lato dell’esperienza che purtroppo esiste, ma non era il verso narrativo su cui questo prodotto voleva concentrarsi. Perciò bianco e nero, dignità ed eleganza. Solo gli ingredienti fondamentali.