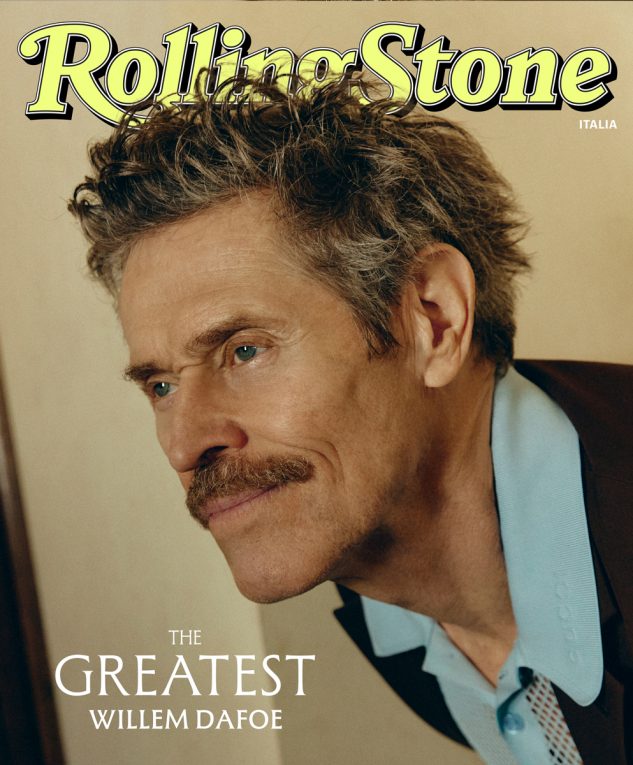Elio Germano:
Il fascino discreto di Berlinguer
Arriva ‘Berlinguer – La grande ambizione’ di Andrea Segre, e l’attore, neo-vincitore del Premio Vittorio Gassman alla Festa di Roma, fa del segretario del Partito Comunista Italiano un’interpretazione «mai esasperata, né mai completamente mimetica», che vuole invece restituire «la poesia, l’emotività di quel mondo» e di quel modo di fare politica. Cosa insegna il più grande leader della sinistra italiana oggi? Lo abbiamo chiesto al protagonista del film, tra Storia d’Italia, ideali ascetici e impossibili e una lezione che risuona: «La felicità è far star bene qualcuno»
Foto: Massimo Calabria/Vivo film
Enrico Berlinguer. Raccontato nei soli cinque anni che segnano davvero la sua parabola, tra l’annuncio del compromesso storico (1973) e il rapimento Moro (1978). Quasi un vezzo da storytelling ma continuamente sorvegliato dallo sguardo storico del regista Andrea Segre, documentarista di formazione, e del suo sceneggiatore Marco Pettenello. Il repertorio mischiato alle ricostruzioni, le automobili d’epoca, il décor e i vestiti, la color correction, gli stessi marron e verdini di un mondo doppiamente scomparso nel tempo, condannato all’oblio dopo aver vissuto la sconfitta. Al centro, il corpo di Elio Germano evoca tutto il cinema possibile, e continuamente se ne sottrae. Non il Moro di Petri, neppure i mascheroni di Sorrentino, né gli specchi deformati di Bellocchio. Elio è Berlinguer nella sua goffa tenerezza: la ginnastica in casa appoggiato alla scrivania, i mille bicchieri di latte: giullare di Dio come il Francesco di Rossellini, circondato dai suoi confratelli e familiari (nel cast ci sono anche Elena Radonicich, Paolo Pierobon, Roberto Citran, Andrea Pennacchi, Giorgio Tirabassi, Paolo Calabresi, Francesco Acquaroli, Fabrizia Sacchi).
Berlinguer – La grande ambizione – una produzione Vivo film e Jolefilm con Rai Cinema, in coproduzione con Tarantula (Belgio) e Agitprop (Bulgaria) – esce in sala il 31 ottobre distribuito da Lucky Red. Ce lo siamo fatti raccontare da Elio Germano qualche giorno prima che vincesse il premio “Vittorio Gassman” per il migliore attore alla Festa del Cinema di Roma, dove ha citato Berlinguer al circolo del Quadraro: «Se i giovani si impadroniscono di ogni ramo del sapere e si organizzano e lottano al fianco dei lavoratori, degli sfruttati, degli oppressi, non c’è scampo per un vecchio ordine fondato sui privilegi e le ingiustizie».

Foto: Massimo Calabria/Vivo film
Quando è morto Berlinguer avevi soltanto 4 anni. Sei riuscito a tirar fuori qualche ricordo personale nella tua interpretazione?
In realtà studiare tanto qualcosa frantuma tutti i ricordi che uno potrebbe avere. Forse il primo ricordo che ho è una caricatura di Forattini sulle riviste che giravano in casa. Avevamo anche delle carte da gioco di Panorama, sempre coi disegni di Forattini: Craxi, Andreotti, Berlinguer. Io mi chiedevo chi fossero. E forse c’era ancora il ricordo della sua imitazione, quando ero piccolo.
In sardo maccheronico, raddoppiando le consonanti. E per la tua famiglia? Berlinguer contava qualcosa?
Ti chiedo scusa, ma dalle interviste tendo sempre a lasciar fuori la mia famiglia, che non fa un lavoro pubblico. Parlo di me. Io verrei non proprio dalla parte di Berlinguer, sono un figlio del movimento del ’77 verso il quale il PCI non fu tenero. Per questo, ancora più che Berlinguer avevo voglia di scoprire il funzionamento del partito, sempre molto contestato per la sua forma rigida, il suo ascetismo…

Elio Germano è Enrico Berlinguer. Foto: Vivo film/Jolefilm/Tarantula/Agitprop/Lucky Red
Nelle scene del comitato centrale, in effetti, dove incontriamo nomi un tempo familiari come Ingrao (interpretato da Francesco Acquaroli) e Natta (Luca Lazzareschi), sembrano quasi dei monaci.
Questa forma di ascesi nascondeva la fatica della ricerca di un percorso comune: l’unità che, al di là del titolo del giornale e del nome delle feste, ho capito ora cosa volesse dire. Funzionava così: chi presentava le mozioni contrarie, sconfitte nelle assemblee, poi doveva occuparsi di redigere il verbale finale. Oggi questa fatica si incontra ancora in movimenti come quello per il Chapas o per il Rojava, fatti da persone che si auto-organizzano con una forma di ascesi anche molto maggiore.
Nella tua performance c’è anche una componente di inadeguatezza, quasi di tenerezza, che colpisce. Il tuo Berlinguer sembra più vicino al Francesco, giullare di Dio di Rossellini, che a un uomo di potere.
Il film si sarebbe potuto fare con gente seriosissima che si diceva delle cose, ma non sarebbe stato vero. Loro erano anche molto leggeri, anche alle volte molto cazzoni, diciamo così, questo ce l’hanno raccontato in tanti. Abbiamo cercato di restituire la poesia, l’emotività di quel mondo. Anche la stranezza, il buffo, senza aggiungere altro. Per questo la mia interpretazione non è mai esasperata, né mai completamente mimetica.

La famiglia Berlinguer in una scena del film: la moglie Letizia è interpretata da Elena Radonicich. Foto: Vivo film/Jolefilm/Tarantula/Agitprop/Lucky Red
Però la ginnastica a casa, i palleggi col pallone, i bicchieri di latte. Immagino fosse tutto vero.
Verissimo! Berlinguer faceva anche cose che a metterle in scena sarebbero sembrate esagerate, ce le hanno raccontate le figlie. Il vezzo di bere il latte in continuazione, il dubbio e la fatica di quel che faceva, il senso di responsabilità: è una persona che sembra sempre inadeguata. Niente a che vedere rispetto al Potere come oggi ci è raccontato, la possibilità di fare il comodo proprio.
Mai provato neanche un po’ di fascino per quel mondo?
Semmai oggi ci fa sorridere, però racconta una dedizione. Prendevano tutti lo stesso stipendio, metà lo rigiravano al partito. Se ti si rompeva la caldaia dentro casa, arrivava uno del partito. Il falegname, il meccanico, il dottore erano del partito, una specie di Stato nello Stato. Cosa che la moglie di Berlinguer soffriva un po’: “Io vorrei prendere un falegname vero”, diceva… D’altra parte, il PCI era un esercizio continuo di coinvolgimento delle persone, cercava di mettere in pratica la democrazia come dovrebbe essere. Con senso del sacrificio, che era anche una forma di gioia del vivere, uno strumento per immaginare un futuro migliore.

Una scena di ‘Berlinguer – La grande ambizione’. Foto: Vivo film/Jolefilm/Tarantula/Agitprop/Lucky Red
Quelli del ’77 trovavano discutibile proprio la questione dei sacrifici. Pensavano che quelli del PCI fossero molto grigi e basta.
Un po’ è così. Ma se parliamo di ragazzi e ragazze che partono per il Chapas, che non fumano, non bevono, si devono coprire il volto, come abnegazione è addirittura più forte di quella che criticavamo al Partito Comunista. Non faccio un paragone storico, però la cosa mi colpisce. Il Partito Comunista nell’accezione berlusconiana di aderente al mondo sovietico totalitario in realtà ha sempre insistito sulla democrazia, molto più di quanto non facesse la Democrazia Cristiana.
E questa cosa un po’ cattolica da catechismo, ti piace? Al di là di tutto, spendersi per gli altri, dimenticarsi di sé, è esattamente il contrario del mondo in cui viviamo.
“Dove andiamo a cercare il piacere?”: oggi si riduce tutto a questo. Magari lo troviamo nella condivisione, nel mettersi a disposizione degli altri, anche solo preparare la cena per qualcuno, oppure fare un regalo. La felicità in realtà è far star bene qualcuno.

Da sinistra a destra: Andrea Pennacchi (Luciano Barca), Fabrizia Sacchi (Nilde Iotti), Paolo Calabresi (Ugo Pecchioli), Elio Germano (Enrico Berlinguer), Francesco Acquaroli (Pietro Ingrao). Foto: Vivo film/Jolefilm/Tarantula/Agitprop/Lucky Red
Ecco. Siamo al comunismo buonista.
Ma bisogna liberarci un po’ di quello che ci fanno credere, e dalla realtà virtuale dei social. Se sinceramente rispondi alla domanda “Qual è l’ultima volta che sei stato bene?”, ti verrà in mente quando ti sei dimenticato di te. Lo dicono i manuali di psicologia. Ti puoi dimenticare di te stesso con le droghe, col cinema, con un viaggio, dormendo. Pare che stiamo bene quando siamo dimentichi di noi, è una forma di piacere proprio come per gli asceti veri. Oppure quando ci sentiamo utili, sennò perché stiamo al mondo non si capisce.
Il film nasce da un lungo studio di libri, carte, filmati di repertorio e dall’incontro con alcuni testimoni. Ci racconti?
Innanzitutto mi fa piacere consigliare il lavoro immenso che ha fatto Enrico Deaglio in un libro che si chiama Patria, puntualissimo nel raccontare la storia del nostro Paese. Ovviamente si sono aperti i canali dell’Istituto Gramsci, che conserva l’archivio del PCI: i verbali, i biglietti d’auguri, i fogli scritti a mano da Berlinguer stesso. E abbiamo avuto il sostegno dell’archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico (AAMOD), dove abbiamo visto miliardi di cose. E le interviste: tutta la famiglia, Gavino Angius che ci ha dato una mano in Sardegna, tutti i vecchi compagni rimasti, Veltroni e D’Alema, Luciana Castellina…

Germano/Berlinguer durante un comizio. Foto: Vivo film/Jolefilm/Tarantula/Agitprop/Lucky Red
Possiamo dire che il trucco così leggero, mai esasperato, è una conseguenza di questa mole di lavoro che hai fatto?
Noi volevamo che ci si concentrasse sui contenuti. Quindi tutto il gioco delle somiglianze tende a restituire solo cose che hanno un senso: il modo di parlare di Berlinguer è interessante perché lui è sempre un po’ sbagliato, inadeguato, non era una persona nata per parlare in pubblico e questo ce lo avvicina se pensiamo alla retorica craxiana di allora.
Sembra quasi vivere in un altro mondo che, si spera, dovrebbe essere migliore di questo, te ne porta delle notizie.
Sempre spettinato, trafelato… È interessante quanto la Storia del nostro Paese sia fatta da persone così. Mazzini era un oppiomane che aveva paura di parlare in pubblico, Cavour era un dislessico, Garibaldi veniva preso in giro per come parlava. E questi sono i padri, stanno seduti in tutti i monumenti del nostro Paese. Noi oggi siamo convinti che chi fa politica debba parlare bene, in realtà se dovessimo affidare i nostri soldi a qualcuno li daremmo più volentieri a uno che somiglia Berlinguer che a un altro col cerone, il macchinone e l’oro addosso, o no?
Si diceva una volta: Almirante parla bene. Poi Fini. Nella repubblica dei social chi parla bene vince.
Se tu passi il tempo sui libri e sugli atti, non è detto che ti sai muovere in società. E viceversa. Ci sono persone che vengono a venderti la politica, e poi c’è chi la fa davvero: le persone che non vediamo mai in tv, gli esperti che scrivono le leggi, quelli che le fanno passare.
Avete girato a Sofia per cercare di restituire un po’ di estetica filosovietica del tempo. Ascoltavi i CCCP – Fedeli alla Linea?
In realtà sì, ma se pensi alla deriva che ha preso Lindo Ferretti…
Non volevo aprire il dibattito, ti chiedevo se portavi qualche spilletta sovietica sul bavero della giacca.
No, però a me piace molto il cinema sovietico. Gli attori lavoravano per lo Stato con uno stipendio fisso, senza la competizione che oggi senti nella musica, quella forma di sottile disperazione dell’artista che cerca di convincerti, di stare aggrappato al tuo consenso sennò sparisce. È una forma di sicurezza, di serenità artistica. Paradossalmente si fanno cose migliori quando non ci sono i soldi perché così le persone stanno rilassate.
Hai potuto incrociare Jacopo Iosonouncane, che firma la colonna sonora?
No, ma lo conosco da tempo. Quando la gente esce commossa dal film, che è molto emotivo, si deve non solo alle immagini di repertorio mischiate alle altre, ma anche alla musica. Ha scritto una colonna sonora veramente bella, popolaresca e solenne insieme.