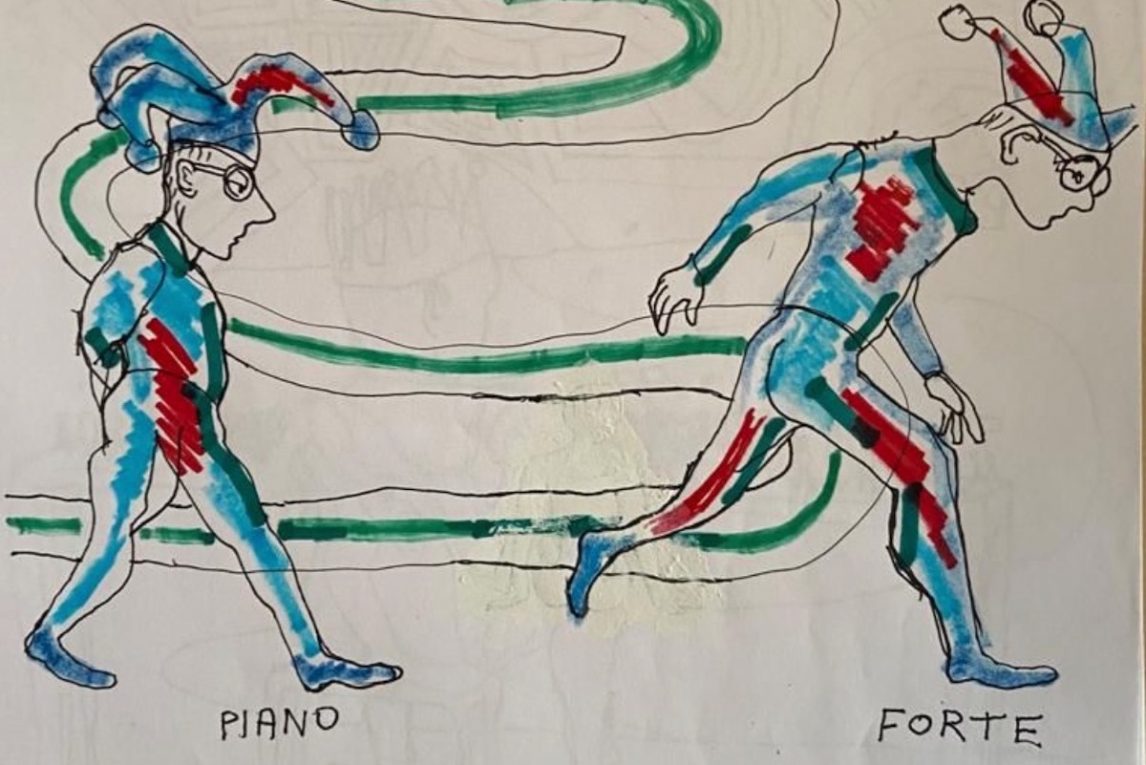Fino a qualche tempo fa, Fausto Russo Alesi era, per i più, una faccia da mettere dentro quella vecchia rubrica da giornale per cinematografari nerd: “Come hai detto che si chiama?”. Quello bravissimo, che vedevi spesso e con gioia, e di cui però non ricordavi il nome (il che forse, almeno a volte, è la scusa per restare bravissimi). Oggi Fausto Russo Alesi è, finalmente, Fausto Russo Alesi. Nome e (doppio) cognome noti a un pubblico sempre più largo. Quel pubblico che ha conosciuto il suo Giovanni Falcone del Traditore, e il Cossiga di Esterno notte (prima candidatura ai David come miglior attore non protagonista: avrebbe meritato la vittoria), e che ora sta conoscendo Momolo Mortara – padre di Edgardo, il piccolo ebreo bolognese che la Chiesa vorrebbe convertire alla religione cattolica nell’Italia del secondo ’800 – in Rapito, prima a Cannes e ora in sala. Tutti film di Marco Bellocchio, con cui Fausto Russo Alesi ha girato anche Vincere, Sangue del mio sangue e Fai bei sogni. Bellocchio è l’autore che ha stabilito la centralità dell’attore palermitano anche al cinema, centralità che ha sempre avuto a teatro e che pareva inevitabile, per talento e per destino, almeno per chi lo segue dai tempi di Ronconi (eccomi). Fausto Russo Alesi è ora in tournée, per così dire, nelle sale dei cinema di mezza Italia, «ne sto scoprendo di bellissime, con un pubblico caldissimo», e portare in giro i film senza lasciarli lì da soli, come fossero opere da subire passivamente, è per lui l’unico modo per riattivare l’interesse sul cinema stesso. Ci arriveremo alla fine di questa lunga, densa chiacchierata.
Comincio naturalmente da Rapito, e da quell’urlo del tuo personaggio che, a vederlo esplodere sullo schermo, mi è sembrato una liberazione non solo sua, ma anche per esteso di tutti i tuoi personaggi con Bellocchio. Personaggi sempre così trattenuti, ingabbiati nel loro ruolo politico e sociale, e che appunto è come se, attraverso questo grido, simbolicamente “saltassero” di colpo.
C’è dentro tantissimo, in quel momento. Momolo Mortara è un personaggio che tiene, tiene, tiene e poi, quando tutto quello su cui ha riposto fiducia crolla, crolla anche lui. Ma più che liberatorio quell’urlo è necessario. C’è qualcosa di organico rispetto al percorso che deve affrontare, insieme alla famiglia, quel padre vittima di una tragedia così grande. È descritto come un uomo mite, le armi che mette in campo sono la pazienza, il dialogo, la fiducia, un profondo senso della giustizia, qualcosa di religioso quasi. Ci siamo chiesti a cosa ci si aggrappa, di fronte a un abuso di potere come quello. Abbiamo cercato, indagando tutto lo spettro dei sentimenti umani, di trovare la strada, la soluzione. Momolo è un personaggio che non si rassegna mai, ma lo fa dentro la complessità della sceneggiatura di Bellocchio, nel confronto continuo con tante tematiche politiche e religiose. Fin dall’inizio, l’indicazione di Marco era di raccontare una vicenda soprattutto umana, la sofferenza di due genitori. E allora Momolo diventa un uomo disposto a mettere da parte qualsiasi principio a favore di ciò che è più essenziale, e cioè suo figlio, ad accantonare qualunque ortodossia, persino il proprio credo. In questo senso, non è per nulla ideologico.

Fausto Russo Alesi è Momolo Mortara in ‘Rapito’ di Marco Bellocchio. Foto: 01 Distribution
Come non lo è il cinema di Marco Bellocchio. Conosciamo ovviamente la sua posizione rispetto alla religione e alla Chiesa, ma il suo sguardo sul caso Mortara resta aperto, dialogante, indagatore appunto. E insieme, come dici tu, c’è questa impudicizia verso i sentimenti, le urla, le emozioni che sembrano prese – lo ha detto lo stesso Bellocchio – dal libro Cuore.
Mi ha emozionato molto questo modo di affrontare la vicenda. L’urlo è il simbolo, il momento di rottura di un uomo che si trova schiacciato da forze più grandi di lui. Dentro c’è l’incomprensibile. E però sì, accanto a questo dato così umano ci sono i temi di un conflitto senza tempo, una costante ricerca di confronto, di dialogo, di tolleranza. Lo trovo un approccio estremamente contemporaneo.
Come racconteresti la tua storia con Bellocchio? Dall’inizio con Vincere ai ruoli di adesso, Falcone, Cossiga, Mortara. Ruoli che hanno preso sempre più corpo e spazio, fino a farti diventare uno dei volti ricorrenti del cinema di Bellocchio.
Lo dico in maniera molto semplice: per me poter essere dentro le sue opere è ogni volta un grande regalo, uno stupore, una fortuna. La conoscenza che negli anni si è sviluppata è nata da una grandissima curiosità, una curiosità da parte sua, intendo, perché io figurati se non l’avevo… (ride) Marco è un artista estremamente curioso, che vuole approfondire sempre, e pensa, come lo penso io, che nella durata si possano realizzare cose migliori. La fortuna è avere, oggi, un rapporto di fiducia estrema, sapere che un regista ti conosce e vuole avvicinarti sempre di più a te, o allontanarti da te, quando ti affida un ruolo. Quando Marco dà un ruolo a un attore è perché dentro c’è sempre qualcosa di molto preciso di quell’attore, da lì nasce quel processo che va sempre in profondità, che fa lavorare la tua parte migliore. Marco è sempre insieme all’attore, ne ha un rispetto enorme, lo segue ovunque: se sa che sei a teatro, viene a vedere i tuoi spettacoli, è curioso, si nutre di letteratura, teatro, di tutto quello che è presente. E quando si lavora viaggia insieme a te, vicino a te, te lo può confermare qualsiasi attore che ha lavorato con lui. Ti viene vicino, ti sussurra le cose, perché sa che quel luogo che stai abitando è un luogo speciale, un luogo dove devi stare con tutte le parti di te stesso. Marco sta lì con te a seguirti, a suggerirti anche solo una piccola parola per spostare leggermente la direzione e portarti dove serve. C’è qualcosa di inaspettato in questo percorso, e mi auguro che possa continuare. Ma non do nulla per scontato, ogni volta è una possibilità.

Fausto Russo Alesi con Marco Bellocchio sul set di ‘Rapito’. Foto press
Non so se esiste un “metodo Russo Alesi”, ma da spettatore, se penso ai tuoi ruoli recenti ma anche a quelli passati ispirati a figure realmente esistite – ricordo, tanti anni fa, Reichlin a teatro, nel Silenzio dei comunisti di Ronconi – ci trovo sempre un distanziamento, da parte tua, per poi rientrarci dentro, in quella determinata vita che non è mai imitazione ma resta fedelissima, aderente a quella reale di chi vuoi raccontare.
Quando si raccontano personaggi reali, soprattutto se sono profondamente radicati nel nostro immaginario, bisogna certamente conoscerli nelle loro biografie. Però poi quello che interessa, a me e anche a Marco, è farli vibrare e vivere nel presente. Gli esseri umani nelle loro differenze si somigliano molto, ed è dentro quelle differenze che mi piace scavare, nelle ombre e nelle crepe che, nonostante le apparenze, appartengono a tutti. E credo che in quelle crepe lo spettatore – e anch’io che mi trovo davanti al copione – possa specchiarsi, riconoscersi, capire qualcosa di sé. A me questo interessa, quando sono dentro una storia: che mi faccia emozionare, e allora sento il bisogno che quell’emozione venga condivisa, ma non un’emozione fine a sé stessa, un’emozione che può farci andare avanti nella nostra conoscenza di noi stessi. Perciò a quello che già sappiamo di un personaggio – e che va restituito, se no quel personaggio non lo riconosceresti – aggiungo l’andare dietro le quinte, il cercare di raccontare qualcosa che potresti trovare nella casa di ciascuno di noi.
Interviene anche la paura, quando devi maneggiare una materia così delicata?
Certo, perciò servono rispetto e distanza, come dicevi tu: la distanza è fondamentale. Ma anche in questo, con Marco siamo perfettamente complici: l’idea è sempre fare un’interpretazione del personaggio. E questo te lo insegna anche il teatro: ogni volta che prendi in mano Amleto, o Il mercante di Venezia, o Eduardo, o Čechov, c’è una nuova persona che con occhi nuovi cerca di far risuonare quello che di universale c’è lì dentro. E così può avvenire anche con le storie del cinema, soprattutto quando raccontano personaggi ed eventi del nostro passato verso cui bisogna per forza avere occhi nuovi, una nuova possibilità di interpretazione, o semplicemente la restituzione di una piccola parte di quella persona che ti sembra necessario o ti emoziona restituire. Forse ci riconosciamo più facilmente in una piccola parte. In fondo, ogni attore racconta una grande storia mettendo solo un pezzo del puzzle.
Il Cossiga “psicotico” di Esterno notte è davvero una parte per il tutto, vale a dire la psicosi di un intero Paese.
Il cinema di Marco, come tutto il grande cinema, e i grandi testi teatrali, e la grande letteratura, ci racconta una storia sempre come metafora di qualcos’altro. Quando le sceneggiature sono scritte così bene (nel caso di Esterno notte, dal regista con Stefano Bises, Ludovica Rampoldi e Davide Serino, nda), la metafora sta anche dentro i singoli personaggi. E farla emergere da un personaggio crea un dialogo con i temi ancora più ricco, perché la metafora sta anche nei non detti, nelle parti più oscure, più misteriose.

Fausto Russo Alesi alias Francesco Cossiga in ‘Esterno notte’ di Marco Bellocchio. Foto: Rai/Kavac Film
Qual è il personaggio, il ruolo, in cui secondo te questo processo ha funzionato di più, in cui le varie parti hanno combaciato meglio?
Ovviamente i ruoli con Marco Bellocchio, proprio per la potenza che c’è nella scrittura dei personaggi. Si sente che c’è sempre un grande coinvolgimento da parte di Marco nel mettere in scena quei personaggi, non c’è mai nulla di superfluo, di gratuito, è tutto voluto, agganciato. È vero che non esistono piccole parti, che anche un piccolo ruolo può regalare molto, e tu come attore devi cercare di lasciare qualcosa di te. Ma quando hai la possibilità di interpretare personaggi che hanno molto spazio, e dunque di raccontarli in maniera più ampia, puoi mettere in campo molti più elementi. Gli ultimi due ruoli soprattutto, Cossiga e Momolo Mortara, sono stati due grandissimi viaggi, molto densi nella preparazione e anche sul set. Mi hanno fatto scoprire qualcosa in più anche di me stesso.
Confermiamo o sfatiamo un mito: che l’attore che nasce a teatro poi lavora meglio anche al cinema.
Secondo me non ci dovrebbe essere nessuna differenza, poi sono le cose che incontri ad aiutarti ad andare verso il tuo obiettivo. La recitazione, al suo cuore, segue lo stesso principio, ma in due mezzi diversi che vanno tecnicamente conosciuti e praticati, perché hanno caratteristiche appunto diverse. Quanto al mettersi dentro le cose, al dare spazio alla libertà, all’immaginazione, è totalmente uguale. Però ogni cosa deve essere fatta con perizia, non si può delegare tutto solo all’improvvisazione o a un ipotetico talento. Bisogna riuscire a comunicare attraverso quel dato mezzo in maniera sempre più… e qui ci vuole la parola giusta, perché mi verrebbe da dire sempre più precisa, ma non è l’aggettivo corretto. Bisogna cercare di raggiungere quella zona dove la tua grande preparazione, il tuo metterti a disposizione, il mettere in campo la tua arte, la tua immaginazione, alla fine coincide con una strana sensazione di sospensione, un vuoto in cui tutto può accadere.

Fausto Russo Alesi/Giovanni Falcone con Pierfrancesco Favino/Tommaso Buscetta in ‘Il traditore’ di Marco Bellocchio. Foto: 01 Distribution
Quali sono stati i tuoi maestri? Qualcuno posso immaginarlo, ma intendo anche, che so, una zia, un attore che hai visto quand’eri ragazzo, Shakespeare…
Il primo colpo di fulmine è stato a Siracusa, alle tragedie: ero molto piccolo e quell’esperienza teatrale da spettatore vissuta tra le pietre del teatro greco mi colpì profondamente. In realtà però da piccolo sono stato affascinato dal cinema ancora prima che dal teatro, vedere i grandi attori e le grandi attrici sullo schermo mi ha fatto sognare di fare questo lavoro. Sordi, Tognazzi, Manfredi, e Volonté, e ovviamente Mastroianni. Poi, crescendo, ciò che incontri è ciò che ti guida. Io a teatro ho avuto la fortuna di incontrare grandissimi maestri, e parlo come sai di Ronconi, ma anche di Nekrosius, Stein; e però anche di mantenere parallelamente un percorso di autonomia, di crescita insieme a colleghi come Serena Sinigaglia, con cui ho fatto tantissime cose. Amo il grande teatro e anche ciò che avviene negli spazi indipendenti, e amo tantissimo il cinema, e lì ovviamente ho avuto la fortuna di incontrare Bellocchio, a cui devo veramente tutto. E amo Shakespeare, Čechov, Eduardo, che ho incontrato professionalmente due volte e sempre con grande determinazione nel farlo, perché penso che non sia immediato, o quantomeno non lo era per me, e quindi mi sono creato delle occasioni molto volute: prima, dieci anni fa, con Natale in casa Cupiello, e adesso con L’arte della commedia, che porterò in tournée la stagione prossima. Le cose col tempo hanno finito per contaminarsi e, per quello che mi lasciano addosso, a volte mi capita misteriosamente di portare Eduardo dentro a un film, e viceversa.

Fausto Russo Alesi in scena con ‘L’arte della commedia’ di Eduardo De Filippo. Foto: Anna Camerlingo
A te che abiti, come ti piace dire, sia il teatro che il cinema e la tv, e che nell’ultima stagione di cinema hai partecipato a titoli di grande successo – Esterno notte e anche La stranezza, peraltro di matrice per così dire teatrale – voglio fare l’annosa domanda: come stanno oggi il cinema e il teatro?
Il cinema e il teatro sono fratelli, e in questo momento penso che siano più che mai vicini. Un elemento è il fatto che adesso tanti attori di teatro lavorano al cinema e in tv in maniera assolutamente organica. C’è stato il momento sconvolgente della pandemia che ci ha fermati tutti, ma poi i teatri sono ripartiti in maniera fortissima perché il pubblico ha sentito davvero il bisogno della condivisone, del percepire lo spettacolo dal vivo. Il cinema invece non si è fermato, ha offerto tanto lavoro anche durante la pandemia, è stato una grandissima risorsa. Ma dopo un periodo di crisi mi sembra che ora ci sia una ripresa della sala e non è così scontato, perché a casa possiamo usufruire di un’offerta molto ampia e perché i ragazzi guardano le serie sul cellulare. Però penso che la sala si stia riprendendo proprio perché il pubblico ha voglia di stare insieme. In questo senso, accompagnare un film, non lasciarlo al suo destino, creare occasioni di scambio, di dialogo, è una ricchezza enorme. E visto che il teatro è un luogo vivo, abitato, ecco, questa è una cosa che i due fratelli possono condividere in maniera dialettica. Porti il tuo film in una sala piena e alla fine dal pubblico arriva sempre quell’intervento che non ti aspetti e che è uno stimolo, una cosa che ti traghetta in avanti, un po’ più in là, nel tuo viaggio.