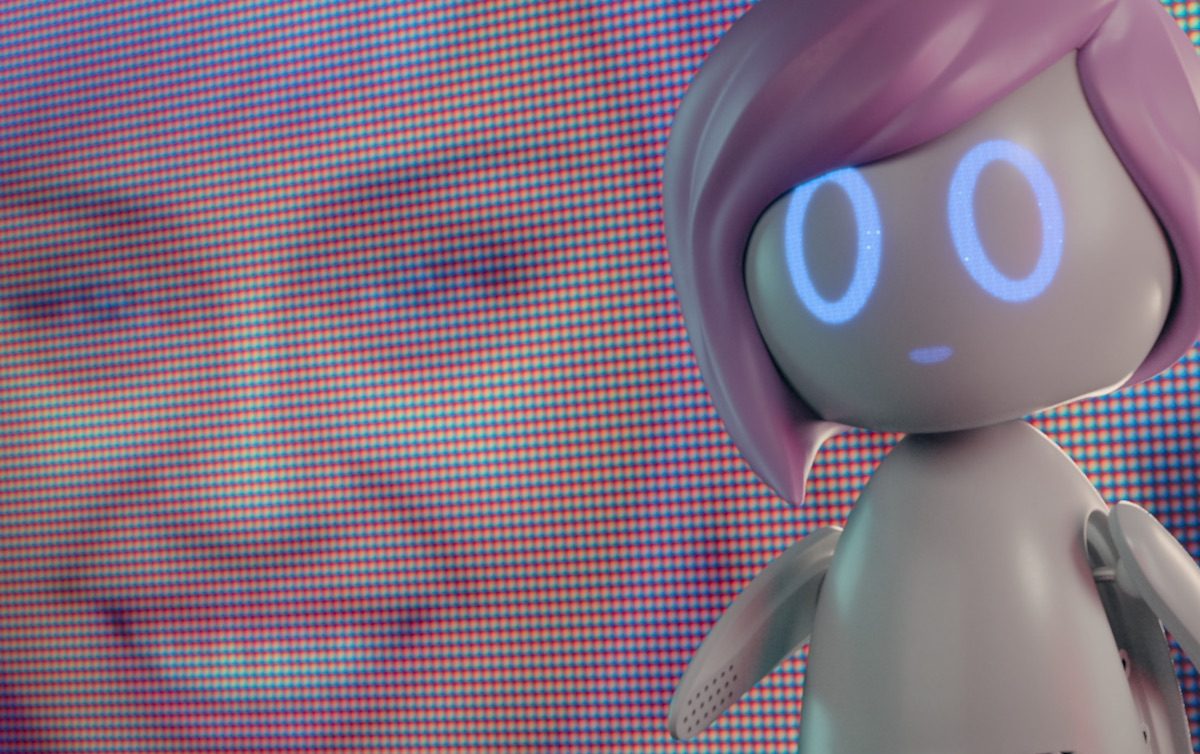ATTENZIONE: questa recensione contiene MOLTI spoiler sulla sesta stagione di Black Mirror, ora disponibile su Netflix.
Joan è terribile, il primo episodio della nuova stagione di Black Mirror, la satira antologica sci-fi by Charlie Brooker, vede Annie Murphy nei panni del personaggio del titolo, l’impiegata di una società del ramo tech che scopre che la sua vita è stata trasformata, senza il suo permesso, in una serie drammatica disponibile su una piattaforma di streaming di nome Streamberry.
Joan è terribile è un episodio degno di nota per vari motivi. Per prima cosa, è il migliore – o, almeno, il meglio costruito – fra i diversi capitoli di questa nuova stagione. Secondo, era da un po’ che un episodio di Black Mirror pensato come una comedy non funzionava davvero come una comedy, grazie sia alla sua idea di partenza – Streamberry utilizza un super computer capace di adattare all’istante gli eventi della vita di Joan in una serie tv, utilizzando deepfake di Salma Hayek e Himesh Patel – sia alle performance di Murphy e Hayek. Terzo, sembra davvero voler sputare nel piatto in cui mangia, considerato che Streamberry è evidentemente modellato – dalla font del logo al “TU-DUM” che si sente all’inizio della serie – su Netflix.
Dato forse più importante di tutti, è l’unico tra i cinque nuovi episodi a giocare con il tema portante della serie, ovvero la nostra dipendenza dalle nuove (o imminenti) tecnologie. Il secondo episodio, lo spaventoso Loch Henry, è l’unico, fra gli altri, ad essere ambientato nel presente, in una remota località della Scozia in cui si è sconnessi da tutto. Gli altri tre capitoli sono tutti ambientati nell’epoca pre-smartphone, anche se lo sfondo di Beyond the Sea è una versione alternativa del 1969 dove una coppia di colleghi astronauti interpretata da Josh Hartnett e Aaron Paul passa il tempo del lungo viaggio nello spazio uploadando le rispettive coscienze nei duplicati artificiali rimasti a casa con le famiglie.
Mazey Day, con Zazie Beetz nei panni di una paparazza che cerca di svoltare grazie alle foto scattate a una tormentata star del cinema, è ambientato nel 2006, mentre Demone 79 alla fine degli anni ’70. L’elemento tech è presente in tutti gli episodi, ma è, per cosi dire, vintage: ci sono VHS in Loch Henry, videocamere digitali in Mazey Day e set televisivi in Demone 79. E nel finale di Loch Henry, l’aspirante filmmaker Davis (Samuel Blenkin) raggiunge la fama quando la sua storia diventa una miniserie di Streamberry che ricorda uno dei tanti titoli true crime di Netflix che abbiamo guardato all’inizio della pandemia.

Zazie Beetz nell’episodio ‘Mazey Day’. Foto: Netflix
Tutti gli episodi sono interessanti per ragioni diverse, anche se Joan è terribile sembra l’unico riuscito a pieno. Ma, presi nel loro insieme, viene da pensare se Charlie Brooker non si sia ormai stancato della serie e/o della collaborazione con Netflix. Propendiamo per la seconda ipotesi: Netflix è diventata una parte così importante della nostra “vita digitale” che sarebbe parso disonesto se Brooker, a un certo punto, non avesse fatto i conti con questa realtà. E le battute direttamente rivolte a Netflix in Joan è terribile e Loch Henry – incluse quelle sui pericoli provocati dal non leggere i termini di qualsivoglia piattaforma, o su quanto siamo ormai disinteressati ai prodotti che ci vengono offerti sui servizi di streaming – possono in realtà valere per qualsiasi società tech. Ma il “trasloco” di Black Mirror nel 2016 dall’inglese Channel 4 a Netflix ha comunque provocato qualcosa. Ha dato a Brooker l’accesso a star molto più note, e a budget molto più elevati. Ma le ultime stagioni sono sembrate molto più irregolari, in parte perché non sono più le serie da tre episodi ciascuna prodotte per Channel 4.
Gli anni di Netflix sono stati anche più ripetitivi, accomunati da trame troppo simili, una su tutte: i pericoli che incontra una persona la cui coscienza viene duplicata in un device o nella realtà virtuale. Questo tema portante ci ha però regalato due dei migliori episodi dell’intera serie: San Junipero (con Gugu Mbatha-Raw e Mackenzie Davis che si innamorano in una versione digitale dell’aldilà) e USS Callister (starring Cristin Milioti intrappolata nella fantasia in stile Star Trek di un imprenditore del tech). Ma più Brooker tornava su quell’idea, meno impatto sembrava avere sugli spettatori.
Quindi, forse, quest’ultima stagione è solo il tentativo di Brooker di abbandonare quello che aveva fatto (e rifatto) in passato. Se è davvero andata così, è ammirevole che l’autore non si sia semplicemente seduto sugli allori, ma abbia invece cercato di capire cosa Black Mirror può ancora essere e rappresentare. Ma molti di questi nuovi episodi rivelano gli stessi problemi che la serie ha patito nella sua storia recente, anche quando si è focalizzata soprattutto sul ruolo dei social media nelle nostre vite.
[Seguono ulteriori spoiler. Se avete intenzione di guardare la serie e non volete sapere nulla, ripassate da qui più tardi.]
In particolare, il ritmo e la durata degli episodi restano due problemi evidenti. La maggior parte degli episodi prodotti da Channel 4 durava tra i 40 e i 50 minuti, il tempo giusto per fondare le regole di ogni singolo mondo e poi piazzare un twist su quella realtà che ormai pensavamo di conoscere. Su Netflix, la durata media è diventata di 60 minuti, spesso anche di più, tanto che trovare un episodio di appena 41 minuti come Metalhead (quello in bianco in nero con i feroci cani robot) era quasi sconvolgente. Alcuni di quegli episodi sfruttavano il vantaggio di poter sviluppare più a fondo idee e personaggi, ma molti altri sembravano ripetere o allungare troppo l’assunto di base, solo per assicurarsi che arrivasse forte e chiaro allo spettatore.

Josh Hartnett nell’episodio ‘Beyond the Sea’. Foto: Netflix
Beyond the Sea e Demone 79 durano entrambi più di un’ora. Paapa Essiedu è molto divertente nei panni del demone del titolo, e Anjana Vasan (vista nella serie inglese We Are Lady Parts) è bravissima nei panni della povera commessa che deve uccidere tre persone in tre giorni per fermare la fine del mondo. In parte riescono a farci dimenticare l’eccessiva lunghezza dell’episodio. Beyond the Sea, invece, impiega tantissimo tempo prima di avviare la trama vera e propria, ossia quando un gruppo di hippie in stile Manson Family fa strage della famiglia di Hartnett e distrugge il suo surrogato robot; e poi lavora sulle complicazioni che ne derivano, in particolare quando Aaron Paul suggerisce al Hartnett di usare il finto corpo dello stesso Paul e passare del tempo con sua moglie (interpretata da Kate Mara) come “pausa” dal dolore, dalla monotonia e dall’isolamento dello spazio. Paul, Hartnett e Mara sono tutti e tre molto bravi, ma ogni scena sembra fin troppo allungata, e alla fine è allo spettatore che sembra di essere ingabbiato dentro una lunghissima missione spaziale.
Ironicamente, l’episodio più breve della serie è quello che avrebbe bisogno di un po’ di tempo aggiuntivo. Coi suoi 40 minuti, Mazey Day racconta la natura oppressiva della cultura dei paparazzi, e il fatto che ci trasforma tutti in animali. Ma l’idea fin troppo letterale – scopriremo che Mazey (Clara Rugaard) non è in un rehab per disintossicarsi dalla droga, ma si nasconde dalla luna piena perché nel frattempo è diventata una licantropa – è talmente assurda da risultare più divertente (anche se involontariamente) di tutto quello che vediamo in Joan è terribile o Demone 79.
Joan è terribile e Loch Henry fanno l’uso più efficace del minutaggio (entrambi durano poco meno di un’ora). La scoperta di Joan che la sua vita è diventata una serie, e il successivo tentativo di cancellare tutto ciò, richiede una costruzione graduale, con nuove trovate ironiche di fronte a ogni nuova complicazione. Un esempio: Joan capisce che deve fare qualcosa di così mortificante, e allora Salma Hayek finisce per distruggere il suo charme disseminando diarrea per tutta la navata di una chiesa durante un matrimonio. Quando Joan e Salma scoprono di essere due versioni dello stesso personaggio, e che c’è un numero infinito di Joan digitali, Murphy, Hayek e, in un cameo, Michael Cera sono tutti così bravi da farci dimenticare il fatto che Brooker sta facendo il suo solito giochetto a proposito di simulazioni e realtà virtuali. E, proprio come San Junipero, è bello che questo episodio abbia un lieto fine, cosa più unica che rara nell’universo di Black Mirror.

Salma Hayek nella sesta stagione della serie di Charlie Brooker. Foto: Netflix
Il soggetto di Loch Henry è un mistero che cresce lentamente. I protagonisti sono Davis, la sua fidanzata Pia (Myha’la Herrold) e il suo vecchio amico Stuart (Daniel Portman); insieme, girano un documentario su un serial killer che aveva ucciso le sue vittime nella città di Davis e Stuart negli anni ’90. L’atmosfera è spaventosa, e la storia prepara molto bene il colpo di scena (i genitori di Davis erano complici dell’assassino). Il finale è forse un po’ affrettato, ma sembra anche più a fuoco rispetto a quello, decisamente più sciocco, di Joan è terribile.
A differenza di Joan, Brooker non si è ancora liberato dell’equivalente di Streamberry nel mondo reale. Quest’anno ha firmato per Netflix un altro titolo, cioè il divertentissimo mockumentary con protagonista la finta reporter Philomena Cunk. La domanda, se mai, è quanto vorrà andare avanti con Black Mirror, e quanto questa formula avrà ancora qualcosa da dire. Anche quando finalmente deciderà di ridurre il numero di storie con al centro gli iPhone. O almeno ce lo auguriamo.