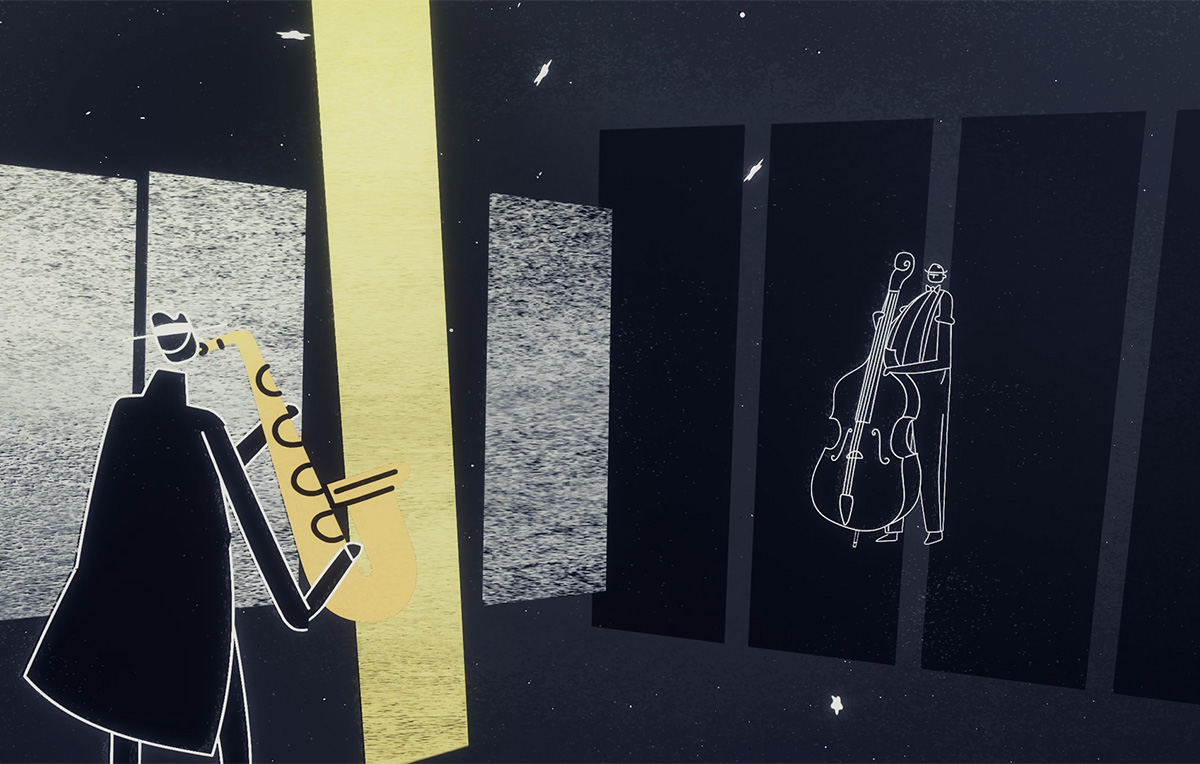Tempo fa, ci confrontammo con Daniele Giardini sul tema del sessismo nell’ambiente dello sviluppo, scontrandoci con un problema: eravamo due uomini che parlavano di un problema che non riguarda gli uomini. Su input di Daniele, ci siamo allora messi in contatto con Claudia Molinari, una delle due metà di We Are Müesli, apprezzata sviluppatrice, ma anche una figura che da anni cerca di far compiere passi avanti all’industria. Claudia è un’artista 2D, illustratrice e visual-teller con anni di esperienza nella direzione creativa di progetti di design. Insegna inoltre Game Design con un particolare focus sulla valorizzazione del patrimonio culturale e della diversità. Insieme a Matteo Pozzi, l’altra metà di We Are Müesli, realizza “visual novel strane”, come CAVE! CAVE! DEUS VIDET ispirata alle opere di Jheronimus Bosh, ma anche vere come Venti Mesi, una collezione di storie (anche autobiografiche) sulla resistenza, o bizzarre come The Great Palermo, primo gioco in Italia a meritarsi una selezione al Compasso d’Oro. Ma anche giochi non narrativi come SIHEYUAN, un titolo cooperativo ispirato ai cortili di Pechino, o non digitali come Colpo di Stato, un gioco di carte di investigazione storica su uno dei più inquietanti, eppure poco conosciuti, “misteri d’Italia”: il tentato “golpe Borghese” del 1970. Al momento è impegnata nel progetto più complesso mai realizzato dal suo studio, Wer Ist Wer, un’escape room temporanea che sarà fruibile a breve a Milano.

We Are Müesli è uno studio di sviluppo indie con una spiccata vocazione internazionale certificata dall’apprezzamento e dai premi raccolti oltreconfine.
Ciao Claudia, benvenuta, vuoi presentarti ai nostri lettori?
Ciao! Io sono Claudia Molinari e insieme a Matteo Pozzi siamo We Are Müesli, uno studio indipendente che realizza giochi a tema culturale, artistico e ultimamente anche giornalistico. Abbiamo debuttato nel 2013 con Cave! Cave! Deus Videt, visual novel pluripremiata se posso dirlo. E lo dico perché ci siamo lanciati nei videogiochi da un aereo, sperando che il paracadute si aprisse.
Voi venite da un altro ambiente, più canonico, quello della comunicazione. Come avete trovato il mondo dei videogiochi in Italia dall’interno?
Penso a me e Matteo nel 2013 come Don Chisciotte e Sancho Panza. Forse siamo stati fortunati, ma abbiamo sempre visto un lato molto bello di questo mondo, soprattutto sul versante internazionale. In Italia abbiamo vissuto momenti di aggregazione indie molto forti, ma anche situazioni migliorabili. C’è molto isolamento, ad esempio: non credo esista una vera community indie italiana.
Nemmeno online?
Sicuramente ci sono, ma qui entriamo nel campo dell’inclusività che è parecchio spigoloso in Italia. Quando si è troppo diversi, come noi con i nostri giochi strani e particolari al punto da non venire considerati giochi dal pubblico italiano, all’estero è considerata una qualità. Qui in Italia invece c’è stata un po’ di curiosità, ma anche un approccio escludente da parte di un certo pubblico: questi non sono videogiochi.

Siheyuan è un puzzle collaborativo a blocchi per 4 giocatori ispirato allo stile architettonico dei cortili cinesi.
Avete capito perché?
Il motivo è culturale. Mi duole dirlo, ma in Italia non c’è una cultura del gioco, a partire dagli stakeholder istituzionale per finire col pubblico. Il videogiocatore medio italiano è il tipico maschio, bianco eterosessuale. C’è un problema a comunicare tematiche diverse attraverso un videogioco, mentre all’estero è più naturale trovare esperienze indie autobiografiche e avere un riscontro. Poi c’è il problema culturale in senso più ampio: in Italia fatichiamo a parlare inglese. Arrivare alla GamesWeek di Milano è considerato il Santo Graal, ma ci sono tantissimi altri percorsi.
Su The Verge qualche tempo fa si parlava delle situazioni economiche (agghiaccianti) di alcuni sviluppatori indipendenti anche parecchio famosi. Non per farvi i conti in tasca, ma voi credete che fare videogiochi sia un modello economico sostenibile?
Noi facciamo giochi a km zero. Il concetto che dobbiamo sempre tenere a cuore è la sostenibilità del progetto: economica, ma soprattutto mentale e fisica. Ho tanti sogni nel cassetto, ma conosco le nostre possibilità. Produrre giochi, paradossalmente, non è un gioco.
E qua finiamo a parlare del crunch.
Io il crunch l’ho conosciuto anche nella mai vita precedente in agenzia. È un problema serio, che noi abbiamo provato a superare con una policy ferrea, memori delle esperienze passate di breakdown. Funziona così: quando sento che sto superando una soglia di ore sopportabili cerco di ricordarmi che il nostro è un lavoro creativo, ma di fondo inutile, e non salvo vite. E la applico anche a chi lavora con noi (sottolineo con, non per). In fondo produciamo più tecnologia di quella che riusciamo a governare. A volte mi chiedo che senso abbia.

Colpo di Stato è un gioco di carte narrativo cooperativo per 2-6 persone, ispirato alle meccaniche degli escape games.
Torno un attimo sulla tua descrizione del videogiocatore italiano: maschio, bianco, etero. Il tema del machismo nel mondo dei videogame l’ho già affrontato con Daniele Giardini, ma credo sia molto più interessante sentire il parere di una donna.
Io ho la fortuna di aver fondato il mio studio col mio compagno, che ha un rispetto per la donna altissimo, e non avrei mai potuto stare con una persona diversa. E di conseguenza i nostri collaboratori li cerchiamo tra persone che condividano la nostra mentalità. Perciò io, Claudia, non ho mai avuto esperienze spiacevoli nel mondo del videogioco, ma so di fare riferimento a un giardino che mi sono creata e che non è così per tutte le videogiocatrici e le sviluppatrici. Il GamerGate mi ha disgustata, ma era lontano, ero nel settore da un annetto e non capivo bene. Mi ha invece inquietato la situazione più recente nata dallo sfogo e dalle rivelazioni di Natalie Lawhead. La vicenda è di per sé raggelante, ma il trattamento da parte dei giornali italiani è stata ancora peggio.
Nel mondo del videogioco italiano questa parte però non esiste. Si parla di recensioni, numerini, qualcuno prova a fare un discorso un po’ più profondo, ma di questa roba non se ne parla.
Ritorniamo al discorso culturale: di fondo qualcuno pensa che le donne nei videogiochi non dovrebbero entrare. Spesso il confine tra goliardia e denigrazione è labile. Lo vedo dai modelli 3D che ci vengono sottoposti per la valutazione: spesso anche a livello di scuola non c’è un incentivo all’attenzione verso la figura femminile, né verso la partecipazione femminile. Per me è faticoso partecipare a eventi dove sono l’unica donna perché vedo che in sei anni la situazione non è cambiata di una virgola: resto sempre l’unica donna. Alcune mie studentesse mi dicono di avere pseudonimi maschili per giocare online in santa pace.
C’è poi un aspetto che si sottovaluta: si punta spesso il dito contro chi denuncia per i modi in cui lo fa, dimenticando che ci vuole un grande coraggio a farlo. Secondo statistiche 1 donna su 3 è stata oggetto di violenze: prova a chiederti quante delle donne che conosci te ne hanno mai parlato e se c’è una correlazione con questa media. Stimo le donne che hanno trovato la forza di parlare di cosa succede sui loro luoghi di lavoro.
Nel raccontarlo ci è focalizzati sul contesto dei videogiochi, quando in realtà sono cose che succedono ovunque.
Esatto, l’atteggiamento del videogiocatore è stato quello di difendere il proprio giocattolo, arrivando a chiedersi cosa ci facciano le donne nel settore, invece di allargare il ragionamento nella direzione opposta. Ci sono Pride per quasi tutte le minoranze, ma non per le donne abusate, perché non c’è nessun orgoglio nell’esserlo. L’immaginario della donna abusata è quella di una figura triste e depressa, lamentosa e professionalmente non evoluta: la realtà triste invece è che di donne abusate ne incontriamo a decine ogni giorno senza saperlo né riconoscerlo, donne che lavorano, che vincono premi, che hanno figli e viaggiano. Senza dirlo per non essere marchiate, perché in fondo per alcuni te la sei andata a cercare se sei andata a lavorare in uno studio di videogiochi di soli uomini.

Le idee di We Are Musli ogni tanto si fanno molto fisiche, come nel caso di Wer Ist Wer, escape romm che ha esordito a Torino nel novembre 2019.
Perché secondo te la community dei videogiocatori è particolarmente problematica in questo senso?
Non vorrei cadere nei cliché, ma giocare a titoli che non ti spingono mai a riflessioni personali non aiuta. Immagina se il cinema fosse solo i cinepanettoni: che pubblico ti aspetteresti di trovare? I giochi sono concepiti come luoghi dove scaricare lo stress, e non come erogatori di valori. Poi fare un videogioco non è considerato un vero e proprio lavoro, perciò alcuni appassionati ritengono di poter mettere in discussione chi lo fa, spesso basandosi sull’aver giocato più degli sviluppatori stessi. Ma a chi scrive romanzi non viene richiesto di aver letto tutto il catalogo Feltrinelli. Mentre è facile trovare commenti del tipo: “Perché assumete donne, sono incapaci di sviluppare”.
Io credo che alcuni davvero non percepiscano lo sviluppatore come una persona che lavora, ma come un bot senza volto, il cui ruolo è fare ciò che il videogiocatore si aspetta, pena gli insulti.
Il videogioco non è visto come qualcosa di autorevole. Questo approccio ha dato spazio alla figura dello youtuber, che sventra sul tavolo dell’autopsia il lavoro di tre-quattro persone, di qualcuno che ha impegnato la casa per fare un videogioco, usando gli stessi strumenti critici che userebbe per una produzioni milionaria Ubisoft, senza pensare alle conseguenze.
Cosa potrebbe migliorare la situazione a livello istituzionale, almeno in Italia?
Oddio. Credo fondi che aiutino lo sviluppo di titoli più inclusivi, più orientati alla cultura. E poi servirebbero interventi e programmi rivolti alle sviluppatrici, che aiutino l’ingresso delle figure femminili nell’industria.