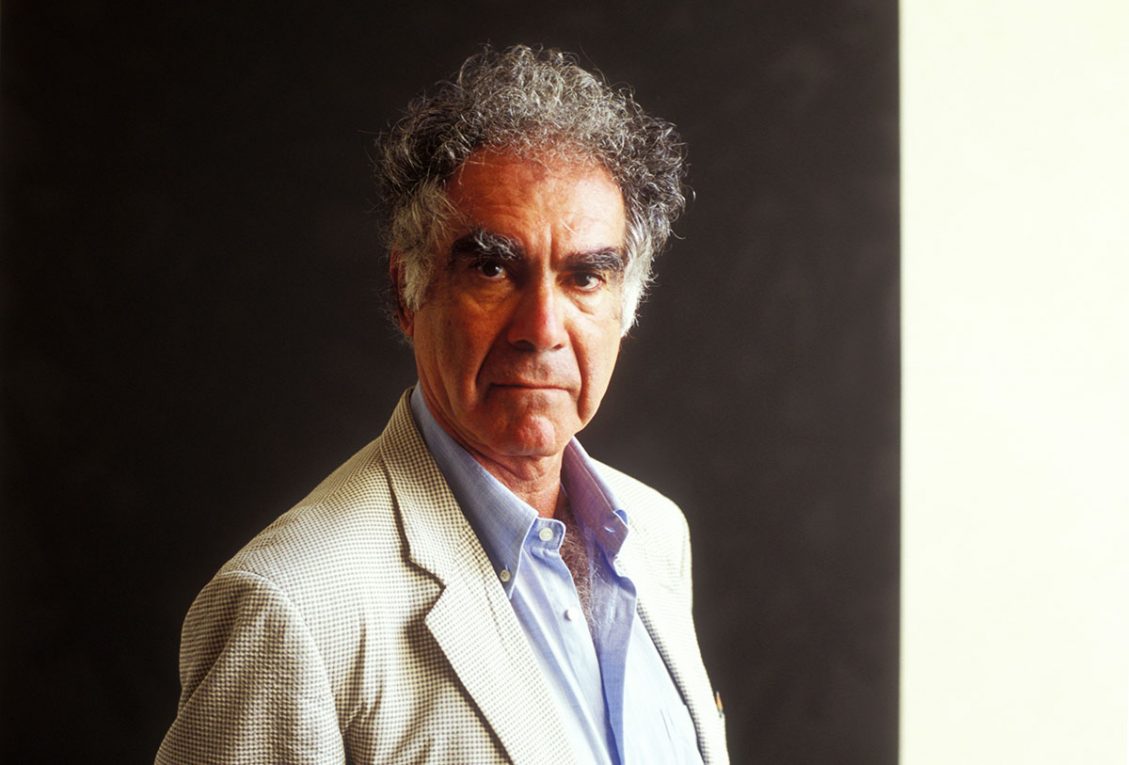A differenza di molti altri quartieri di Roma che, pur presentando alti e bassi, sono in genere belli o brutti in modo omogeneo, l’Alessandrino è composto da pezzi di varie città completamente diverse cuciti insieme. Ogni zona dell’Alessandrino — Tor Tre Teste, Alessandrina, Quarticciolo — è frazione a sé di un comune schizofrenico e col deficit d’attenzione, che si interrompe e ricomincia ogni volta che, a sua volta, è dilaniata dalle invalicabili differenze tra un isolato e l’altro, tra via e via, tra interno e esterno di uno stesso palazzo, tra facciata e retrobottega dello stesso bar. L’Alessandrino è un mostro urbanistico che, adagiato sul suo gigantesco lettino anatomico tra l’acquedotto dell’imperatore Alessandro Severo (che dà il nome al quartiere) e la Lidl di via Prenestina, nonostante l’elettricità lo raggiunga e lo scuota, a mo’ di creatura di Frankenstein, attraverso i tralicci dell’alta tensione, purtroppo non prende mai vita.
Per dirla alla Oscar Wilde, non si può vivere nel lato alla moda di Tor Tre Teste o in quello meno accattivante del Quarticciolo. Puoi capitare, a seconda del metro quadro in cui ti ha collocato un destino comunque non indulgente, o in un comprensorio con il parco privato (Tor Tre Tesle) o in un campo di pomodori, coltivato esattamente a dieci metri dalla sbarra di accesso al comprensorio. Per dirla alla Ligabue, certe notti puoi farti una bevuta di troppo al bar Giolli, il cuore pulsante di bingo e slot machine della Little Las Vegas che è il confine Nord del quartiere, prendere l’auto e chiederti se, svoltato l’angolo con via Aristide Staderini, sei ad Albuquerque New Mexico o sul lungolago — senza il lago — di qualche riserva montana della provincia di Rieti.

Influencer di Tor Tre Teste rincasa dopo uno shooting fotografico
Prendete la Biblioteca Gianni Rodari e il Parco Giovanni Palatucci, a Tor Tre Teste: l’una di fronte all’altro, vicinissimi eppure per sempre separati dalle auto che sfrecciano e dalle erbacce che crescono su via Tovaglieri, non più spesse della parete tra le stanze di Piramo e Tisbe, ma ugualmente invalicabili per i cittadini che non li conoscono o addirittura non li vedono. L’una, che vanta uno dei palinsesti di presentazioni di libri più ricco del circuito delle biblioteche di Roma, e l’altro — non solo è dotato di laghetto, ma perfino di giochi d’acqua tipo Ginevra — si tendono eternamente la mano, in una delle combo tra cultura e natura più potenti mai azionate nelle sale giochi per potenti che sono le periferie romane.
Per questo, l’Alessandrino è la Roma contemporanea sintetizzata in un solo quartiere. La parte della città che, meglio di tutte le altre, interpreta la vera grande bellezza di Roma, che non è più — come Fellini ci ha insegnato e Sorrentino ci ha ripetuto ossessivamente al doposcuola — l’accumulazione di un certo numero di meraviglie artistiche o architettoniche, una accanto all’altra, ma semmai l’autoassolversi nel godere del continuo contrasto tra schifo e incanto, tra Villa Medici e piazzale Clodio. Ogni bruttezza dell’Alessandrino propelle una bellezza adiacente, segreta o seminascosta, che non sarebbe altrettanto bella se non fosse per l’oscenità che le ha dato l’assist per essere la Cenerentola della situazione, grata alle sorelle Anastasia e Genoveffa per ciascuno dei loro brufoli.

Il lato non formale del Bar Oasi, visto da largo Mola di Bari
Pensate al valore che ha l’angolo dell’orrore tra via Prenestina e via Palmiro Togliatti per il fascino intramontabile di quel luogo, strappato con le unghie e con i denti alla serie di non luoghi confinanti, che è il Quarticciolo. Una borgata romana degli anni ‘40 che, ancora oggi, è rimasta fedele al suo vecchio spirito di simulazione di vita in paese, con i suoi palazzi quasi tutti uguali, ma ciascuno degradato in modo diverso. La domenica mattina c’è un silenzio tale che dalle cucine viene fuori una sinfonia di sfrigolii e di cazziatoni materni. La comunicazione tra vicini, anche non vicinissimi, è urlata a viva voce, tra davanzali, con battiti di mani come notifiche.
È ammirevole l’onestà intellettuale del declino del Quarticciolo, non ostentato né nascosto, ma sincero e dignitoso, come lo è la vegetazione dei cortili — mai recintati — ormai intricata come piccole foreste, ma comunque goduta fino all’ultima foglia che ripari dal sole di ottobrata. La sedia in plastica, cuscinata, che si aggiunge con grazia e naturalezza alle panchine comunali, per giunta ostentando una discreta sicurezza nei confronti della possibilità di furti, è la perfetta dialettica tra pubblico privato che piace alla gente che non mette mi piace.
C’è una sola osteria storica (il Quagliaro) ma ci sono due biblioteche, altrettanto pubbliche: quella comunale, aperta anche la domenica, con tanto di sterminato cartellone teatrale, e quella occupata, ovviamente aperta, con aria di sfida, di fronte all’altra. Molti dei pochi negozi hanno un doppio ingresso, come i bar delle stazioni o i passage parigini, con un lato più pomposo (su piazza del Quarticciolo) o un lato più informale (su largo Mola di Bari). Nei villaggi turistici, dopo la colazione, prendi la bici e vai al mare, qui prendi lo scooter e vai a Roma.

Un cortile al Quarticciolo, nido d’amore tra pubblico e privato
Purtroppo, invece, nessuno scriverà mai una guida alle cose da fare a Tor Tre Teste. È più probabile che esca una top ten delle cose da non fare a Tor Bella Monaca. Molte delle attività più interessanti, inevitabilmente, ti portano in altri posti, come aspettare il 556 o farsi a piedi la ciclabile che costeggia il parco dell’acquedotto. Molte, ma non tutte, perché visitare la chiesa di Dio Padre Misericordioso, o Dives in Misericordia, costruita dall’archistar Richard Meier per il Giubileo dell’anno 2000 (salvo terminarla nel 2003), è una delle esperienze più eccezionali da fare a Roma. È come se l’intera Tor Tre Teste l’avesse fatto apposta, di essere così brutta, e insignificante, pur di dare l’assist giusto a questa chiesa.
Dives in Misericordia ha portato alle estreme conseguenze la simbologia nautica che è alla base di ogni chiesa dotata di almeno una navata: un viaggio per mare verso la salvezza. Meier è andato oltre e l’intera costruzione di Tor Tre Teste ha la forma di un veliero trialbero, che sfrutta tanto meglio il vento metaforico rispetto alle classiche vele dei palazzoni intorno. Il più imponente dei quali, interamente ricoperto di vetro e appartenente a Francesco Totti, al confronto con Dives sembra una meganave da crociera, di quelle che ogni tanto fanno temere il peggio a Venezia, piene di turisti ma totalmente prive di grazia. Al confronto con Dives moltissime altre belle chiese di periferia sembrano inquinanti barche a motore o, ancora più prosaicamente, un ufficio postale di provincia.
I palazzi intorno alla chiesa sono democraticamente riflessi nelle sue grandi vetrate, che non sono per niente schifiltose. Il cemento che le sostiene, progettato apposta da Italcementi, è di tipo speciale e autopulente, così autopulente che i ragazzi dei muretti attorno hanno paura a mangiarci le crêpes. La regola dei cinque secondi per il cibo caduto in terra qui sembra conoscere una variante: in caso di distrazione, non hai paura che la crespella si infetti, ma di perderla, riassorbita dal cemento.
Per fortuna la metafora navale si ferma all’esterno: dentro niente salvagenti, nodi marinari, etc. Non sembra di entrare in una chiesa per dire un’Ave Maria, ma da Gagosian per chiedere il prezzo di un Cy Twombly. All’ingresso, è una sorpresa trovare messali invece che copie di Elle Decor o AD.
La pala d’altare è Gesù con attorno il logo della chiesa: tre vele e un albero maestro ben diritto. La sagrestia è a vista, trasparente come la cucina di un sushibar: un buco della serratura più grande della porta stessa. Seguono dettagli come l’acquasantiera minimalista, il fonte battesimale sperimentale, i confessionali curati come salottini di Artissima. Gli amplificatori hi-fi (“Mejo de Bang e Oluffese!”) hanno il bordo color legno quando sono appesi sul legno e bianco quando sono appesi sulla parete bianca.
Gli unici elementi che non sono di design sono i fedeli e un crocifisso in cartapesta del ‘700 (che però si illumina una volta l’anno per un raggio di sole accuratamente direzionato). Nonostante questo, nessuno di loro si sente in colpa per non aver aderito a un certo dress code. Tutto è perfettamente funzionale alla devozione. Ognuno dei devoti, coi suoi particolari colori guida e concept dell’abito buono della domenica, sa qual è il suo ruolo, inconsciamente e ingenuamente come un portatore sano di verità: esaltare la perfezione dell’insieme attraverso la manifesta inadeguatezza del singolo.
Dives in Misericordia, a ogni Messa, lancia la sua sfida non solo a Roma Est, ma a tutta la città: “Non preoccuparti di certi dettagli, sei sempre in tempo per la salvezza, e per rifarti il guardaroba”.