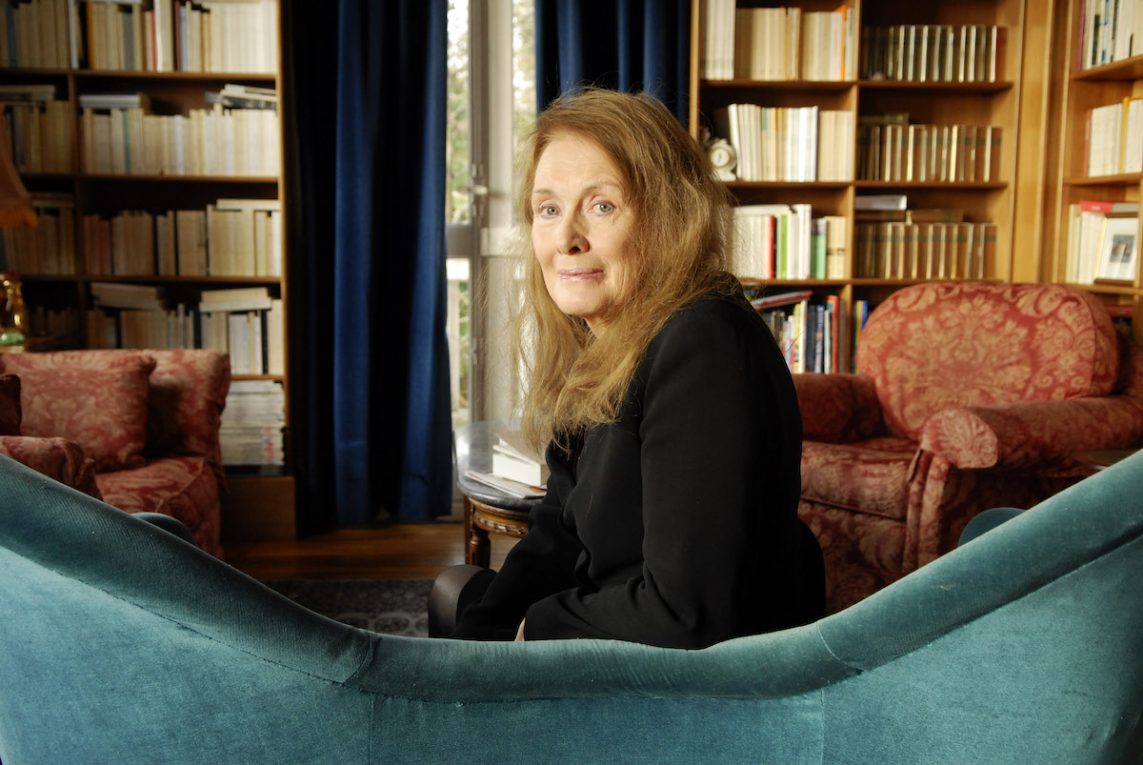Si chiama decreto Minniti ma in realtà è stato prodotto tanto dai tecnici del ministero della Giustizia guidato da Andrea Orlando quanto da quelli del ministero degli Interni diretto da Marco Minniti. Contiene le nuove regole che dovrebbero fronteggiare l’emergenza immigrazione, in particolare il nodo dei rifugiati, ma promette di diventare un campo di battaglia quando, quasi certamente la settimana prossima, sarà in discussione al Senato. L’Associazione nazionale magistrati lo ha già bersagliato di critiche, con un documento che esprime “fermo e allarmato dissenso”.
L’elemento più vistoso è la sostituzione degli attuali Cie, i Centri di identificazione ed espulsione attualmente in vigore, con i Cpr, Centri di permanenza per il rimpatrio. Il compito dei Cie sarebbe quello di identificare i migranti non in possesso dei requisiti per l’accoglienza come rifugiati, individuare i paesi di provenienza e procedere al rimpatrio. In Italia ce ne sono al momento 6, per una capienza di circa 700 persone. Sono gestiti da ditte private, in base a gara d’appalto, e presidiati dall’esterno da forze di polizia che possono intervenire solo su richiesta dei gestori. Il tempo di permanenza iniziale era di 30 giorni, il governo Berlusconi lo portò addirittura a 18 mesi, la riforma del 2014 ha fissato un tetto di 90 giorni che però in una quantità di casi è puramente teorico. Viste la difficoltà di identificare i migranti e la scarsa collaborazione dei Paesi di provenienza, e la ancora maggiore difficoltà di eseguire i rimpatri, il termine è spesso soggetto a una serie di proroghe. I Cie si sono così trasformati di fatti in una sorta di prigioni.
Le critiche nei confronti dei Cie sono state negli ultimi anni innumerevoli: l’accusa è quella di essere di fatto dei lager nei quali vengono tenute in stato di reclusione persone che non hanno commesso alcun reato, e questo senza in compenso neppure scalfire il problema. La formula del governo Gentiloni si limita a moltiplicare i Cie e a cambiargli nome. I Cpr dovrebbero essere 20, uno per regione, con capienza di 200 posti ciascuno. Anche l’elemento di garanzia apparentemente più innovativo, la sorveglianza da parte del Garante nazionale dei diritti del detenuto, è in realtà solo la conferma di una ricognizione già effettuata dal Garante sui Cie, ma con scarsi effetti.
Il decreto si limita a moltiplicare i Cie, pur ribattezzandoli, e dunque non risponde neppure in minima misure alle critiche. Anche sul piano dell’efficacia non ci saranno grandi cambiamenti. Non solo perché le difficoltà nei rapporti con i Paesi di provenienza, che costituiscono l principale ostacolo ai rimpatri, non subiranno modifiche ma anche perché anche così moltiplicato (da 700 a 2mila) il numero di migranti nei centri resta risibile rispetto alle dimensioni dei flussi migratori. L’obiettivo del decreto, ammettono del resto apertamente le fonti del Viminale, è essenzialmente dissuasivo. La speranza è che aumentando la capienza dei Centri e rendendo più celeri le procedure d’esame delle domande d’asilo, diminuisca il numero di quanti presentano domanda d’accoglienza pur sapendo che verrà respinta perché contano comunque sui tempi lunghi degli accertamenti.
Il problema è che proprio le nuove regole che dovrebbero accelerare i tempi di accettazione o rifiuto delle domande d’asilo politico sono quelli più severamente criticati dai magistrati e da molti costituzionalisti, oltre che da praticamente tutte le associazioni che si occupano dell’emergenza immigrazione. L’innovazione più clamorosa è l’eliminazione di uno dei tre gradi di giudizio, l’appello. Il richiedente a cui venga negato lo status di rifugiato potrà ricorrere solo in Cassazione, senza passare come in tutti gli altri casi per l’appello. In questo modo, però, si introduce una sorta di iter giudiziario discriminato per una specifica categoria di persone, con effetti potenzialmente devastanti sul principio base per cui “la legge è uguale per tutti”.
La decisione, inoltre, spetterà al giudice monocratico, sarà presa cioè da un solo magistrato e non da una corte e senza contraddittorio con la persona soggetta a giudizio. Il giudice monocratico si avvarrà solo delle videoregistrazioni dei colloqui tra il richiedente asilo e la commissione che ha deciso di respigere la sua richiesta. Il richiedente potrà sì chiedere di essere ascoltato direttamente, ma sarà poi il giudice a decidere se farlo o meno. L’udienza della Cassazione, secondo e ultimo grado di giudizio, non sarà pubblica. Nel complesso è evidente l’indebolimento drastico dei diritti della difesa, in linea con la strategia “dissuasiva”. Si tratta di un capitolo particolarmente delicato, sia perché si crea così una categoria specifica discriminata e per definizione “meno garantita”, sia perché in tema di rifugiati politici l’errore equivale spesso a una condanna a morte nel Paese d’origine.
C’è in realtà un ultimo punto critico, forse il più discutibile di tutti. La strategia delineata dal ministro degli Interni punta fortemente sulla ripresa degli accordi con la Libia siglati nel 2008 e poi nel 2012, al momento resi per la verità virtuali dalla instabilità politica di quel Paese.
Il 9 gennaio scorso Minniti è stato a Tripoli e al termine della visita ha indicato un nuovo accordo italo-libico che dovrebbe avere tre obiettivi: la stabilizzazione del Paese, il contrasto al terrorismo e la lotta al traffico di esseri umani. La nota dolente è che, per quanto in Italia la cosa sia stata tenuta il più possibile celata, l’accordo del 2008 con Gheddafi era sì riuscito a frenare le partenze dalle coste libiche, ma a prezzo di migliaia di vite. Gheddafi aveva onorato l’accordo, del resto per lui proficuo, con l’Italia rimpiendo il deserto di cadaveri e dando mano libera alla sua polizia per ogni tipo di vessazione. Non è affatto detto che una nuova intesa italo-libica debba ripercorrere le tracce di quella del 2008, uno dei capitoli più vergognosi della politica estera italiana. Ma sarebbe bene stare molto attenti, perché il rischio di ripetere quell’esperienza tragica senza dubbio c’è.