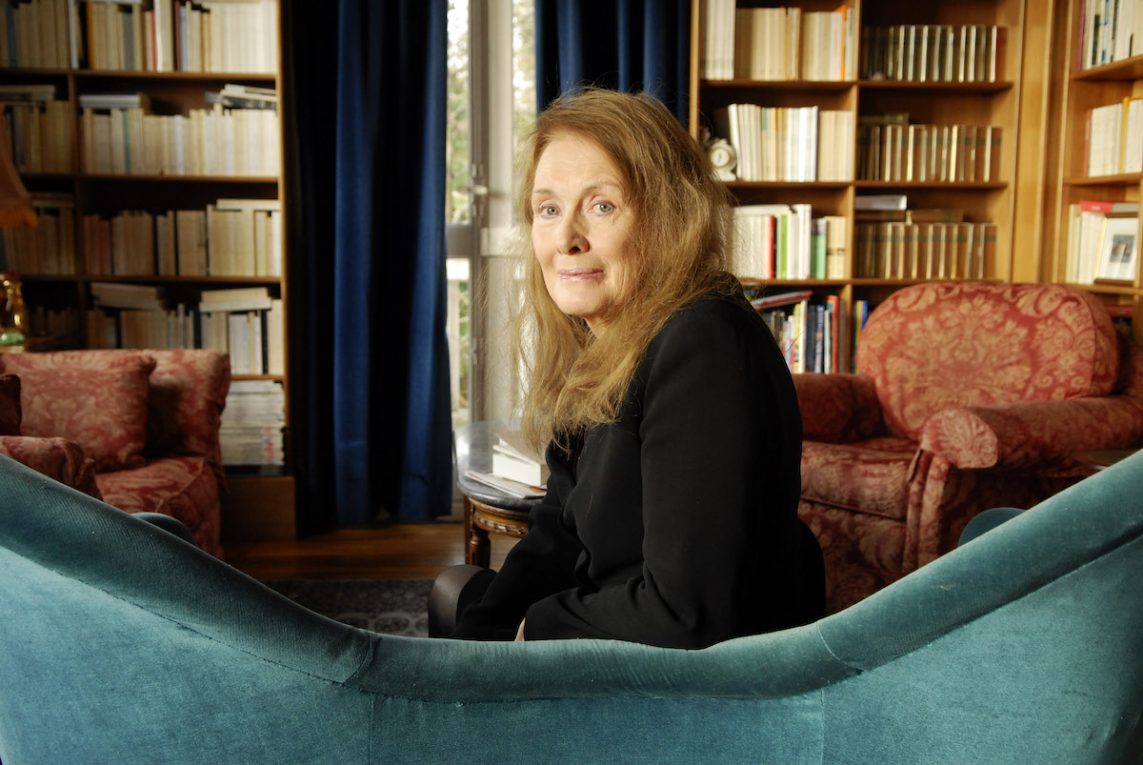Due sere fa, al Tg di La7, quando Enrico Mentana le ha chiesto, un po’ affranto e un po’ sarcastico, se esiste “un’aggressività femminile” nei suoi confronti e se il suo sia un caso di “deroga a un clima di maggior rispetto nei confronti delle donne”, Giorgia Meloni ha fatto una cosa intelligente. Ha risposto: «C’è stata un’aggressività complessiva verso di me»; ha ricordato l’attacco che ha subìto a Livorno (il 13 febbraio scorso, alcuni militanti – negli anni Novanta li avremmo chiamati antagonisti di sinistra – l’hanno cacciata dal centro della città cantando “questo è il fiore del partigiano morto per la libertà” mentre le urlavano “troia” e le sputavano addosso); ha fatto notare che, durante la campagna elettorale, in quasi tutte le trasmissioni televisive in cui è stata invitata, le è stato chiesto quasi esclusivamente conto dei nuovi rigurgiti fascisti («e pure delle guerre puniche»: ricordo perfetto di quando Andreotti disse «A parte le guerre puniche, mi è stato attribuito veramente di tutto») e quasi mai del suo programma politico.
Così, ha schivato l’assist del sessismo, ha evitato di mettere sul banco degli imputati le donne ed ha impedito a Mentana di trasformarla in una testimone dell’opinabilità della solidarietà femminile. Non l’ha fatto per femminismo, consapevole com’è di non poter contare su difese d’ufficio: sul suo corpo – quando era incinta, dopo che ha partorito, quando si è fatta fotografare per i manifesti elettorali ricorrendo, come tutti, a qualche filtro di troppo – si è potuto infierire con insulti, parodie, minacce (“eccovi una lardosa fascista sorpresa a brucare”, scrisse lo scorso anno Asia Argento su Twitter, postando una foto che le aveva scattato mentre era a cena fuori), senza che la cosa venisse denunciata con troppa decisione, senza che una solidarietà corale e compatta le venisse manifestata, senza che nessuno di coloro che le esprimevano sostegno evitasse di specificare la propria distanza da lei (del senza se e senza ma, Giorgia Meloni, forse, non potrà beneficiare mai).
Le importa? È quasi impossibile capirlo: questo è uno dei suoi punti di forza. È (o sembra, non fa differenza) del tutto impermeabile alle manifestazioni stomachevoli e stomacali di odio nei suoi confronti: denunciarle non solo non l’appassiona, ma sarebbe, per lei, una imperdonabile distrazione. “Prima gli italiani”, nella greve declinazione di Salvini, significa “prima io e, per ultimi, se resta spazio, ma tanto non ne resta, gli immigrati”; nella declinazione di Giorgia Meloni, significa “per ultima io”.
Non si tratta di abnegazione monacale, naturalmente, bensì di strategia. Meloni soddisfa qualcosa di più profondo, rispetto a Salvini, e cioè la richiesta, né populista e né demagogica ma di certo un po’ ingenua, che i politici mettano da parte loro stessi (meglio: diano l’impressione di farlo). Nel 2006, quando era vicepresidente della Camera, disse: “Berlusconi ha fatto delle leggi per se stesso, ma sono leggi perfettamente giuste”, anche se già sapeva che quel personalismo, bandiera di altri e non sua, aveva i giorni contati. Erano altri tempi.
La ragione per cui Giorgia Meloni non risponde a Mentana «Sì, direttore, certo che molte donne mi odiano e mi aggrediscono, e sono le stesse che poi denunciano le angherie del patriarcato» è che deve mostrarsi interessata agli altri e non a se stessa, che non deve mai e poi mai accusare i colpi, che deve spendersi alla maniera di una madre devota, unica figura non esposta alle inflazioni congiunturali, eterna, imbattibile. Cosa c’è di più materno del ridimensionarsi per occuparsi del prossimo? Quando è andata al Museo Egizio, qualche settimana fa, per protestare contro la promozione dedicata ai visitatori di lingua araba, accusando il direttore di “razzismo nei confronti degli italiani” (sembrava uno sketch de I Nuovi Mostri), non sembrava una di quelle mamme un po’ invasate che accusano gli insegnanti di favorire i figli degli altri a scapito dei propri? Amore, non preoccuparti, adesso arriva la mamma e si mangia la maestra.
Salvini non è mai stato altrettanto grottesco, neanche quando ha giurato sul Vangelo, bravata della quale è stato chiesto conto quasi più a Giorgia Meloni che a lui – lei un po’ ha preso le distanze, un po’ ha ricordato che assistiamo ogni giorno ad appropriazioni altrettanto indebite, un po’ s’è incazzata ricordando che lei non è Salvini. Nessuno più di Giorgia Meloni soffre l’assimilazione ai suoi alleati e colleghi di coalizione o area politica e non accade perché è una donna, per di più di destra e di grande talento politico – la prima donna a diventare, nel 2004, presidente di una organizzazione giovanile di destra (Azione Giovani); una tra i più influenti sabotatori del progetto, principiato da Fini, di costruire una destra repubblicana (errore tragico, di cui mai come in queste elezioni stiamo pagando il prezzo); una che ha fondato un partito di destra, Fratelli d’Italia, tra le figure di riferimento del quale, insieme a Tolkien, Mameli e D’Annunzio, ha infilato Pier Paolo Pasolini; l’unica responsabile del capolavoro politico che ha ridato la Sicilia al centrodestra, pochi mesi fa; quella che ha indetto una manifestazione anti-inciucio, il mese scorso, per garantire agli elettori che lei non firmerà alleanze di convenienza (Salvini e Berlusconi l’hanno disertata, senza alcuna conseguenza tangibile sul loro consenso); quella che a tre giorni dal voto va da Orban, a Budapest, e dice di averlo fatto in opposizione alla genuflessione di Gentiloni all’asse franco-tedesco, che ci userebbe e ci condannerebbe alla subalternità in Europa, mentre l’Italia è con i paesi dell’Est che dovrebbe dialogare e allearsi, essendo quei paesi uniti contro lo strapotere di Berlino.
Eppure, nonostante tutto questo, Salvini inghiotte Meloni. Succede, tuttavia, per responsabilità di Meloni: ha scelto di muoversi nel solco greve della lotta all’immigrato, di cui Salvini è campione indiscusso e indiscutibile. Ha scelto di adattare il suo linguaggio, certo sempre colorito ma pure debitore di una destra diversa da quella leghista – lo specifica lei stessa, invano: “nello Statuto di Fratelli d’Italia si parla di unità nazionale, in quello leghista ancora di indipendenza della Padania” – a quello assoluto e greve e semplicistico di Salvini. E così, da giovane ministro della Gioventù (era il 2008, aveva 31 anni) capace di andare in tv, da Victoria Cabello, a imitare Giulio Tremonti (stupenda, persino Corrado Guzzanti le fece i complimenti) e capace di chiedere agli atleti italiani di boicottare la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Pechino come atto di solidarietà verso il Tibet (anche in quel caso fu lasciata da sola dai suoi), è diventata l’ancella del populismo di destra, la Marine Le Pen della provincia al di qua delle Alpi, una che espone un cartello contro Laura Boldrini con sopra scritto “Radical chic in miniera”, una che straparla di razzismo verso gli italiani.
L’altra sera, quando Salvini ha esordito in collegamento da Floris dicendo «la prossima volta sarò in studio con voi da Premier» (a proposito di “prima gli italiani, cioè io”), alla domanda su come siano i rapporti tra lui e Giorgia Meloni, il ragazzo della Lega ha risposto raccontando di quanto s’inorgoglisce quando va a incontrare gli operai e quelli gli dicono che voteranno lui e non Pd, senza che nessuno gli ribattesse che non aveva risposto alla domanda, così come nessuno lo inchioda mai davvero quando si rifiuta di discutere di fascismo. A lei va decisamente peggio: le capita di finire in un tre contro uno a Otto e mezzo e di ritrovarsi a dover dare conto soprattutto del suo legame con Salvini, un legame che entrambi mal sopportano, ma di cui solo lei non smette e non smetterà forse mai di essere vittima.
È una delle ragioni per cui non riusciremo a vedere se lei sia stata o meno una delle più grandi occasioni sprecate del Centrodestra; la donna più forte e più debole della politica recente; la più a sinistra della destra o la più a destra della sinistra; la vittima o la carnefice del fascismo degli antifascisti. Peccato.