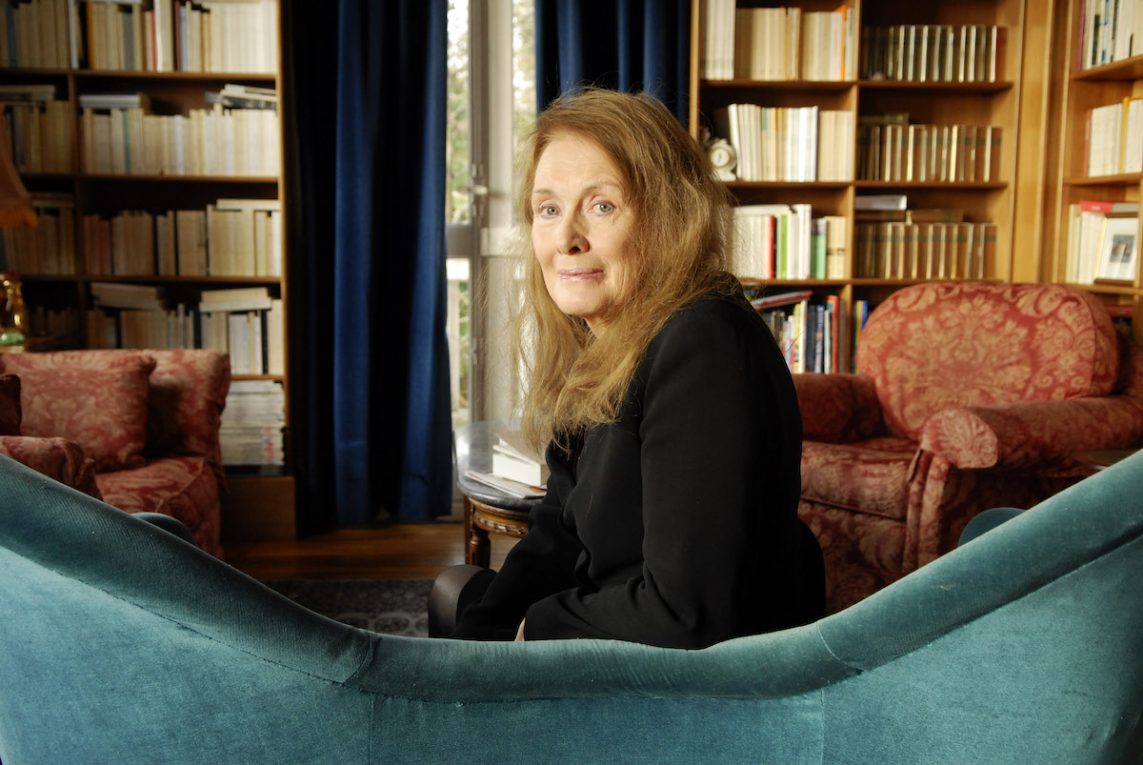La ricorrenza si avvicina, ma i festeggiati ancora non sanno se il prossimo 14 ottobre taglieranno la torta con dieci candeline sopra o dovranno presenziare a una più mesta veglia funebre. Nel PD tira un’ariaccia di scissione che costringerebbe a rispolverare le cartografie politiche antecedenti al 2007: da un lato un partito di vaga ispirazione socialdemocratica, identico agli antichi DS in tutto tranne che nel nome, dall’altro una formazione centrista a forma di Margherita, erede dell’antica sinistra democristiana.
A decidere se il partitone si spaccherà subito come una mela o rinvierà la sofferta scelta a un imminente congresso non sarà questa o quella opzione politiche bensì una data: quella delle elezioni politiche. Matteo Renzi, il leader che per tre anni ha fatto il bello e il cattivo tempo nel partito e nel Paese, le vuole subito, meglio ieri che oggi e comunque non oltre l’11 giugno. È uno di quei giocatori d’azzardo che quando perdono forte nemmeno si domandano se non sia il caso di interrompere e rinviare a più fausta occasione, ma insistono per raddoppiare la posta nella speranza di rifarsi. Dopo la mazzata del referendum sulla sua riforma costituzionale, non ha pensato ad altro che alla rivincita. Solo le elezioni a breve, del resto, gli permetterebbero di non cambiare nulla nel partito. Soprattutto, è convinto che aspettare fino al 2018 significherebbe farsi risucchiare dal cono d’ombra che già lo avvolge. Dunque vuole le urne e le vuole subito.
Tanto per cambiare, la minoranza del suo partito, quella capitana dall’ex segretario Bersani, gran smacchiatore di giaguari, e dal delfino Roberto Speranza, è di parere diametralmente opposto: «Calma, gesso e revisione radicale di tutto il rivedibile, dall’assetto del partito alla linea politica». Non sono posizioni conciliabili. O vince l’una o trionfa l’altra ed entrambe hanno valide ragioni da sommare al puro interesse di fazione. Renzi ricorda che, per un partito che governa, arrivare al voto dopo una manovra economica che promette di far piangere il Paese intero nel prossimo autunno non è precisamente l’ideale. I rivali replicano sottolineando l’inopportunità di votare con una legge elettorale messa insieme alla rinfusa, abborracciata e contraddittoria come il costume di Arlecchino.
Hanno ragione entrambi. La temperie economica è davvero tempestosa, e la manovra d’autunno sarà il peggior viatico possibile per affrontare il popolo votante. Ma le leggi elettorali attualmente in campo garantiscono tutte sicurissima cilecca, in soldoni nessun vincitore e Parlamento ingovernabile. In un Paese che da 12 anni vota con leggi elettorali incostituzionali, dove la credibilità della classe politica veleggia sotto zero, non sarebbe l’optimum.
Anche se non è detta l’ultima, è probabile che tra le due accidentate vie alla fine il Partito Democratico imbocchi quella del rinvio e della rinuncia al voto prima dell’estate. Un po’ perché affrontare la tempesta economica, dopo elezioni a vuoto, senza un governo o con un governo nato agonizzante, potrebbe rivelarsi un rimedio peggiore del male. Un po’ perché la squadra compatta dei ministri – composta dai principali capibastone ex alleati di Renzi – di votare in corsa non ha nessuna voglia. Molto perché la scissione, con annesse disastrose ricadute elettorali, sarebbe a quel punto garantita. Merito di Massimo D’Alema, ex padreterno dei DS poi derubricato a rottamato numero uno. L’ex volpe del Tavoliere avrebbe dovuto, nei progetti di Renzi, rassegnarsi a un futuro di viticoltore. Invece, con la trovata un po’ surreale ma brillante di annunciare la nascita di un partito al momento composto più o meno solo da lui, ha rovesciato il tavolo. Quel partito virtuale ha offerto alla timidissima minoranza bersaniana la sponda necessaria per minacciare seriamente il divorzio finale.
Se non si voterà in giugno, il congresso anticipato diventerà invitabile: forse non a breve, perché sia gli ex alleati che la minoranza hanno tutto l’interesse a logorare Renzi lasciandolo cuocere nel suo brodo il più a lungo possibile, ma di centro entro l’autunno. Renzi giocherà per vincere. La minoranza giocherà per affondarlo, tenendo sempre pronta la carta di riserva della scissione. I capibastone attualmente ministri come Dario Franceschini, Andrea Orlando, Maurizio Martina (e forse anche lo stesso ex renzianissimo Graziano Delrio) si muoveranno per sostituirlo, con due principali alternative: l’attuale premier, Paolo Gentiloni, ben introdotto negli ambienti vaticani per genealogia familiare ma anche in grado, per biografia personale, di tessere un dialogo con la sinistra, e l’astro nascente Andrea Orlando. Il ministro della Giustizia ha fatto in tempo per un pelo a fare parte del PCI, diventando consigliere comunale a La Spezia a vent’anni. Può vantare una lunga militanza nei DS, l’area del PD più penalizzata da Renzi. Gode dell’appoggio prezioso del presidente emerito Giorgio Napolitano, che lo impose come guardasigilli a Renzi, che puntava invece sul procuratore di catanzaro Nicola Gratteri e sarebbe sostenuto con la dovuta discrezione da Ugo Sposetti, l’ex tesoriere che, secondo molte voci, attraverso un circuito di fondazioni controllerebbe ancora il “tesoro” dei Democratici di sinistra. Qualcosa in più di un semplice appoggio prezioso.
Saranno comunque assise senza rete e senza alcuna certezza, neppure quella di evitare almeno la scissione. Con il congresso il PD arriverà almeno a festeggiare il decimo compleanno. Però potrebbe essere l’ultimo.