“Esiste un altro mondo, ma è in questo” diceva Paul Eluard e uno dei compiti della letteratura è proprio il disvelamento di questo mondo segreto. Non tutti gli autori ci riescono, ma ce n’è uno che ne fa il suo marchio di fabbrica: Nicola Lagioia, premio Strega 2015. Nel suo ultimo libro, La città dei vivi, Nicola Lagioia ricostruisce l’omicidio di Luca Varani da parte di Manuel Foffo e Marco Prato. Un gesto che ha colto di sorpresa tutti e prima di tutto loro stessi. Il fatto di cronaca è stato un espediente per interrogarsi sulla natura umana e sul male, che compare in questa storia all’improvviso, quasi come in una possessione.
Sullo sfondo del racconto c’è una Roma in disfacimento, una giungla urbana simile al sottosopra di Stranger Things, dove la putrescenza è ovunque, ma da cui è quasi impossibile allontanarsi. Di tutti questi temi, di musica, cinema – e spoiler – del Marocco visto dalla Spagna, ce ne ha parlato in una lunga intervista da cui traspare un aspetto fondamentale del carattere di Nicola: è un uomo generoso che si concede senza remore.
Ho letto in questi giorni il tuo post su Facebook in cui racconti di aver deciso di non partecipare al Premio Strega di quest’anno con La città dei vivi. Come mai hai “rifiutato la nomination” se così si può dire?
Le motivazioni sono quelle del post, non c’è molto da aggiungere. Incentivare la partecipazione al premio di chi ha già vinto è un’idea che condivido, ha fatto bene Sandro Veronesi a presentarsi nel 2020. Io però ho vinto lo Strega con il romanzo precedente a questo. Tornare senza saltare un turno mi sembrava un gesto un po’ arrogante. Non ci si conosce mai abbastanza. O forse da lettore di certi classici potrei dire che temo la tracotanza.
La maggior parte di chi legge La città dei vivi si sente davvero toccato nell’intimo. Già l’episodio di cronaca ci aveva colpito l’opinione pubblica, ma è qualcosa di diverso ad attrarre il lettore verso le tue pagine. Secondo te qual è l’aspetto che crea questo magnetismo?
L’omicidio di Luca Varani non ha niente del giallo – sin da subito si conoscono i nomi dei colpevoli – né del thriller, perché non ci sono fuggiaschi da acciuffare e Manuel Foffo si consegna spontaneamente alle autorità poche ore dopo essere uscito dall’appartamento in cui il massacro ha avuto luogo. Dunque il problema non è “cosa è successo?”, ma “come è stato possibile?” È, paradossalmente, la domanda che fanno Manuel Foffo e Marco Prato ai propri stessi accusatori, non si capacitano nemmeno loro di ciò di cui si sono resi colpevoli. Com’è possibile che due ragazzi considerati normali, senza nessun movente, senza possibilità di trarre dall’omicidio alcun vantaggio, si ritrovano a torturare per ore un ragazzo di 23 anni che conoscono a malapena (è il caso di Prato) o non conoscono affatto (è il caso di Foffo) mettendo in scena con una violenza mai vista perfino dalle forze dell’ordine, qualcosa di simile all’omicidio rituale?
Non sono domande a cui la cronaca può rispondere. Nemmeno la letteratura può farlo, ma il suo fallimento è diverso. La strategia retorica delle opere letterarie non consiste nel consegnare al lettore risposte definitive, inevitabilmente sbagliate, ma nel sollevare le giuste domande, e nel provare a farlo nel modo più complesso, più umano, più profondo, se necessario anche più spiazzante e scandaloso possibile. L’incapacità di arrivare a un approdo è un punto di forza, ciò che si perde in definitività si acquisisce in conoscenza, e in dialogo. È per questo che i libri che amiamo continuano a interrogarci mesi e a volte anche anni dopo che abbiamo smesso di leggerli. La letteratura può fare il contropelo alla Storia (pensiamo a Primo Levi, a Javier Cercas) e a maggior ragione può farlo rispetto alla cronaca. Ci sono aspetti della realtà che non allo storico, non all’antropologo, non al filosofo, non al sociologo, non al giornalista e non al criminologo è dato di cogliere, ma allo scrittore. Più questa indagine va a fondo, più il lettore ne resterà colpito e adotterà per così dire il libro, lo farà proprio.
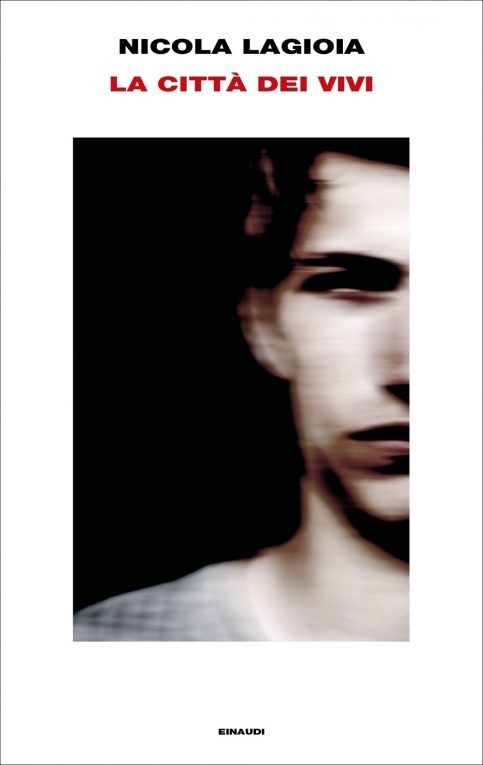
Hai letto i Vangeli per trovare il ritmo narrativo e “calibrare il male in una lingua esatta”. Come ci si allena, da non avvocato, al garantismo? Come hai fatto a non scivolare in un giudizio morale in quasi 500 pagine?
Per la letteratura comprendere è più importante di giudicare. È così per Dostoevskij, per Balzac, per Proust, per Joyce, per Lowry, per Wolf, per chiunque trovi nello scrivere un’occasione di conoscenza e affrancamento. È illuminante, a tal proposito, ciò che dice Albert Camus nel discorso di accettazione del Nobel. Non è dunque una questione di garantismo (le colpe in questo caso sono evidenti), ma se proprio dovessimo spiegarla in termini giuridici allora la letteratura sarebbe un’istruttoria non finalizzata a gradi di giudizio, una ricerca continua. Giudicare inchioda. Raccontare forse libera. La lettura dei Vangeli mi ha aiutato sul piano linguistico: mi serviva una lingua semplice ma al tempo stesso capace di evocare grandi complessità, e di affrontare all’occorrenza l’ambiguità, il mistero, l’insolubile. Ciò che gli estensori dei Vangeli riescono a fare con apparente semplicità è abbastanza stupefacente – dalle parabole a una ben determinata costruzione di certe curve narrative, ad alcuni pur brevi passaggi linguistici che sembrano enigmi contenuti in altri enigmi.
Nel libro racconti di Roma e della sua violenza. Ne ho parlato con un amico avvocato e ci siamo interrogati sulla differenza delle manifestazioni di violenza tra città. Bari, Roma, ma anche Napoli (da cui ti scrivo). La violenza può essere declinata in maniera diversa a seconda della città?
Sottoposta a un’analisi razionale, Roma non è una città violenta. Sul piano della messa alla prova dell’emotività di chi ci abita, lo è. Sul piano razionale basta contare il numero degli omicidi che ogni anno si consumano qui e rapportarli al numero degli abitanti. Si scoprirà che Roma è una delle capitali europee in cui c’è meno violenza, meno che a Parigi, che a Berlino, che a Bruxelles, per non parlare di quello che succede nelle città degli Stati Uniti.
Sul piano emotivo però, come dicevo, le cose stanno in modo diverso. Roma sfianca chi ci abita, esaspera, invita alla bestemmia, alla maledizione continua, è fatta per farti cadere in una buca che si apre all’improvviso sull’asfalto, per farti attendere ore dentro un ufficio pubblico senza ottenere il certificato che ti spetta di diritto. È una città impossibile, attraversata però da una vitalità unica. E molto ruvida, su questo piano è tutto violento: le emozioni, il modo di salutarsi, di discutere, di fare pace. A Roma anche l’estrema unzione te la danno a schiaffoni, schiaffi pieni di umanità, intendiamoci. Tutto si consuma, nulla cessa di esistere. È una città che non ti fa mai sentire solo. Io la amo. Per amarla devi essere disposto però anche ad accettare qualche tradimento. Poi, certo, c’è anche la violenza criminale. Quella è un’altra cosa ancora. La criminalità a Roma, sul piano antropologico, si declina in modo peculiare. Ogni città ha le sue caratteristiche. Credo che l’intercettazione sul “mondo di mezzo” tra Massimo Carminati e Riccardo Brugia nel famoso bar di Vigna Stelluti renda l’idea.
Mi interesserebbe sapere qualcosa in più del tuo legame con la musica. Sei batterista e so che hai avuto più di un dialogo pubblico con artisti come Vasco Brondi e Bianconi, ma ho letto in altre interviste della passione per altri artisti e per un altro Vasco) Cosa ascolti in questo periodo? E durante la scrittura ti concedi il piacere dell’ascolto?
In questi giorni ascolto Christian Löffler. Quando scrivo non ascolto niente. Mentre cammino da una parte all’altra della città (ho rottamato macchina, scooter, tutto, a Roma mi muovo a piedi, sono un’ombra errante nella città) ascolto sempre musica. Non sono più un batterista. Il mio amore per la musica, quando avevo quindici anni, nasce da due filoni in teoria poco conciliabili. Da una parte il post-punk dei Joy Division (e quindi dei New Order, di Smiths, Cure e così via). Dall’altra, tutto ciò che accade a Dylan dal terzetto delle meraviglie (Bringing It All Back Home, Highway 61 Revisited, Blonde on Blonde) in poi. Ho amato molto Vasco Rossi da ragazzo. Negli ultimi mesi ascolto molto Francesco Bianconi e i suoi Baustelle, Pierpaolo Capovilla, i CCCP, Faust’O, Lucio Dalla, Federico Fiumani e i suoi Diaframma, Edda, Moltheni, Luci della Centrale Elettrica, Bologna Violenta, Cosmo, I Cani, il Morgan delle Canzoni dell’appartamento, il Battiato di Cafè de la Paix, i Father Murphy. Posso ritrovarmi a sentire i Laibach o gli Animal Collective, Nick Cave e Patti Smith (per il Salone del Libro le abbiamo fatto fare un incontro fantastico con Giordano Meacci e i ragazzi di un liceo, tutto davanti al palco prima del concerto). E poi magari ritorno a Exile on Main Street. Mi interessa il binomio tra musica e terapie psichedeliche.
Ho visto una diretta su Instagram con un intervistatore molto giovane, di 16 o 17 anni, che ti ha fatto delle belle domande dal suo profilo privato. La cosa che mi ha colpito tanto però è che gli hai dato la possibilità di intervistarti, gli hai concesso molto tempo, che non è scontato per uno scrittore così acclamato. Dalla tua posizione consolidata di scrittore e intellettuale senti una responsabilità nei confronti delle generazioni più giovani che si traduce in dar loro più spazio?
Il mio problema, ma forse è anche il mio punto di forza, è che da questo punto di vista sono molto generoso. Do a chiunque il mio numero di telefono, e naturalmente c’è chi ne approfitta. Una volta mi ha citofonato un poeta che sosteneva di avere camminato a piedi da non so quale paese dell’Abruzzo per venirmi a trovare. Ovviamente non era vero, era pazzo di suo. Ma aveva il mio numero, il mio indirizzo, e dunque ho dovuto almeno invitarlo a prendere un caffè e ascoltare la sua storia. Non era Dino Campana.
Posso vantarmi di aver messo piede in buona parte delle librerie, delle associazioni culturali, dei piccoli circoli letterari sparsi in giro per l’Italia. E anche all’estero (Francia, Germania, Grecia, Stati Uniti, Canada, Spagna, Olanda) un po’ di giri a parlare di libri me li sono fatti. Lo faccio per curiosità, per fame, perché non sai mai cosa può capitare. Una volta, in Spagna, mi sono fermato per tre o quattro giorni in una comunità di fricchettoni dediti al culto dello psilocybe. Dormivano in strane capanne su un’altura. Nelle mattine terse si vedeva il Marocco. Naturalmente tutto questo divora un sacco di tempo. Molti apprezzano. Qualcuno, invece, per questo motivo può detestarmi: quelli come me dovrebbero essere irraggiungibili, il fatto di essere a portata di mano fa andare questi tizi fuori di testa. Il meccanismo psicologico che scatta in loro è molto preciso. Non ho la forza di spiegarlo. Preferisco il Marocco visto dalla Spagna. E l’Esquilino.
Hai un forte legame con il cinema, sei stato anche selezionatore e giurato alla Mostra del Cinema di Venezia. Ho letto che ci sarà una serie tv tratta dal libro, a che punto siete?
Della serie non si dice niente fino a quando è pronta e fino a quando i produttori non decidono che le prime comunicazioni possono essere date. Sì, nella mia educazione sentimentale c’è anche il cinema. Ricordo perfettamente la prima volta che vidi The Night of the Hunter, la prima volta che vidi To Be or Not to Be, la prima volt che vidi Accattone, La dolce vita, Io la conoscevo bene, Anna (di Alberto Grifi), la prima volta che vidi Mullholland Drive, Nausicaa della Valle del Vento, Cul de Sac, Tetsuo, Una moglie, Mean Streets… Ma anche le prime volte di Bruce Lee, di Bud Spencer e Terence Hill.
La promozione dell’ultimo libro mi sembra già di per sé un lavoro a tempo pieno, ma poi ci sono ovviamente tutte le altre occupazioni ufficiali tra cui anche la prestigiosa direzione del Salone del libro. Hai già iniziato a scrivere qualcosa di nuovo?
Magari! Io sono felice mentre scrivo. O mentre faccio ricerche per il libro che dovrò scrivere. Ci metto un sacco. Tra La ferocia e La città dei vivi sono trascorsi sei anni. Passerà molto, temo, prima di un altro libro, ma inizierò a lavorarci quando finirà la promozione di questo.











