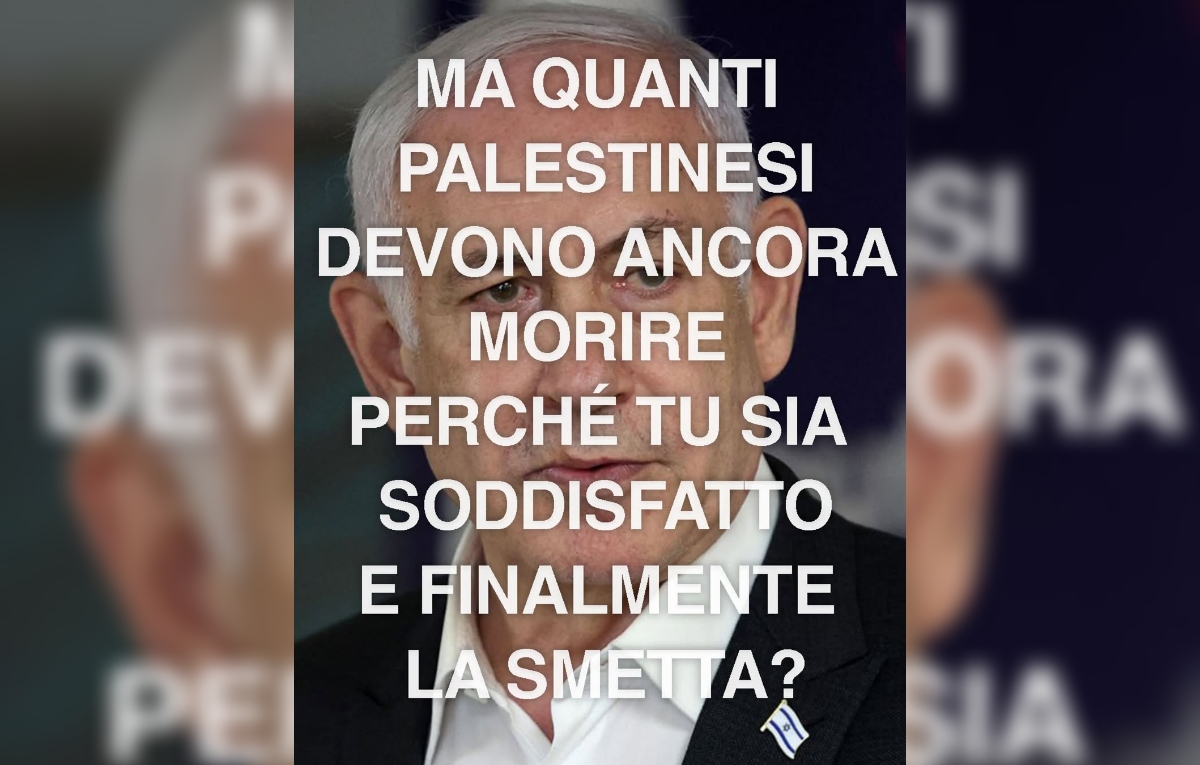Esattamente 50 anni fa, al termine di quella stagione di lotte sindacali e scioperi passata alla storia come “autunno caldo” del 1969, diventava legge lo Statuto dei lavoratori, approvato alla Camera con il voto a favore della Democrazia Cristiana e del Partito Socialista Italiano e l’astensione del PCI, che in tal modo voleva sottolinearne le carenze. “Lo Statuto dei lavoratori è legge”, titolava l’Avanti!, e “la Costituzione entra in fabbrica”. 50 anni dopo, scorrendo le home dei siti dei principali quotidiani italiani, è difficile trovare celebrazioni dell’anniversario di quel momento storico.
Eppure negli ultimi decenni lo Statuto dei lavoratori è stato oggetto di un’aspra contesa politica. Al centro c’era il suo articolo 18, quello che garantiva il reintegro sul posto del lavoro in caso di licenziamento illegittimo: per anni i tentativi di cancellarlo o di riformarlo hanno tenuto banco, fino a diventare uno dei segni distintivi del divario tra berlusconismo e anti-berlusconismo. Poi è arrivato il 2015, l’articolo 18 è stato “superato” nella terminologia renziana – ovvero è stato abrogato in seguito alla promulgazione del Jobs Act – e anche dello Statuto dei lavoratori non si è più parlato, o se ne è parlato molto di rado.
Tutto ciò è avvenuto per un motivo ben preciso, che riguarda il modo in cui è cambiato il mondo del lavoro in quegli stessi decenni di globalizzazione e rivoluzione tecnologica. Quei cambiamenti violentissimi che hanno investito ogni settore della nostra società hanno cambiato profondamente i connotati della classe lavoratrice e del concetto stesso di “lavoratore” e l’immagine della “classe operaia” degli anni Sessanta e Settanta si è fatta sempre più lontana dalla realtà. Naturalmente, allora, la conseguenza è stata vedere lo Statuto dei lavoratori come qualcosa di invecchiato, che rappresentava e cristallizzava rapporti che nel frattempo erano profondamente mutati. E che come tale andava appunto “superato”.
Gli ultimi anni hanno però mostrato che forse il punto non erano tanto i profondi cambiamenti nella realtà quando la nostra capacità di analizza nel modo corretto, la nostra definizione di cosa vuol dire essere un lavoratore. Tutta una serie di nuove categorie create negli ultimi anni dall’espansione della gig economy, come ad esempio i rider, sono una buona prova di questo punto L’immagine di una classe lavoratrice fatta di operai di fabbrica sarà anche un’immagine “vetero” ma anche quella che ci è stata presentata come alternativa – una società di pure ceto medio, colletti bianchi e lavoratori intellettuali indipendenti, di lavoro sempre più evanescente – comincia a scricchiolare.
La pandemia ha fatto emergere la questione in maniera piuttosto evidente. A un bel momento, per cause di forza maggiore, siamo stati costretti a restare tutti a casa e l’intero tessuto produttivo del paese è entrato in una specie di survival mode garantendo esclusivamente alcuni servizi essenziali – in breve, la filiera alimentare, i servizi sanitari e una serie di settori produttivi secondari ad essi collegati. Da questa necessità è nata anche una distinzione tra quei lavoratori lavoratori che sono essenziali per il mantenimento dell’ordine civile e quelli che non lo sono.
Che cosa è emerso da questa situazione? Che i lavoratori essenziali senza cui la società crollerebbe sono ancora in larga parte, mutatis mutandis, gli eredi diretti di quelli che hanno lottato per lo Statuto dei lavoratori. Fabbriche essenziali per produrre equipaggiamento medico e dispositivi di protezione individuale, personale medico, logistica, lavoratori dell’alimentare e braccianti. Tutti gli altri possono lavorare da casa, o se non possono farlo possono fermarsi: le conseguenze dal punto di vista economico saranno gravi, su questo non c’è dubbio, ma la società rimane in piedi anche senza di loro.
Oggi in pochi stanno celebrando i 50 anni dello Statuto dei lavoratori, ma questo fatto esprime un paradosso: mai come ora il lavoro è stato un tema pressante. Non solo perché, appunto, abbiamo visto che è una cosa molto reale e terra-terra, ma anche perché tutta una serie di diversi temi sono diventati incredibilmente d’attualità: la regolamentazione dello smart working, che fino a ieri era l’eccezione e adesso è diventata la regola per molte categorie di lavoratori; la tutela della salute, inevitabilmente terreno di scontro visto che i lavoratori essenziali che non si sono potuti fermare hanno continuato ad andare al lavoro rischiando la vita; il lavoro nero, che in Italia vale il 12% del PIL e che si manifesta soprattutto in un settore essenziale come la filiera agroalimentare – vedi le polemiche sulla regolarizzazione dei braccianti delle ultime settimane, che nascono dagli allarmi sulla necessità di forza lavoro nei campi in mezzo alla pandemia.
È già piuttosto chiaro che alla pandemia seguirà una grave crisi economica, per cui tutti questi problemi che la pandemia ha fatto emergere non si riuscirà a nasconderli sotto il tappeto tanto presto. Ricordare lo Statuto dei lavoratori è anche ricordare che i lavoratori e il lavoro sono ciò su cui dovrebbe fondarsi la Repubblica italiana e che ogni volta che si proverà a cacciarli dalla porta rientreranno dalla finestra – almeno fino al giorno in cui verremo tutti sostituiti da dei robot.