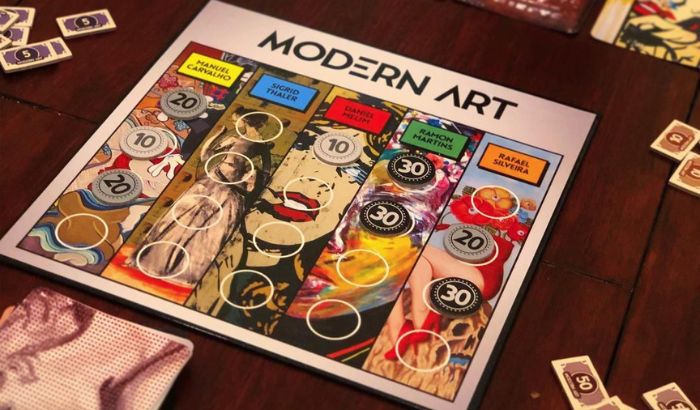Tempo addietro, me ne stavo bel bello sotto il sole ottobrino di Milano Marittima.
Spiaggia deserta, solo gli ombrelloni del Bagno Oasis, sdraio piazzata verso ponente, telo con le diecimila lire, bicchieraccio di Tè Infrè deteinato bello marmato con cannuccetta col ginocchino, testicolo fuori dai boxer in omaggio al Michele Placido di Casotto.
Ero lì che stavo ruminando un pensiero da stronzo. Mi stavo rendendo conto di come a me della collana di libri umoristici che curo non me n’è mai fregato nulla. È servita solo per piazzare degli amici a cui dovevo dei favori. Niccolò Re, giornalista spezzino che mi sdoganò alla sinistra in tempi non sospetti, dipingendogli come un amico quello che si sarebbe rivelato una talpa radioattiva col solo fine di prendere appunti e venderli agli amici della FORCOM (cos’è? Beh, vi assicuro che non volete saperlo). Per non parlare di Gianluca Cincinelli, mio compagno di banco delle superiori, bocciato per colpa mia, ostracizzato nell’Arezzo dei numerari Opus Dei e mio irrisolto Vietnam interiore. I loro libri? Carini, piacevoli, gradevoli come può esserlo un Arbre Magique al pompelmo. Niente di eclatante, quello è certo. Ma è quello che serve a me: sdebitarmi e nel frattempo, se avanza, farmi qualche migliaio di euro scrivendo articoli come questo. Pfui.
Decido di assecondare il rumore bianco della risacca (solo a me ricorda i Queen?) e scivolare nel sonno dei giusti, quando all’improvviso il mio sorriso soddisfatto si piega in una smorfia di consapevolezza e orrore. D’un tratto mi rendo conto che il libro nuovo stava per uscire e non avevo un nuovo progetto da curare. In compenso dovevo pagarmi le stampe di Steven Rhodes per la mia casa nuova. Da lì come un godo alla gola. E subito ansia, palpitazioni, attacchi di tachicardia cardiaca.
Vabbè mi volto dall’altro lato e do le spalle a questi pensieri angoscianti, quando mi vedo arrivare da lontano, passettino dopo passettino, questo omino. Un omarino sulla sessantatreina, con una canottierina bianca con la foto d’una sedia impagliata e una borsa di tela della Brioschi (solo io preferisco la Galeffi?). Un cappellino stile borsalino che gli cala sul suo capino santo. Delle ginocchine un pochino piegate perché camminare sulla sabbia è un lavoro che nemmeno i Transformers. Viene verso di me e, prima che mi si avvicini troppo, gli ringhio: «Chi è lei? Si qualifichi!».
E lui: «Dire che “sono” è una parola grossa… Io al massimo “sarei”, diciamo… Nella fattispecie sarei Ubaldo Berti, un omino sulla sessantatreina del tutto marginale che forse la sta importunando…».
Lo blocco subito: «E codesta cartellina gialla che reca sotto braccio cosa mi rappresenta?».
E lui: «Eeeh… Qua dentro ci sarebbero delle cose che ho scritto nel corso di tutta la mia vita e che sarei onorato di farle leggere… Sono dei racconti, delle storie che ho vissuto, mozziconi di quotidianità… Sono in un’unica copia e se vuole la brucio direttamente… Davvero non vorrei averla disturbata, mi scusi…».
«Decido io se lei mi sta disturbando o no, chiaro? Senti amico, leggimi qualcosa va’».
L’omarino tira fuori dalla cartellina un foglio a protocollo, si mette degli occhiali da vista e inizia a leggermi un racconto su un pellicano malato.
Io nemmeno lo guardo ma, dopo un paio di minuti di lettura, mi accorgo che ho iniziato a battere il piede sul lettino. Ebbene sì, come a tenere il ritmo. E da dietro ai miei Ray-Ban Wayfarer gli faccio: «Ehi ehi ehi ehi ehi ehi ehi amico! Questa è cazzo di dannata buona musica, cazzo!».
E lui, con la voce tremante come un ebreo graziato a Bergen-Belsen: «Dice davvero?».
Mi sporgo verso di lui e con una scoppola gli faccio saltare il cappello: «Ma non montarti la testa eh! Non sei Miles Davis! Solo che io riconosco la roba buona esattamente come fiuto da lontano la merda fumante, cazzo. E tu… Beh amico, tu sei ci sai fare… Ci sai faAaAaAaAare, cazzo… Sei un diamante grezzo eh, un Van Gogh, vai sicuramente forgiato ma questa è fottuta musica per le mie orecchie e a te una bella pubblicazione non te la toglie nessuno!».
E lui, col cappello in mano e gli occhi bassi e lucidi: «Grazie signore, le sono grato… Questo è il giorno più bello della mia vita, mi scusi…». Poi alza lo sguardo e con un sorriso di pace mi chiede: «Posso farle solo una domanda? Spero di non risultare inopportuno ma in caso le chiedo scusa: ha pranzato?».
E io: «Eh no, amico. Sono stato per un’ora sotto pompa d’una tipa, poi mi sono addormentato e la cucina del Touring chiude alle due». «Se non si offende ci penso io», mi dice. Così lo vedo che si fruga nella borsa di tela, dopo lunghi minuti di ricerca tira fuori una mela renetta, la spolvera, me la porge e sorridendomi inoffensivo mi fa: «Tenga, è buona».
L’esito? Gliel’ho ribaltata nel muso.

Detto questo, caro Ubaldo, come ti è venuto di scrivere il tuo primo libro?
L’idea del libro mi è nata quando ho scoperto la tua collana per Visiogeist. Non per piaggeria, è andata così. In precedenza non avevo mai pensato di riunire i miei pezzi ma, siccome sono da sempre un tuo fervente fan – nonostante, a mio modo di vedere, i nostri stili siano piuttosto dissimili –, letta la descrizione del progetto ho pensato che potessero essere in linea e mi sono convinto. Meglio: “in linea” con questa sicumera da scrittorino lo dico oggi, che siedo sgambettando su una pila di copie fresche di tipografia. Tra l’invio della proposta di pubblicazione e la lieta notizia ho passato mesi piegato in due.
Il tuo è un libro caleidoscopico che alla prima lettura mi ha lasciato un piacevole senso di stordimento. A una seconda invece mi sono accorto che i colori dei vari racconti erano come cambiati. Quello che però arriva è spesso molto diverso da quello che parte, me ne accorgo sempre coi miei libri quando li recensiscono. Quindi, invece di sbilanciarmi io, lo chiedo a te: ci parli del tuo libro?
Cerco di stare sul semplice: Uno starnuto fortissimo è a mio giudizio una collezione di testi abbastanza variegati – racconti, sfoghi, poesie, epitaffi, anche un sondaggio – tenuti insieme dal tentativo, spero riuscito, di confezionarli con una scrittura il meno noiosa possibile. In più, il libro ha una prima di copertina splendida – grazie al pittore Marco Pace, straordinario – e una quarta a cui tengo moltissimo, perché dedicata a una persona davvero speciale: Matteo Renzi.
Ho sempre pensato che il desiderio di far ridere gli altri dovrebbe essere curato in psichiatria. Quindi ti chiedo, perché fra tutti proprio un libro comico e non, per esempio, una kenfollettata bella arrogante?
Non sono del tutto d’accordo con te sul fatto che il desiderio di far ridere sia un male. Io se qualcuno mi fa ridere sono – è tautologico, ma è così – contento. Allo stesso tempo lo sono se penso che ad aver fatto ridere qualcuno gli ho alleggerito, anche solo per cinque dieci secondi, l’angoscia che tutti, sotto varie forme, ci si porta addosso. Ma forse tu intendi quelli che pensano soltanto a far ridere, in qualsiasi situazione, e che scappano in ogni modo dalla serietà (no, intendevo la cosa di prima. Bella figura a darmi torto, complimenti, nda). E ancora, dall’altra parte, quelli che ridono in continuazione. Su questa gente convengo con te. L’elemento umoristico però per me è un valore aggiunto, anche e soprattutto nella letteratura. I libri che preferisco hanno sempre qualcosa di buffo. Purtroppo però mi sembra che troppo spesso si tenda, in certi contesti, a ritenere lo humor un fattore squalificante. Che equivale a roba agghiacciante tipo “il liceo classico ti prepara alla vita”. Tornando a me, più che di comico, parlerei di cifra umoristica, una questione di tono. Penso derivi appunto dal desiderio di annoiare il meno possibile, che per me dovrebbe essere sempre priorità di chi scrive, non solo narrativa. Scrivendo questi pezzi, e poi riunendoli, ho tenuto come parametro la mia soglia del tedio, che credo sia piuttosto alta (o bassa, non ho mai capito questa storia delle soglie come dev’essere). Per questo ho cercato di esplorare più forme testuali, anche grazie al tuo sapiente consiglio, l’invito, cioè, all’aggiunta di testi veloci, verticali. Non sento di avere grosse velleità: mi basterebbe non venire a noia tempo dieci pagine e ogni tanto produrre nel lettore, se non una risata, almeno uno sbuffetto o una soffiata forte col naso. Tipo mi dicessero: uno che ride o 25 mila copie a persone serissime? 25 mila copie.
La bellezza del tuo libro è anche, per me, quello di essere composto da racconti cult, dei congegni godibili anche se decontestualizzati. Immagino che se tu chiedessi a chi l’ha letto quali sono i racconti che più ha gradito, le risposte coprirebbero l’intero sommario. Ma lo chiedo a te: quali sono i tuoi racconti preferiti del lotto?
Su tutti, preferisco 180 milioni di sterline, dove cerco vendetta contro Sting e il suo monito scemo secondo cui i genitori non dovrebbero dare soldi ai figli, e Moonlight Shadow, in cui Christian De Sica mi scambia per l’amico Jerry Calà e mi costringe a passare una giornata di montagna con lui. Ma sono affezionato anche a L’attentato, uno dei pezzi più vecchi, che risale a un’epoca – si capisce dal titolo – di lievi attriti tra Occidente e Medio Oriente, o a Ronny, dedicato a un commesso dell’Apple Store, o ancora a Giovanissimo Holden, il racconto di un test di ammissione alla Scuola Holden fallito per una storia di droga di mio fratello. Volendo ti potrei anche dire quali pezzi mi sembrano più deboli, ma da Visiogeist si sono raccomandati tramite PEC di non farlo. Dirò però che uno di questi, addirittura, lo stavo quasi per togliere, quando poi, parlando con Paul McCartney, ho scoperto il concetto di “riempitivo” e allora ho deciso di mantenerlo.
È percepibile nei tuoi racconti un horror vacui costante. Non ci sono momenti di passaggio, di snodo, freddamente burocratici. Le tue storie sono brevi eppure piene di oggetti, facce, dettagli, fegatelli, ragionamenti, punti di fuoco. È una scelta cosciente?
È una scelta consapevole se dipende ancora, come credo, dalla voglia di essere il meno noioso possibile di cui dicevo prima. Riempire i vuoti o, altrimenti, quando non riesco, eliminarli. Stesso discorso per la ricerca del dettaglio: un escamotage per dare brio agli elementi strutturali. Scelta però, come hai notato tu, che deve essere accompagnata a una brevità d’insieme, tanto del singolo racconto che del libro nel suo complesso. In caso contrario sarebbe insostenibile, almeno per le mie capacità.
Un’altra cosa che mi ha colpito del tuo libro è la forte e piacevolmente prepotente percezione della psicologia dell’io narrante di ogni racconto. Paiono interessarti più le voci che le storie. È così?
Sì, senza dubbio. Anche da fruitore, mi interessa il giusto la grande costruzione narrativa. Bravissimi, e li apprezzo, quelli capaci di sfaccettare personaggi inventati, o di costruire intrecci di trame (anche nel breve) sorprendenti, ma io preferisco la curiosità che mi deriva dal leggere una pagina con in trasparenza la psiche di chi l’ha scritta, mi piace cogliere i movimenti di pensiero. Le cose che mi danno più soddisfazione in genere mi fanno scattare la voglia di avere a che fare personalmente con l’autore, per capire da dove siano scaturite le parole che leggo. Anche perché non ritengo che questo imbrigli l’invenzione. Dirò, secondo me è ancora più interessante se l’immaginazione è in qualche modo costretta a un vincolo con la realtà – più o meno sfumata – di chi parla.
Da buon non lettore, immagino che mi sfuggano un sacco di riferimenti letterari e non, che percepisco ci sono (o “ci siano”, non ho tempo di controllare). Quali sono le tue comete?
Non parlerei di riferimenti, perché penso a gente troppo brava. Ma ho alcune fissazioni, persone o cose che mi divertono tanto e sempre. Woody Allen, per dire, libri e film va bene tutto, anche se tra i secondi preferisco sempre quelli dove compare lui; Bo Burnham, per me un gigante vero. Ma anche voci dove lo humor è elemento secondario, per quanto presente e fenomenale, tipo Gianluca Nicoletti (oltre alla radio il suo Libro infame è grandioso), o Mariarosa Mancuso, critica cinematografica straordinaria e, per quanto mi riguarda, formidabile scuola di stile. E poi, alla rinfusa: I Soprano, Rocco Tanica, Fruttero e Lucentini – in particolare l’ultimo Fruttero –, Louie, The Office (quello americano), Monicelli, Seinfeld e Larry David. Chiudo con un nome che ritengo sia ingiustamente poco noto: Giorgio Marchetti, alias Ettore Borzacchini. Fate qualsiasi cosa per leggere uno dei suoi vocabolari, anche se non siete toscani.
Sul The Office americano manco ti commento. Per me non vale niente rispetto a quello inglese. Parliamo d’altro che è meglio: Niccolò Re, l’autore che ha aperto questa collana, ha ricavato dal suo libro uno spettacolo teatrale, che andrà in scena il 4 maggio non in una bettolaccia sieropositiva, ma nientemeno che al Teatro Puccini di Firenze. Hai fatto anche tu un folkloristico “pensierino” in tal senso?
Non ci ho mai pensato, ma credo che alcuni pezzi del libro potrebbero rendere benino ad alta voce. Mi piacerebbe forse di più che li leggessero altre persone, non io, per togliermi la curiosità di sapere che tono e che ritmo verrebbero dati a certi passaggi per me univoci e che invece magari non lo sono.
Bene, direi che è tutto. Ti va di salutare gli amici di Rolling Stone?
Sì, tutti, anche le donne.