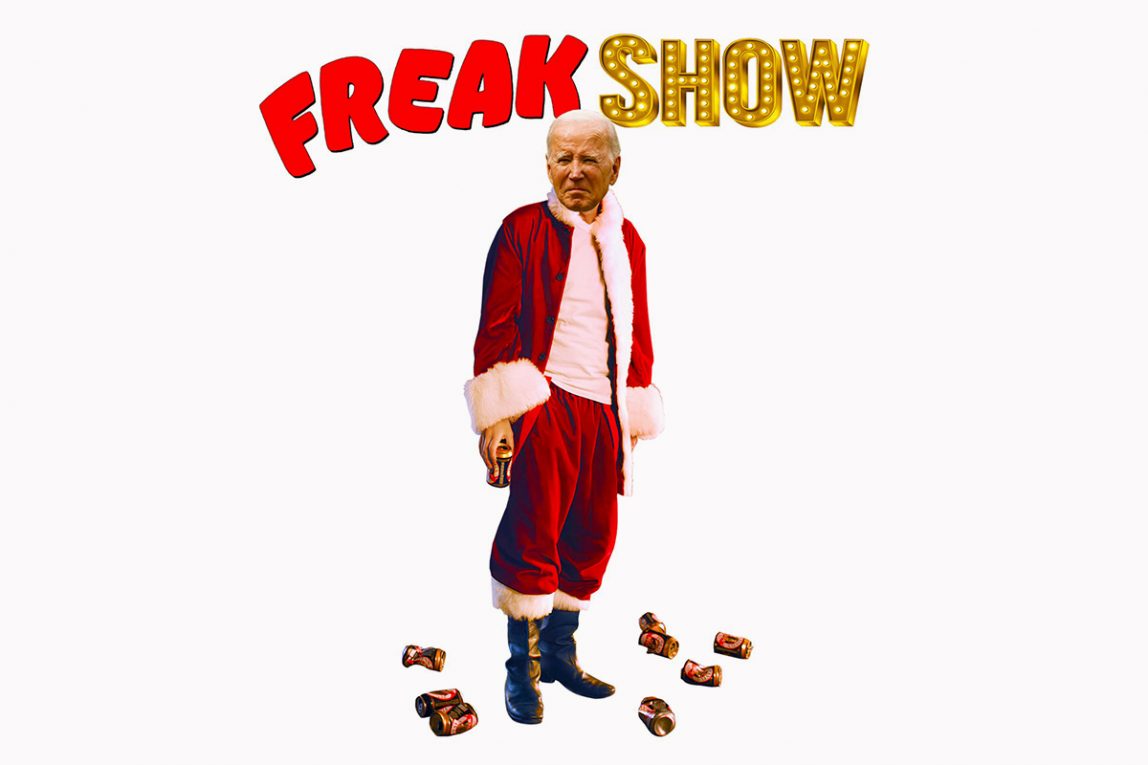Povero Karl Lagerfeld. Lui, in tempi non sospetti, l’aveva predetto: «I pantaloni della tuta sono un segno di sconfitta: avete perso il controllo della vostra vita, se uscite con la tuta». E noi, diligenti, il giorno della sua scomparsa ci eravamo premurati di giurare che no, con la tuta mai e poi mai: caro Kaiser, non ti daremo un simile dispiacere.
Tenere fede all’impegno non è stato facile. Un po’ per l’imperversare di quella cosa chiamata dagli addetti ai lavori (e non solo da loro) athleisure, un po’ per il successo dello streetwear che non accenna a diminuire, un po’ perché Emrata (aka Emily Ratajkowski) ci va in giro per New York, in tuta: se lo fa lei, perché non lo dovrei fare io? Morale: da italiani che si cibano di pane e moda, pure noi abbiamo cominciato ad abbassare le difese, e ci siamo ritrovati sempre più spesso a indossare quel tutone che – da qualsiasi parte lo si guardi – è da americano medio di provincia, quello stesso americano medio di provincia che prendiamo per il culo quando ordina carbonara e cappuccino in tenuta da palestra in un ristorante romano.
Mia nonna sosteneva che la meraviglia s’attacca (tradotto, non meravigliarti troppo di cose che alla fine ti ritroverai a fare anche tu), e così in un certo senso è stato. Escluso un periodo al liceo durante il quale sfoggiavo con fierezza il classico modello Adidas in acetato blu, ché erano gli anni ’90 ed ero innamorata di Damon Albarn, sono stata immune al virus della tuta finché non ho realizzato che, forse, è l’outfit ideale per affrontare un viaggio in aereo. Poi sono diventata freelance, e la tuta si è trasformata nella divisa delle mie giornate casalinghe davanti al computer, accantonata soltanto per uscire di casa. Poi è arrivato il mio cane, e insomma, cosa vuoi, per portarlo fuori mica m’agghindo come se stessi andando a prendere l’aperitivo.
Infine, nella mia vita composta da un 60% di tuta e da un 40% di abbigliamento socialmente accettabile, ha fatto irruzione la quarantena, e le proporzioni si sono invertite. Anzi no, la tuta ha vinto sul resto. In questo kolossal distopico che ci vede protagonisti e che pare Avengers: Infinity War (con l’unica differenza che mancano gli Avengers e che Thanos continua a schioccare le dita ogni giorno), la produzione ha lesinato sui costumi, lasciandoci a disposizione esclusivamente pantaloni in poliestere, leggings in elastan, felpe in pile e panta jazz in cotone elasticizzato.
Alcuni, in principio, si sono ribellati, opponendo una coraggiosa resistenza. Altri hanno accettato il nuovo paradigma fashion con rassegnazione. Altri ancora, l’hanno abbracciato con un preoccupante entusiasmo: ma sai che c’è? Meno sbattimenti, ché già devo preoccuparmi della mia salute e non ho voglia di dannarmi ad abbinare gonne, borse e scarpe. La settimana scorsa, un’amica con cui condivido le gioie dello shopping mi raccontava che – nel tentativo di ritrovare una certa normalità in una situazione completamente anormale – la mattina aveva deciso di vestirsi di tutto punto e di truccarsi («Mari, non ci crederai, ho messo il rossetto!»), pur consapevole di dover rimanere entro le quattro mura domestiche. Non lo nego, rimasi colpita dalla sua forza di volontà: io ormai non ricordo nemmeno più l’ultima volta che ho indossato il reggiseno e passato il mascara sulle ciglia, e due giorni fa ero soddisfattissima di un look composto da leggings vagamente cangianti, calzettoni colorati, Birkenstock e felpa extra-large del mio fidanzato. Povero Karl.
La mia amica comunque s’è arresa, riponendo le proprie velleità nell’armadio in vista dei bei tempi che (si spera) torneranno, e insieme a lei stanno via via cadendo anche i soldati più valorosi. Lo vedo su Instagram: ieri sera mi sono soffermata a lungo sulla foto postata da una conoscente – che ancora non lo sa, ma è uno dei miei personali fari in tema di gusto estetico – constatando che la tuta se l’era portata via. «Oggi così», recitava la caption d’accompagnamento agli inconfondibili pantaloni in acetato abbinati al maglione che mai avresti mostrato ai tuoi follower. Oggi così e domani lo stesso, anzi peggio, avrei voluto aggiungere. Ma chi sono io per levare l’illusione che domani ti vestirai diversamente? Volenti o nolenti, ci siamo tramutati nell’esercito dei 60 milioni di tute, e chissà se, a pandemia conclusa, la nostra metamorfosi kafkiana subirà un arresto o un’ulteriore impennata.
Appartenendo alla categoria di persone che, nel rispetto dei limiti imposti dai vari decreti, è costretta a uscire (il cane di cui sopra, ricordate?), con cadenza quotidiana mi rendo conto che la mia non è affatto un’esagerazione. Ogni persona che incrocio per strada a un metro di distanza da me è in tuta, indipendentemente dall’età, dall’estrazione sociale, dall’etnia. Ci guardiamo con sospetto, gli occhi indugiano sul volto, scivolano lungo il cappotto, scorgono il cane al guinzaglio («Ok, hai la giustificazione») e quando s’abbassano raggiungendo i pantaloni e le scarpe danno uno sfuggente e consolatorio cenno d’assenso. Siamo membri del medesimo club, tu signora con la tuta in velour blu cobalto comprata in Rinascente, io con i leggings a vita alta un po’ a zampa perfetti per il pilates, tu ragazzotto zarro con quell’elastico alla caviglia che scommetto ti fa sentire proprio un trapper. Abbiamo insomma scoperto che la tuta è la quintessenza della comodità, che durante eventi eccezionali è socialmente ammissibile, che è democratica.
Per ora, oltretutto, quello con i suoi tessuti avvolgenti che non stringono mai troppo è uno dei pochissimi abbracci che possiamo concederci senza correre alcun rischio, il che costituisce un ulteriore punto a favore. La domanda sorge spontanea: riusciremo in un futuro prossimo a farne a meno? I teorici del costume e della moda inorridirebbero, ovvio che sì, sei matta? Ma di fronte alle quantità di cibo ingurgitate in quarantena e alla contravvenzione del principio alla base di ogni dieta – fare del moto –, le mie certezze traballano. Magari la tuta diventerà il refugium peccatorum per eccellenza, dove ci rintaneremo per mascherare gli stravizi contratti durante la reclusione forzata, la prova schiacciante della perdita di controllo sulle nostre vite. E lì ci torneranno in mente le parole del buon vecchio Karl. Te l’avevamo promesso, Kaiser: riuscirai mai a perdonarci?