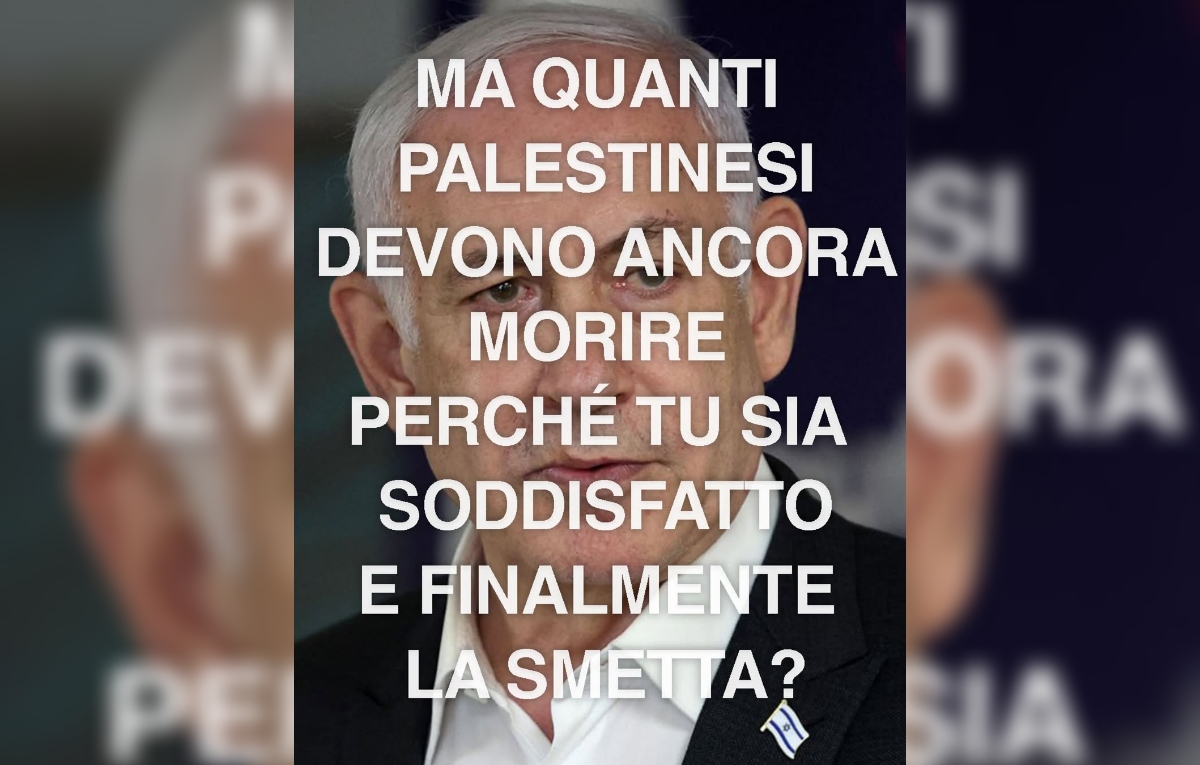Se la sceneggiatura di Sylvester Stallone fosse rimasta nella sua versione originale – Rocky si ritira dall’incontro con il campione Apollo Creed per fuggire dal mondo cattivo della boxe – nessuna statua di Rocky sarebbe mai stata eretta, nessun Rocky Day immaginato, nessun Rocky Fest organizzato. «Non ci sono mai stati assembramenti attorno a un disilluso», scriveva un vecchio europeo.
E invece questo anonimo pugile italoamericano delle periferie di Filadelfia resta in piedi fino alla quindicesima ripresa contro il campione in carica dei pesi massimi e così oggi, a quarantotto anni dall’uscita al cinema (3 dicembre 1976), per festeggiare il secondo Rocky Day e inaugurare il primo Rocky Fest hanno posato una statua del personaggio sulla vetta della scalinata del Philadelphia Museum Of Art, gli stessi settantadue gradini risaliti di corsa da Stallone in una scena del film. Sul piedistallo della scultura di bronzo è riportata una citazione: “It’s not how hard you hit. It’s how hard you can get hit and keep moving forward. That’s how winning is done” (“Non è quanto forte riesci a colpire. È quanto forte riesci a farti colpire mentre continui ad andare avanti. Ecco come si vince”).
Rocky ha incarnato decenni fa un ideale reso oggi dal fastidioso e abusato termine di resilienza. Se sai sopportare abbastanza a lungo, prima o poi l’occasione ti capita. Il campione Apollo (già nel nome una divinità pagana) per celebrare i due secoli dalla fondazione degli Stati Uniti mette in palio il titolo a Filadelfia. Il contendente che avrebbe dovuto sfidarlo si infortuna, e allora Apollo decide di dare una chance a un pugile pescato a caso dalle più maleodoranti palestre cittadine, come vuole la mitologia del sogno americano. Apollo passa in rassegna molti dei loro nomi insignificanti, finché non rimane colpito da questo tal Rocky Balboa per il modo in cui si fa chiamare: “The Italian Stallion”.

Foto: Philadelphia Convention & Visitors Bureau
Primo insegnamento di questa storia, e temo l’unico: scegliete uno pseudonimo memorabile, osate esplicitazioni tipo il “missile lucano” o allusioni tipo “virtù abruzzese” – come la zuppa con pancetta che servono al Gran Caffè L’Aquila, un’altra istituzione italoamericana di Filadelfia. Apollo mette in palio il titolo a Filadelfia perché, il 4 luglio 1776, è stata ratificata la Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti dal Regno di Gran Bretagna proprio qui, nella Indipendence Hall. Oggi, all’interno di questo edificio di mattoni rossi su Chestnut Street, una guida svelta e preparata, per spiegare come si è arrivati a un atto politico del genere, deve parlare venti minuti e srotolare documenti ingialliti davanti ai tavoli del congresso con tanto di calamai e volumi polverosi, e modulare frasi complesse come “perché liberarsi dalla tirannia del potere è un diritto sancito già dalla Magna Charta”, e deve azzardare termini come “Illuminismo” e perfino come “eudaimonia”.
Ma il pop, un’invenzione squisitamente americana, è l’epica a portata di distrazione: per correre sulla scalinata, culmine dell’allenamento che lo trasforma da bullo di periferia in potenziale eroe (la sua personale dichiarazione d’indipendenza), Rocky ci mette appena otto secondi. Segue un’esultanza a saltelli e braccia alte in un’alba premonitrice al di sopra della statua equestre di George Washington. Ancora adesso questa statua, di una solennità imperiale, si staglia al termine del Benjamin Franklin Park Way, un viale alberato e bordato dalle bandiere delle nazioni del mondo.
Attorno alla scultura del padre della patria danzano foglie secche di quercia, agitate dal vento atlantico, senza incontrare l’ostacolo di una singola scarpa. Mentre al di sopra della scultura di Rocky garrisce una bandiera americana e, attorno, danzano stelle filanti colorate. Le hanno sparate con piccoli cannoni portatili al momento di svelare la scultura (che in realtà l’artista Thomas Schomberg realizzò nel 1983 per Rocky 3 e che fino a oggi si trovava altrove) mentre una folla di bambini risaliva di corsa le scale sulle note del tema di Rocky. Insieme ai bambini, gli adulti, e gente di ogni età e provenienza, e gente con cappellini di Rocky e felpe di Rocky e piumini di Rocky (i loghi che stilizzano il pugile hanno sempre almeno un pugno alzato), tutti si radunano a ridosso del piedistallo e imitano la posa della statua, con le braccia al cielo in segno di trionfo.

Foto: Philadelphia Convention & Visitors Bureau
Il Rocky Fest durerà l’intero dicembre: quello ai piedi della statua promette di essere il metro quadrato terrestre in cui verranno più allenati i tricipiti della nostra specie. Oltre a quello di Franklin, a portata di sguardo ci sono almeno un altro paio di monumenti dedicati a figure storiche e padri della patria. Nei loro paraggi, il deserto. Il confronto tra queste opere e la statua di Rocky ricorda il finale di The Doors: nel cimitero di Père Lachaise, una panoramica tra le tombe spoglie di Chopin, Balzac, Proust, Rossini, e poi, in un tripudio di fiori e candele e graffiti e bottiglie – la tomba di Jim Morrison.
Durante la cerimonia di inaugurazione, dal pulpito naturalmente montato accanto alla statua, la direttrice del Visitor Center di Filadelfia, Kathryne Lovell, dice: “Questa città, la sesta per popolazione degli Stati Uniti, con la sua tradizione operaia di acciaierie e fonderie, è il cuore e l’anima della storia di Rocky, simbolo della determinazione e della perseveranza”. Lo scultore che ha creato l’opera, Schomberg, un signore attempato e affabile con un codino bianco sulla nuca e una lattina di Sprite in mano, dice che Stallone ha mostrato come sia meglio combattere e perdere piuttosto che non combattere affatto. “Le persone non vengono qui per la mia opera, né per Stallone”, dice. “Le persone vengono qui per un simbolo. La statua, nonostante il trionfo contro il fato, non fissa il suo orizzonte di gloria ma ha lo sguardo rivolto verso il basso, per connettersi con loro”.
Tutte le figure istituzionali che poi si avvicendano al microfono iniziano i discorsi, l’aria assolutamente seriosa, con queste parole: “Happy Rocky Day!”
Sotto la scala, ecco il Rocky Shop. Vendono pupazzi di Apollo Creed, Ivan Drago, Mr. T, l’accappatoio giallo con la scritta sulla schiena “Italian Stallion”, una cintura da campione dei pesi massimi tempestata di santini di Rocky e Adriana per 285 dollari, babydoll per bambini con adagi motivazionali sul petto: “Win! Rocky! Win!”
Di fianco al negozio temporaneo, una statua gemella di quella sulla cima. È al suo cospetto che il 4 dicembre è stata svelata un’ulteriore opera: un’artista di Filadelfia, Ash Ryan, per il Rocky Fest ha realizzato quattro murales. Sono i ritratti in primo piano, dai colori accesi e dagli sguardi ispirati, di quattro “real life Rockys” scelti tra i cittadini, quattro storie che riproducono i valori di determinazione e perseveranza immortalati dal film: chi è una nuotatrice paralimpica, chi taglia i capelli ai clochard, chi ha perso un fratello per un colpo di pistola.

Foto: Philadelphia Convention & Visitors Bureau
Il fatto che anche Stallone sia stato un “real life Rocky”, con il forcipe che gli procura una paresi facciale appena nato e con un padre pessimo e con i forsennati tentativi di uscire dalla miseria, rende l’epopea di Rocky un’autobiografia trasfigurata, perfetta per un’epoca di diari pubblici e memoir agiografici, dove autore, narratore, protagonista e fruitore tendono a diventare tutt’uno – la mistica del selfie.
Nel capannone del Cherry Street Pier, sulla riva del fiume Delaware, nell’ambito del festival si tiene il “pet-friendly happy hour” dedicato a Butkus, il bullmastiff di Rocky. Oltre a quelli di Ivan Drago e di Apollo Creed, qui vendono in esclusiva il pupazzo del cane. Davanti al cartonato di Rocky che lo abbraccia, scodinzola il cosplay di Butkus, addestrato ad accucciarsi nella posa del suo sosia cartonato. Animali senza padrone sfoggiano un cappottino provvisto di cappuccio grigio, un adattamento canino della felpa con cui Rocky si allena sulla scalinata, come cosplay – biologicamente discutibili – dello stesso Rocky. Dei volontari li portano al guinzaglio nella speranza che vengano adottati da qualche visitatore, anche i randagi in attesa di realizzare il proprio piccolo sogno americano, di compiere la biografia del proprio riscatto.
E perfino una statua può avere una biografia. “Ho registrato un podcast chiamato Biography of the Rocky Statue, ma non è solo la biografia di un oggetto di bronzo, è la biografia della potenza di una storia: per questo quattro milioni di visitatori vengono ogni anno a vedere la scultura ai piedi della scala”, dice il professor Paul Farber dell’università della Pennsylvania, con un dottorato di ricerca in cultura americana. È seduto a un tavolo del The Victor Café, locale italiano allo stesso civico di Dickinson Street in cui, nella saga di Rocky, si trova il ristorante Adrian’s, chiamato così in onore della musa capace di ispirare i jab di Balboa.
Farber, con il suo Tosca (un involtino di pollo, prosciutto e fontina) nel piatto, davanti a un dipinto psichedelico di Rocky che combatte, aspetta che una signora afroamericana finisca di cantare O mio babbino caro tra i tavoli, e poi riprende: “La gente non sa un sacco di cose su Rocky e sulla sua statua, come che ne esiste una copia addirittura in Serbia. Conosco un ragazzo scappato dall’Afghanistan dei talebani che ha scelto di stabilirsi a Filadelfia giusto per Rocky. Svariati turisti cinesi acquistano al museo d’arte o su rockystatue.com una riproduzione ufficiale della statua di Rocky alta poche decine di centimetri, se la portano in giro e mandano a Schomberg foto della statuetta sulla Grande Muraglia o sul Bund di Shanghai. Certe persone mi assicurano di considerare Rocky un essere umano in carne e ossa, altre che la prima cosa che faranno una volta guarite dal cancro sarà scalare quei settantadue gradini”. La statua di Rocky come reliquia, San Gennaro anabolizzato.
Magari non più in carne, ma a quanto pare molti credono che pure Adriana esista in ossa. È nel cimitero di Laurel Hill che nella saga si trova la sua tomba, e qui si trova anche nella realtà: sopra la lapide, che riporta le date di nascita e di morte della moglie del protagonista (1950-2002), è posato un mazzo di rose rosse, coerentemente finte. Quella alla tomba di Adriana è una delle tappe in cui si articola il Rocky Philadelphia Bus Tour. Secondo la guida, il motivo per cui malgrado l’amore del pubblico il personaggio sia stato fatto morire tra Rocky 5 e Rocky Balboa è: “Obbligare il protagonista a uscire dalla sua comfort zone”.
Il tour si snoda tra il negozio di animali dove lavora Adriana nella scena di apertura di Rocky, nella periferia nord di Filadelfia, all’ombra della ferrovia sopraelevata; il più grande murale del mondo che rappresenta una bandiera americana, il punto da cui Rocky parte con la sua corsa; The Italian Market, tra cannoli e salsicce, dove Rocky si nutre. I commercianti di questa zona tramandano una leggenda. Il fruttivendolo di nome Chuckie che lancia l’arancia al pugile, all’urlo di “Ehi, Rocky!”, durante la solita corsa, è stato risarcito attraverso questi tre secondi di popolarità del danno procurato dal furgone delle riprese, che gli aveva impallato l’attività per più di un’ora.
Tra le tappe la guida, a ogni curva accarezzata dai guantoni e dall’accappatoio di Rocky che pendono dal telaio del bus, continua a raccontare curiosità in tema. Dice che se davvero Rocky avesse corso per tutte le strade mostrate nel suo allenamento, avrebbe macinato più di trenta miglia. Dice che Stallone, per prendere a pugni quarti di bue surgelati, si è ispirato al vero campione Joe Frazier che in effetti, qui a Filadelfia, si preparava agli incontri così. Dice che Bulkus era davvero il cane di Stallone, che ha dovuto venderlo per quaranta dollari in modo da comprarsi da mangiare: quando poi ha venduto anche la sceneggiatura di Rocky, ha potuto ricomprarselo. Per chiudere con una morale gli aneddoti che snocciola, la guida ripete spesso: “keep pushing for what you want”, “believe in what you want”.
In fondo Stallone, oltre a essere l’autore e il protagonista, è anche il messaggio della storia. E il messaggio è questo: gli americani credano davvero che la realizzazione dei loro desideri possa salvarli – un privilegio che noi abbiamo perso da qualche secolo.