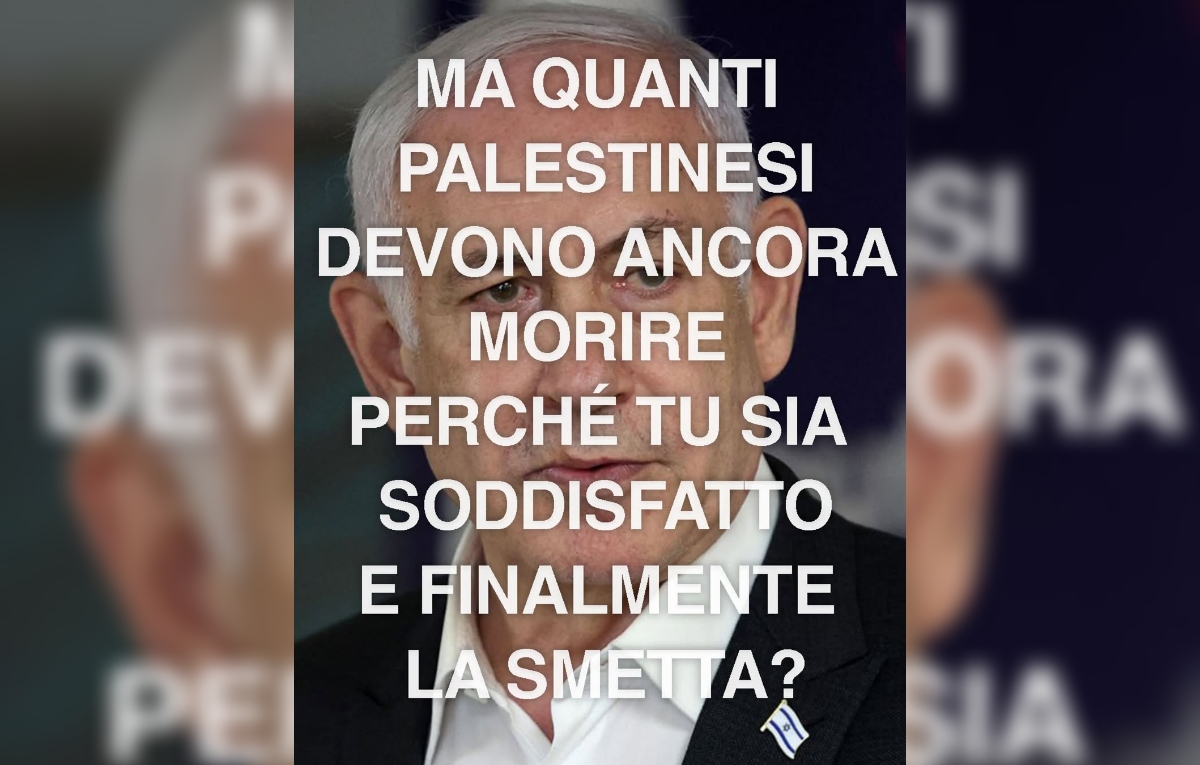Da anni sentiamo ripetere che questa è l’era dei podcast. Quello che un tempo era un fenomeno (e un consumo) di nicchia, si è ritagliato uno spazio non indifferente nella giornata di un numero sempre crescente di ascoltatori. Tra loro ci sono molti vecchi aficionados della radio, ma anche un numero molto consistente di “nativi podcastiani”, cioè persone che – per ragioni cronologiche o di gusti personali – la radio non l’hanno (quasi) mai ascoltata e sono convinte che questa “nuova” tecnologia di prodotti audio on demand abbia soppiantato in toto la radio di una volta che, di conseguenza, non avrebbe più ragione di esistere.
In queste righe, quindi, non voglio indossare gli improbabili panni di un luddista e dire peste e corna dei podcast. Voglio solo invitare a riflettere quella fetta di pubblico convinta che la “vecchia” radio non abbia più senso.
Partiamo da un dato di fatto incontrovertibile: se c’è un medium che ha cambiato la storia della musica è senza dubbio la radio. E non la radio in generale, ma quella free-form. Cosa si intende per radio free-form? Semplice, è la radio libera dalla dittatura della playlist, quella nella quale il dj sceglie non solo la musica, ma la linea editoriale del programma che, idealmente, non è mai fissa ma dettata dalle circostanze del momento. È nella prateria senza regole del free-form che le proposte culturali, musicali e di intrattenimento più innovative e significative degli ultimi decenni possono galoppare felici. Ed è proprio attraverso la radio free-form che sono riuscite a emergere dal buio dell’underground e a imporsi nel mainstream, bypassando la corsa a ostacoli dei media tradizionali.
Fin dal secondo dopoguerra tutta la miglior radio era free-form: dai programmi di John Peel sulla BBC alle radio pirata che hanno portato la controcultura alle orecchie del cittadino insoddisfatto dall’offerta del mercato. Il primo prototipo di radio free-form prende corpo già nel 1949 in California, su iniziativa di un gruppo di obiettori di coscienza e pacifisti: Pacifica Foundation, un piccolo network che controllava un pugno di stazioni radiofoniche apertamente progressiste (la prima sarà la KPFA di Berkeley, alla quale negli anni si aggiungeranno molte altre affiliate). Uno dei programmi che hanno inaugurato questa stagione di libertà è Night Sounds di John Leonard, nel quale trovano voce i poeti della Beat generation come Allen Ginsberg, Gregory Corso, Lawrence Ferlinghetti e Jack Kerouac. Negli anni Sessanta, dalla West Coast la free-form mania sbarca a New York con la WBAI e, in particolare, Radio Unnameable di Bob Fass, che diventa un crocevia per tutto quello che è controcultura: dalle proteste contro la guerra in Vietnam alle sperimentazioni psichedeliche di Timothy Leary, fino a creare vere e proprie tavole rotonde con il pubblico, grazie a un apparecchio che gli permetteva di dialogare in diretta e contemporaneamente con dieci ascoltatori al telefono: un dettaglio che dimostra come la radio free-form non fa avanzare solo il linguaggio radiofonico ma anche la tecnologia legata al medium. Sempre a New York e sempre negli anni Sessanta emerge anche una versione più disimpegnata del free-form, tutta concentrata sulla musica, grazie al dj Murray the K, che contrariamente ai suoi colleghi non fa sentire singoli, ma dischi interi (una cosa folle allora, figuriamoci al giorno d’oggi), intervistando i nomi di spicco della nuova scena folk-rock, da Janis Ian a Bob Dylan, del quale sarà uno strenuo difensore durante la sua (allora) criticatissima svolta elettrica post Newport Folk Festival.
La nobile tradizione americana del free-form resiste ancora oggi anche grazie all’emittente WFMU del New Jersey, che dagli anni Novanta manda in onda Strength Through Failure, le playlist curate da Fabio, un dj istintivamente curioso e onnivoro, un vero kamikaze dell’indipendenza a tutti i costi, un ricercatore sonoro che da anni fotografa quanto di più sorprendente ci sia nella musica d’avanguardia, senza però mai flirtare con la classica contemporanea o qualsiasi altra cosi puzzi di accademia. Fabio è un dj geneticamente free-form: l’unico modo per conoscere in anteprima cosa manderà in onda (e quando lo farà) è andare a trovarlo nel suo negozio di dischi, l’Earwax Records a Brooklyn, e fermarsi a chiacchierare con lui. E, anche in quel caso, non è detto che siate in grado di cogliere la logica che si cela dietro i suoi accostamenti: di puntata in puntata (se non nel corso dello stesso episodio) potete ascoltare una conversazione sul krautrock, riflessioni sulla letteratura mistika russa e un’approfondita analisi sui problemi dell’equitazione.
L’unica cosa che accomuna le puntate, come dice il nome del programma, è il tema del fallimento, argomento non casuale perché WFMU è costantemente impegnata in campagne di fundraising per restare faticosamente a galla. Ragione per cui dobbiamo chiederci: come mai i dj che sanno fare il proprio mestiere insistono per tenere in vita la radio free-form nonostante sia un modello economicamente rischioso? Eppure, stando a quello che dicono Jordan Peterson e Joe Rogan (i Gilbert & George della radio on demand), l’avvento dei podcast è una rivoluzione paragonabile alla stampa a caratteri mobili di Johannes Gutenberg: perché, quindi, abbiamo ancora bisogno della radio free-form trasmessa in diretta?
Perché, come dimostra Steven Van Zandt, il poliedrico chitarrista di Bruce Springsteen (passato alla storia della tv come Silvio dei Soprano), la radio free-form può anche rivelarsi un investimento molto redditizio. Dal 2002, infatti, Van Zandt porta avanti il programma Little Steven’s Underground Garage, due ore settimanali in cui su possono sentire le sue chiacchierate con musicisti storici ed emergenti o ascoltare band che vanno dai Sonics ai Reigning Sound. Nato quasi come un esperimento, il potenziale di Underground Garage è stato rapidamente intercettato da Sirius XM, il broadcaster che l’ha acquisito nel 2003. Oggi il programma si può ascoltare non solo in tutti gli Stati Uniti, ma anche da oltre venti stazioni radio in giro per il mondo, incluse tre italiane (Radio Città Futura, Radio Flash 97.6 e Radio Lombardia). Una ventennale storia di successo, soprattutto se messa al confronto con Renegades, il faraonico podcast di Obama e Springsteen, otto puntate in cui il Boss e l’ex presidente dispensano lezioni di noia e buon senso: un progetto molto costoso e con un grande lancio mediatico, grazie al quale si sono messe in fila circa otto ore di chiacchiere che sono sparite nell’etere senza lasciare alcuna traccia.
I podcast possono veicolare una enorme e variegata quantità di informazioni e contenuti, anche musicali, ma hanno un difetto: la loro è una fruizione “senza tempo” come potrebbe essere quella di un romanzo. E a furia di essere fruito in un momento a nostro piacere, il podcast stesso finisce per essere concepito dai suoi creatori (e non solo percepito dai suoi ascoltatori) come un contenuto slegato dal tempo. In poche parole, quando realizzi un podcast (e posso dirlo per esperienza personale) devi sempre tener presente che quello che dici deve avere un valore assoluto, comprensibile oggi pomeriggio come tra quattro anni. Certo, non è detto che tu sia in grado di farlo, ma l’ambizione è quella fin dal concepimento: creare una cosa che duri nel tempo proprio perché non c’è un momento preciso in cui sarà fruita. E questa folle ambizione di “eterna validità” impone ai creativi dei limiti facili da immaginare.
Al contrario, la trasmissione live di un programma free-form è quanto di più temporaneo ci possa essere, e non solo perché la diretta è di per sé una morte annunciata (il programma svanisce appena termina), ma soprattutto perché nel free-form non resta nulla: a “morire” non è solo una specifica puntata, ma anche l’idea stessa della trasmissione. Non basandosi su una scaletta replicabile o su un format, la radio free-form non si può ingabbiare, archiviare e riascoltare anni dopo come se niente fosse. Certo, puoi riascoltarla (gran parte delle playlist di Fabio sono archiviate e disponibili on-line). Ma ogni volta che lo farai, ti troverai difronte a un qualcosa di diverso, perché il momento storico in cui la ascolterai farà la differenza. Come dimostra la storia di Louie Louie, un pezzo che fin dalla fine degli anni Settanta viene è considerato l’inno nazionale del rock’n’roll. Nel 1957, quando Richard Berry lo pubblica per la prima volta, il pezzo non ottiene particolare successo, ma quando nel 1963 i Kingsmen ne fanno una cover, il pezzo traccia una linea di demarcazione tra un prima e un dopo nella storia del rock, aprendo la strada – tra le altre cose – al punk e a tutto quello che sarebbe venuto dopo.
Nella storia della musica, l’esempio migliore per comprendere come un contenuto cambia valore a seconda del tempo in cui lo si ripesca ce lo offre la new-wave, in particolare nel suo modo innovativo di affrontare le cover. In un suo articolo del 2017 per il New Yorker, il giornalista Ray Padgett (autore del blog e del libro Cover Me), ha raccolto le riflessioni di Mark Mothersbaugh dei Devo sulla loro versione del 1978 di Satisfaction: non si trattava di un omaggio ai Rolling Stones, quanto di una “correzione” del brano originale, che risaliva al 1965, per adattarlo alla loro concezione dei tempi, tempi in cui la società si era de-evoluta non solo sotto l’aspetto ideologico e artistico, ma anche per quanto riguarda “l’orecchio” che uno ha per la musica. E la stessa cosa si potrebbe dire per Hey Jude dei Beatles (1968) coverizzata dai Residents, da alcuni considerati il primo gruppo new-wave, nel 1976. Sul finire degli anni Settanta, gli ascoltatori sono molto diversi dai loro avi dei Sixties: i loro timpani sono sempre meno predisposti a decodificare Schoenberg, perché si stanno preparando ad accogliere fenomeni che negli anni Novanta arriveranno a spazzare via ogni forma di complessità, come i Vengaboys.
Se Charles Dickens volesse turbare i sogni degli Ebenezer Scrooge che oggi controllano i conglomerati dei media, non scomoderebbe i tre Spiriti del Natale (Passato, Presente e Futuro), ma lo Spirito dei Duran Duran. La parabola delle varie reincarnazioni delle loro hit, infatti, potrebbe far capire anche ai potentati radiofonici più ottusi che un brano musicale, se affidato ai dj sostenitori del free-form, può rendere (e durare) molto più del previsto. Per esempio, trasmettere Hungry Like the Wolf nel 1982, cioè quando uscì la prima volta, era una scelta commercialmente e musicalmente accorta: un pezzo di grande successo che catturava il momento. Nel 1995, le Hole ne fecero una cover per MTV Unplugged. In quegli anni il rock era spesso manieristicamente serio, quindi la scelta di Courtney Love era chiaramente comica e provocatoria. Da quel momento, le radio ripresero a mandare i brani dei Duran Duran, perché all’improvviso la loro musica aveva un che di liberatorio: una presa in giro al maschilismo diffuso tra le rock star. E oggi che il rock è morto da una quindicina d’anni e si prepara (forse) all’ennesima resurrezione, un dj che manda Hungry Like the Wolf non lo fa più per accortezza o per ironia: lo fa perché è un professionista serio, mosso da un intento storiografico, quasi pedagogico. La stessa canzone, grazie alla fluidità e alla ricettività della radio free-form, diventa un successo per tre volte (e chissà per quante altre ancora) e con tre significati diversi: nasce come fenomeno commerciale, si trasforma in reazione ironica, per poi diventare un pezzo di storia.
Se inizialmente la radio free-form doveva combattere contro la cultura consumista giovanile, offrendo come controproposte contenuti che la radio tradizionale non avrebbe mai offerto, oggi il suo nemico principale è essenzialmente il suo costo. La radio della heavy rotation, infatti, si presenta sotto le mentite spoglie della “convenienza”: costa poco e garantisce guadagni su breve termine. Ma sul lungo termine la convenienza ha i suoi effetti collaterali, perché per risparmiare e rendere tutto replicabile si semplifica. Format e semplificazione sono le nemesi della creatività e di conseguenza – cosa che gli editori dei media dovrebbero sapere – anche della ricchezza.
Non voglio dilungarmi sul potere creativo del dispendio di risorse: le meraviglie dello spreco sono un tema a me caro, ma ne parlerò in un altro articolo. In queste righe voglio ribadire che il rischio d’impresa della radio free-form è solo apparente. Anzi, è proprio grazie alla programmazione free-form che BBC Radio è riuscita a rilanciare alcuni dei propri canali ormai dati per spacciati.
I primi anni del 2000 sono stati un momento cruciale. Nel 2004, infatti, muore John Peel e comincia a diffondersi Facebook. Con Peel spariscono i ragazzini che si chiudevano in cameretta ad ascoltare new wave, rimpiazzati da giovani che, grazie ai social, si sono illusi di non essere più soli. Quindi fuori Robert Smith e dentro Beyoncé. La tecnologia non è più al servizio dell’essere umano: non è più relegata in cucina, a fare i lavori sporchi che non vogliamo più fare, ma siede tra noi, spesso a capotavola. La tecnologia diventa una forza in grado di definirci: come dice l’artista multimediale e post-internet Cory Arcangel, se prima ci distinguevamo in base alla T-shirt che indossavamo (c’è chi portava quella degli Hawkwind e chi quella dei New York Dolls), oggi ci distinguiamo in base alla marca e al modello dei nostri smartphone.
Ed è proprio in quella fase storica che gli inglesi, popolo che dà il meglio di sé quando ha le spalle al muro, hanno lanciato e “ristrutturato” delle emittenti radiofoniche per farle diventare “palchi” e contemporaneamente “catalizzatori” della musica urban che da decenni viveva nei sobborghi di Londra: e non parlo solo di BBC Radio 1XTRA, ma anche di quella galassia di radio pirata che in quel periodo ottengono le licenze. Da quel momento, le radio inglesi più attente hanno cominciato a prendere sul serio dei generi musicali ai quali il mainstream non dedicava spazio. E improvvisamente le loro trasmissioni live sono diventate ambite dai giovani musicisti grime, che finalmente avevano una cassa di risonanza per la propria musica. E insieme alla “novità” del grime, sono tornate a galla dei generi musicali che – stando alla percezione dei dj schiavi della heavy rotation – sembravano defunti dagli anni Novanta (jungle, drum and bass…): un fiorire di sonorità vecchie e nuove che ha permesso a una certa tipologia di musica black – che non aveva realmente beneficiato del fenomeno Cool Britannia – di diventare ufficialmente rilevante non solo in una prospettiva culturale, ma anche e soprattutto da un punto di vista economico.
La radio free-form, in conclusione, può fotografare un fenomeno in divenire, può afferrare qualcosa che sta accadendo e, nei casi migliori, può restituirne l’autenticità e l’immediatezza, fino a trasformare una realtà sotterranea in un fenomeno di grande successo. Il podcast, invece, non può far altro che commentare un contenuto preesistente e già decodificato. Per quanto possa essere divertente farli e ascoltarli, non è grazie ai podcast che scopriremo la musica di domani o le economie di scala che ne derivano. Se il free-form è il new journalism di Truman Capote, il podcast è un manoscritto di Bernardo di Chiaravalle.