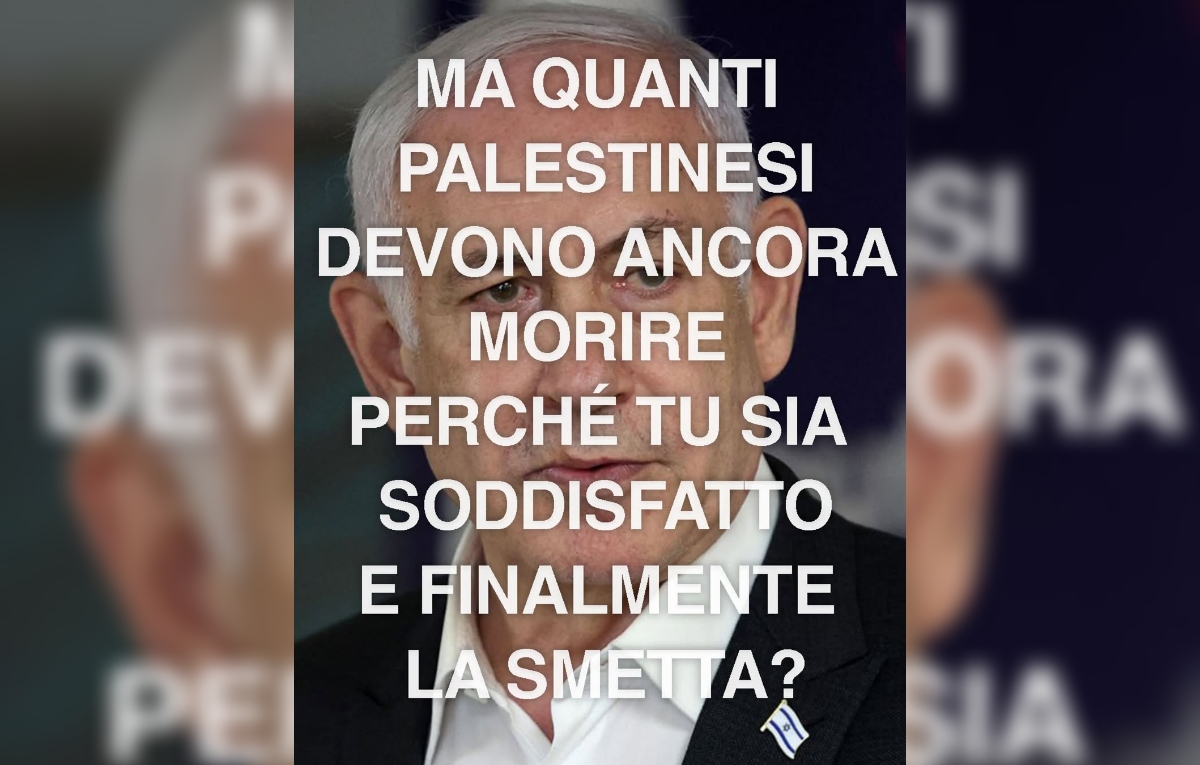Le fratture storiche sono una delle cose che mi mette più allegria. È surreale vedere come cambiano, nel corso del tempo, le percezioni e i comportamenti del cittadino davanti a un determinato fenomeno o prodotto. Per esempio, una buona analogia per provare a comprendere il mondo dell’intrattenimento è sempre stata quella dell’industria della carne. In quest’ottica, da che mondo è mondo, il macellaio è il produttore (che poi è il vero autore di tutti i prodotti culturali che vi piacciono tanto) e il consumatore – ovviamente – lo spettatore. Ma chi è la materia prima? Chi è la carne? In altri tempi sarebbe stato più semplice rispondere: la carne sono gli attori e, più in genere, i corpi che si offrono al giudizio del pubblico. Oggi, invece, il ruolo della carne è più difficile da assegnare, perché ci sono sempre più attori o musicisti “manzi” che diventano produttori. E quindi anche il granitico manzo di un tempo si è evoluto in una figura più sfuggente: mentre in veste di producer dà forma ai contenuti, continua a recitare per non rinunciare al suo ruolo di “carne da macello”.
Un tempo, nelle campagne del nostro Bel Paese, il pollo arrivava tubante e minorenne nelle cucine più agresti e, dopo una tirata di collo, andava consumato entro ventiquattr’ore. Questo breve excursus bucolico ci permette non solo di sottolineare una grande frattura storica (quella che ha reso più appetibile agli occhi dello spettatore una valdostana ottenuta ossigenando una crema di becco di pollo rispetto al povero pollo), ma anche di capire quale ruolo interpreta un attore/produttore come Channing Tatum nella metafora dell’industria della carne: il manzo produttore è un pollo che entra nella cucina di nostra nonna e, ispirato dall’arte di Maurizio Cattelan, s’impicca.
E sempre in tema di fratture storiche e valdostane, c’è da dire che anche la storia di noi galline omosessuali è attraversata da dei radicali cambi di paradigma: dall’antica Grecia all’ascesa di Roma, dal libertinaggio all’oscurantismo, da Una giornata particolare a Stonewall, dall’arte di durante l’incubo dell’Aids fino all’ecumenismo di Sam Smith: uno che si identifica con i pronomi they/them e fa una musica che puoi ascoltare nelle playlist mattutine dei supermercati brianzoli. Ma del fatto che siamo passati dagli scontri con la polizia durante i White Nights riots di San Francisco a collezionare passeggini ne ho parlato in mille occasioni. Stavolta, come una novella Jane Goodall, voglio vestire i panni dell’etologo queer e immergermi in una subcultura tanto affascinante quanto lontana da me: quella del maschio alfa eterosessuale, soprattutto bianco, aggressivo e cardiopatico, come quei sublimi esemplari che passano il capodanno a Gstaad. E per farlo, mi sarà utile passare in rassegna l’evoluzione storica di questa figura mitologica dall’oleografia ormai sbiadita: dal bruto poligamo e carnivoro della preistoria fino alla sua attuale fase di decennale declino psicofisico e conseguente irrilevanza politica.
Nei quattro volumi della sua monumentale Storia della sessualità, Michel Foucault ha spiegato quanto sia cambiata nel tempo la percezione (pubblica e privata) del sesso dal punto di vista della cultura occidentale. Nel mio piccolo, io proverò a tracciare una timeline della decadenza del maschio alfa in relazione all’accettabilità dei suoi appetiti sessuali: dalla preistoria all’era dei tombeur de femmes, dall’età dei puttanieri al presente degli stupratori.
Quando tutto iniziò, in Africa, oltre trecentomila anni fa, la vita per il maschio eterosessuale era un parco pieno di gnu e gazzelle. Non aveva idea di cosa fossero i germi o l’Agenzia delle Entrate né poteva immaginare cosa significasse essere sputtanato sui social. Le uniche cose che gli mettevano ansia erano paure che oggi, a noi occidentali, fanno quasi tenerezza: il buio, la fame e le grandi bestie predatrici. Ormai per la stragrande maggioranza degli europei il buio è diventato sinonimo di profondo relax, la fame (grazie al digiuno intermittente) non è più una minaccia ma un ambito stile di vita e, infine, chi vuol vedere da vicino le grandi bestie predatrici è costretto a pagar caro un Safari in Kenya.
Noncurante della cancel culture, il primo homo sapiens si aggirava sereno sugli altopiani dell’Etiopia, dividendo la sua giornata tra battute di caccia e violente litigate tra le pareti di pelle della propria tenda. Praticava occasionalmente il cannibalismo, ammazzava i propri simili e abusava di loro spontaneamente, non dopo un “ciak” di Lars von Trier. In poche parole, era un sanguinario stupratore seriale ed era orgoglioso di esserlo, caratteristiche per cui oggi ti bannano da Instagram (ma non da Twitter) e che nel paleolitico, invece, ti garantivano un ruolo di spicco nella cerchia della tua tribù.
Certo, i primi sapiens non erano dei debosciati 24/7, ma va riconosciuto che fu proprio questa divorante passione per l’ultraviolenza a spingerli a migliorare la qualità dei loro manufatti (selci sempre più affilate, armi più resistenti e trappole più ingegnose) e a sviluppare tecniche di macellazione e abilità culinarie. Di questo troviamo conferma negli studi dei ricercatori del Max Planck Institute di Lipsia, secondo i quali – a partire dai segni di botte, fratture, tagli e bruciature trovati sui resti fossili di animali (soprattutto gazzelle) – è stato possibile stabilire che i sapiens non erano solo degli abili cacciatori, ma anche degli apprezzabili macellai e dei discreti grill master con una passione da veri gourmet per il midollo alla brace. Detto questo la selezione naturale è stata implacabile con i cacciatori che non condividevano i cosciotti di gnu nonché (e su questo ci vorrebbe una tetralogia di Verhoeven…) con le donne che esprimevano i propri sentimenti prendendo a mazzate le altre donne e non solo i propri mariti. Su questo punto tutti gli eredi di Darwin sono d’accordo, non c’è biologo che dissenta: la qualità che più viene premiata dalla selezione naturale è l’altruismo.
Tra un barbecue e l’altro, i maschi sapiens si dedicavano ai loro hobby preferiti: attaccare gli uomini delle tribù avversarie e brutalizzare le loro donne. E così fu per millenni, senza che l’umanità si indignasse più di tanto, tant’è che per gran parte della storia dell’umanità lo stupro non è nemmeno stato considerato un reato contro la persona, bensì contro la proprietà. Lo stabiliva già nel Diciottesimo secolo a.C. il codice babilonese di Hammurabi, una delle più antiche raccolte di leggi scritte: la donna (soprattutto se giovane e vergine) era considerata a tutti gli effetti una proprietà di suo padre o di suo marito e la violenza sessuale ne riduceva o annullava il valore sul mercato matrimoniale.
Questa abominevole concezione della donna resta sostanzialmente immutata per tutto l’Alto Medioevo e oltre. Anche se andiamo al di là dei confini europei, non troviamo una situazione tanto migliore, visto che a cavallo dell’Undicesimo e Tredicesimo secolo Gengis Khan non faceva altro che saccheggiare e ingravidare qualsiasi cosa gli si parasse davanti. Stando a uno studio apparso nel 2003 sull’American Journal of Human Genetics, il suo patrimonio genetico sarebbe ancora oggi presente in sedici milioni di uomini, lo 0,5 per cento della popolazione maschile mondiale. Il dato conferma la tradizione storiografica che l’ha sempre ritratto come un vero stacanovista del sesso non protetto e cintura nera di rapporti non consensuali.
Nello stesso periodo, però, in Europa comincia a farsi strada l’idea (per noi ovvia) che la vittima dello stupro non sia il capofamiglia, bensì chi subisce in prima persona la violenza, ma è solo nel Tredicesimo secolo, nell’Inghilterra di Edoardo I, che lo stupro inizia a configurarsi come un reato contro la persona. A stabilirlo fu lo Statuto di Westminster del 1275 che – molto timidamente – cominciò a far presente agli inglesi che la violenza sessuale era una cosa un tantino maleducata. Anche se in concreto cambia molto poco, il mutamento di prospettiva è radicale: è la prima volta che la legge impedisce agli uomini di stuprare indisturbati. Da questo momento in poi, il maschio alfa che desidera assecondare i propri appetiti sessuali deve ricorrere all’arma della seduzione. Non può più comportarsi come un bruto proto-sapiens ipersessuato: deve pavoneggiarsi, imbellettarsi e diventare un libertino, cioè fare quel salto evolutivo che permetterà al maschio alfa di scopare a destra e manca fino al Diciassettesimo secolo e gran parte del Diciottesimo.
Ma per il povero predatore alfa non c’è un momento di tregua e, infatti, proprio sul finire del Diciottesimo secolo, per la precisione nel 1789, in Francia succede qualcosa che rimescola le carte in tavola: la rivoluzione francese dà una prima spinta al processo di emancipazione femminile e nell’ottobre dello stesso anno le donne manifestano in maniera compatta e coordinata contro Luigi XVI, marciando su Versailles per costringere il re ad accettare la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino. La parità uomo-donna è ancora una pia illusione, ma per gli sfortunati tombeur de femmes francesi la libertà di movimento si fa ancora più stretta: nell’immaginario collettivo il maschio alfa non è più collegato all’irriverente sensualità del libertino, bensì all’idea ben più laida e scorreggiona del puttaniere.
Da quel momento in poi, come racconta anche Foucault, le culture europee cominciano a parlare sempre più apertamente di sesso e – parallelamente – a scopare sempre di meno, illudendosi che il loro chiacchiericcio osé le renda più “liberate” rispetto alle civiltà dei secoli precedenti, che vengono erroneamente rappresentate come caste e sessuofobe. Il sesso parlato ruba la scena a quello consumato, la modernità si loda e si imbroda autoassegnandosi medaglie d’oro di liberazione sessuale, mentre nei fatti si procede a una costante e sistematica castrazione mediatica che stigmatizza sempre più i puttanieri che, nella loro successiva incarnazione, vengono infine etichettati come morti di figa. Il progressivo e inarrestabile declino del maschio alfa procede senza sosta fino agli anni Ottanta, epoca d’oro del voyeurismo, in cui il sesso si fa del tutto immateriale. Quasi a chiudere il cerchio, Foucault muore nell’aprile 1984, lasciandoci soli a decifrare gli anni Novanta che, per certi versi, diventano una sorta di Riccioli d’Oro della sessualità, perché non è più ok essere predatori, ma si può ancora essere dichiaratamente (e giocosamente) perversi.
Lo scandalo sessuale che metterà fine a questa breve parentesi accademica di playfulness è ovviamente il caso Lewinsky. La relazione tra il presidente Bill Clinton e la giovane stagista inizia nel 1995, ma diventa un caso giudiziario solo nel gennaio del 1998. “La fine di un’era” direte voi e avreste anche ragione se, qualche anno dopo, per gli sventurati maschi alfa le cose non si fossero messe anche peggio. L’affaire Lewinsky, infatti, impallidisce davanti all’alluvione di scandali portati alla luce dal movimento del MeToo.
Nata nel 2006 su un social ormai sepolto dalle sabbie del tempo (MySpace), l’espressione MeToo è una parola chiave inizialmente utilizzata dall’attivista afroamericana Tarana Burke per invitare le donne che come lei erano state vittime di violenza sessuale a condividere pubblicamente le loro esperienze, per creare una rete di autosostegno tra le survivor ed evidenziare la spaventosa e trasversale diffusione del fenomeno. Il movimento, però, raggiunge un’eco internazionale nel 2017, quando l’attrice Alyssa Milano invita con un tweet le donne che hanno subito una qualsiasi forma di violenza sessuale a parlarne pubblicamente utilizzando l’hashtag #metoo, che diventa rapidamente virale e innesca una serie di eventi che portano alla caduta di figure centrali dell’industria dell’entertainment americano: dal produttore Harvey Weinstein (l’uomo più ringraziato nei discorsi dei vincitori dei premi Oscar, secondo solo a Dio) al papà televisivo di intere generazioni di americani (e non solo), Bill Cosby.
Oggi, nonostante sia passato qualche anno, la portata sismica di questa ondata di denunce non ha ancora smesso di permeare il dibattito quotidiano in tutti i Paesi occidentali. Il movimento MeToo è la revolverata alla tempia di quel poco che restava – finiti gli anni Novanta – dell’archetipo di James Bond. Una benedizione che però, come tutti i movimenti rivoluzionari, deve fare i conti con la realtà e non farsi prendere da massimalismi che rischiano, seppur involontariamente, di sforare nel tragicomico alla Molière. Come nel caso di una donna del New Jersey che, non potendone più del marito violento e prevaricatore, iniziò a frequentare un gentile bellimbusto. Quando il marito scoprì che sua moglie aveva passato una serata piacevole, andò su tutte le furie e la signora dovette recarsi dalla Polizia e denunciare il bellimbusto per stupro. L’innocente, il cui volto finì sui giornali locali, perse amici, lavoro e famiglia.
Fermo restando che la vittima di una qualsiasi forma di violenza (fosse anche solo psicologica e indiretta) ha tutto il diritto di sentirsi scossa e di elaborare il proprio trauma, mi riesce difficile mettere sullo stesso piano due stupratori seriali come Weinstein e Cosby e l’artista americano Chuck Close, anche lui finito nel libro nero del MeToo nel dicembre del 2017.
Per chi non lo sapesse, Close è stato uno dei più grandi pittori fotorealisti americani. Affetto da gravi problemi neurologici sin dall’infanzia, nel 1988, alla soglia dei cinquant’anni, viene colpito da un collasso dell’arteria vertebrale che lo paralizza dal collo in giù. Nonostante la pressoché totale disabilità, Close riesce faticosamente a tornare alla pittura, inventandosi una tecnica che gli consente (grazie all’uso di grandi pannelli suddivisi in griglie e a una fasciatura che gli fissa il pennello al polso) di realizzare enormi tele che da vicino non sembrano altro che reticoli di riquadri colorati. Indietreggiando, però, quell’accozzaglia di macchie variopinte si rivela per quel che è: un enorme ritratto pixelato.
Fino al 2017, nessuno aveva dubbi su quale sarebbe stato il destino di Close: in vita aveva raggiunto un incredibile successo economico e si era guadagnato il rispetto della comunità artistica internazionale; da morto sarebbe stato meritatamente celebrato nei libri di storia dell’arte. Nessuno poteva immaginare che il 20 dicembre di quell’anno, ovvero a un paio di mesi dall’esplosione dell’hashtag #metoo, sarebbero emerse le dichiarazioni di due modelle che accusavano Close di aver usato un linguaggio improprio mentre le ritraeva nude. A gennaio del 2018, si aggiunsero le identiche accuse di altre quattro donne: tutti gli episodi erano avvenuti tra il 2003 e il 2013. La risposta di Close arrivò dalle colonne del New York Times, in un’intervista in cui si scusava d’essersi espresso in maniera inappropriata e riconosceva di essere un vecchio sporcaccione. “Lo ammetto, sono sboccato, ma siamo tra adulti.” Le scuse offerte, però, non l’hanno salvato dallo sputtanamento e da una damnatio memoriae che ancora oggi, a due anni dalla sua morte, grava sul suo nome.
Non c’è dubbio: lo stupro va punito severamente. Ma cos’è e cosa non è stupro lo decide l’esperto che dialoga con la vittima, non il tribunale della folla, soprattutto quando la folla crede di essere guidata dalle migliori intenzioni, perché in quei casi si comincia col politicamente corretto e si finisce col giustizialismo. Se ci concentriamo sempre e soltanto sull’impiccare lo stupratore, non saremo mai una società in grado di pensare al “dopo” delle vittime. Abbiamo bisogno di un sistema fondato sul recupero, che aiuti l’individuo, ma la nostra brama di punizioni che “diano l’esempio” alimenta un cortocircuito febbrile, fatto di emozioni forti e che riduce tutto a un video di meno di un minuto.
Non voglio far l’avvocato del diavolo, anche se devo dire che mi riesce piuttosto bene, ma vi prego di tenere a mente che nel caso di Chuck Close stiamo parlando di un anziano signore in sedia a rotelle, al quale nel 2015 (oltre ai suoi preesistenti mille problemi neurologici) viene diagnosticata una forma di demenza neurovegetativa. Sono perfettamente consapevole che Close fosse un uomo ricco e potente, ma faccio davvero fatica a credere che un signore che nel 2003 aveva già sessantatré anni e da quindici era bloccato su una sedia a rotelle potesse rappresentare una reale minaccia per la società o per le modelle che posavano per lui. E, soprattutto, più che il linguaggio scurrile di Close, dovrebbe stupirci la poca dimestichezza che queste donne hanno con la figura antropologica dell’artista che, da Caravaggio a Sam Peckinpah, non è mai stato un essere particolarmente garbato.
Ed è con l’accanimento mediatico che ha cancellato Chuck Close e la sua arte che si chiude l’ingloriosa parabola discendente della storia del maschio alfa. Parafrasando T.S. Eliot, la millenaria parabola del maschio alfa non si chiude con il rombo di un carro armato, ma col fievole ronzio di uno smartphone.