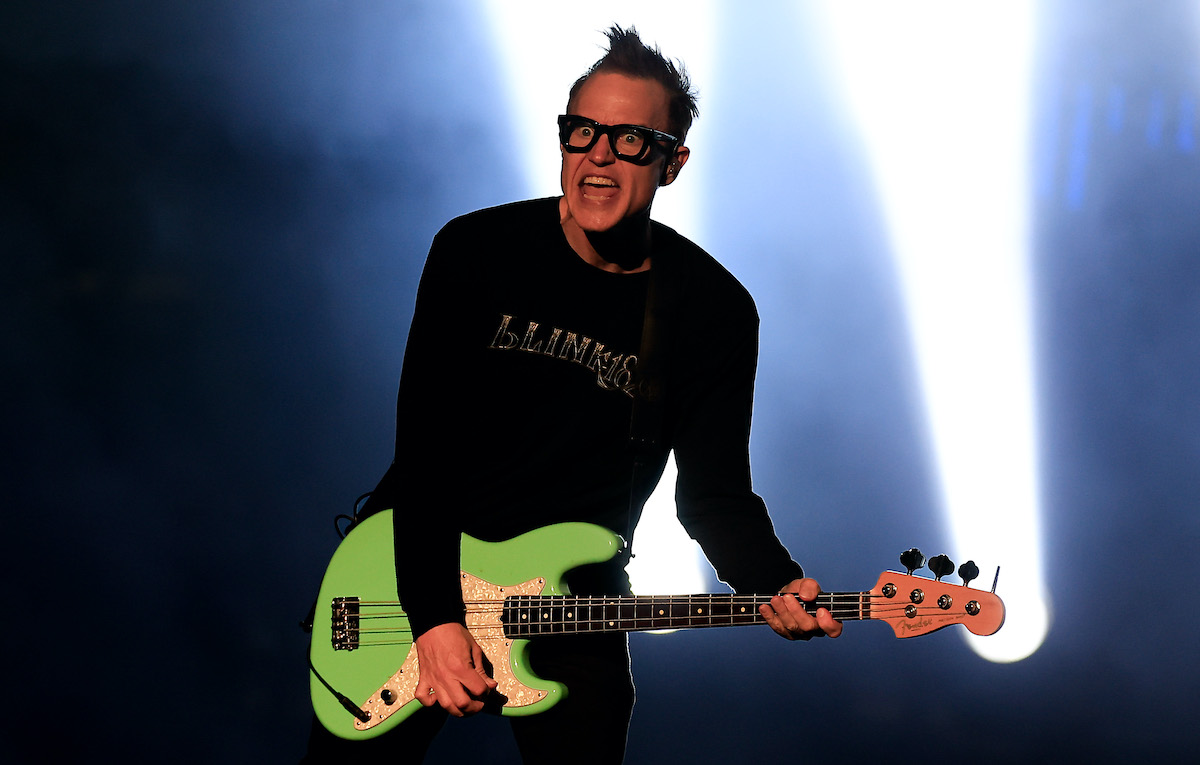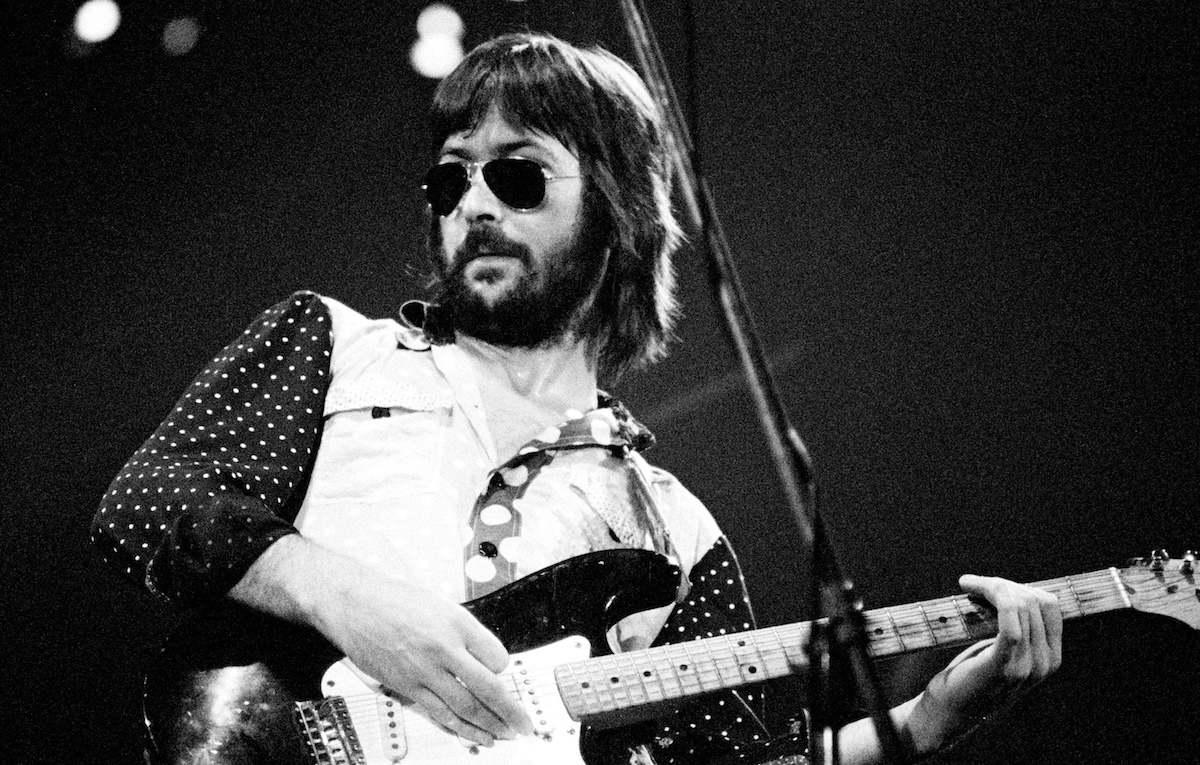“Un ottico” Fabrizio De André (1971)
Non è l’unico lavoratore, l’ottico, tra quelli cantati da Fabrizio De André nel suo Non al denaro non all’amore né al cielo del 1971, adattamento musicale, scritto da De André con musiche e arrangiamenti di Nicola Piovani, dell’Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters, ma è forse il più interessante, il più imprevedibile. La storia di Dippold, ottico, narrata al presente e senza alcun riferimento alla morte, a differenza di quanto accade per gli altri personaggi, è quella di un ottico che stufo di vendere lenti per occhi normali, per pupille abituate a copiare, cioè riprodurre il mondo negli occhi, inizino a inventare mondi propri. Così l’ottico smette di essere tale e diventa, letteralmente, spacciatore di lenti per improvvisare occhi contenti, un riferimento chiarissimo agli allucinogeni, sostanziato dalla musica che si sdoppia, corre e rallenta, si arrotola come se lo spartito fosse improvvisamente letto dentro un caleidoscopio. Un pezzo grandioso e senza paragoni possibili nella canzone italiana – ottimo anche nella versione di Morgan che risuonò interamente l’album e lo incise nel 2005.
“Gli operai” Giorgio Gaber (1972)
Dal suo Dialogo tra un impegnato e un non so, Gaber racconta l’operaio, sfruttato sul lavoro e come immagine, reso retorica e poi abbassato a mera retorica, analizza con un testo – al solito puntualissimo e sorprendente – un immaginario, un racconto politico degli anni ’70, facilmente estendibile ai giorni nostri per quanto concerne lo sfruttamento, poco estendibile forse per quanto invece riguarda la potenza di una forza collettiva, una forza a cui Gaber fa spazio col procedere del brano, una forza che non si cristallizza nella rabbia ma dalla rabbia è, piuttosto, generata. Un pezzo che vale come ascolto ma anche, al solito con GG, come lettura: “Gli operai hanno addosso una forza tremenda / che può rovesciare questo mondo di merda / che noi alimentiamo e non si ferma mai”.
“Il lavoro” Piero Ciampi (1973)
La terza traccia dell’LP del 1973 di Piero Ciampi Io e te abbiamo perso la bussola si intitola proprio Il lavoro, l’album precede di due anni l’antologia Andare camminare lavorare e altri discorsi, che include, relativamente al tema, l’assai nota title track, una delle produzioni più politicamente accurate di Piero Ciampi. Qui Ciampi canterà “Nutriamo il lavoro, alé! Gli agnelli a pascolare con le capre fra i nitriti dei cavalli, questi rumorosi vigilati tutti da truppe di pastori”, come ricreando con immagini bucoliche lo schema dell’operaio controllato infine dal padrone, ma è ne Il lavoro, più che in questo brano noto, che la poetica ciampiana dà il suo meglio sul tema. Se infatti Andare camminare lavorare può essere considerato un racconto sociale, nella canzone del ’73 Ciampi racconta, più in linea con la sua scrittura, la dimensione intima, privata dell’uomo che ha a che fare con una vita lavorativa eternamente mobile e sbandata, precaria, l’uomo che cerca asilo tra le braccia della donna che ama, che cerca in un tuffo in mare nudo con lei la risposta ferma e sicura alla propria eterna instabilità. Il lavoro è una sorta di lettura cantata, alla maniera tipica di Piero Ciampi, su un’onda sinfonica in apertura che si fa sempre più intima, jazzata, sorretta dalla ritmica di un basso imponente. “E allora? Ti ho detto non so niente. E allora? Non lo so non lo so non lo so non lo so”, salmodia Ciampi che trascorre una grande parte della sua breve vita a giustificarsi con le donne per la propria impossibilità alla garanzia, alla sicurezza, e che sempre cerca nell’amore e nel sogno, disperatamente, proprio qualche certezza che il lavoro, il denaro, la vita reale non possono offrirgli, quel posto nel mondo che il suo essere uomo precario, ancor prima che precario lavoratore, non gli permetterà di raggiungere mai: “Non è cambiato niente, provvederò, ma domani è domenica e ti porto a nuotare fino a mezzanotte”.
“L’operaio Gerolamo” Lucio Dalla (1973)
Statuario pezzo dalla prima produzione di Lucio Dalla, da Il giorno aveva cinque teste, primo lavoro in studio con i testi del poeta Roberto Roversi, L’operaio Gerolamo chiude il lato A dell’album ed è una poesia vera e propria che racconta la storia di un operaio e della sua vita disperata come se nulla stesse accadendo al di fuori del lavoro che costringe a spostarsi, emigrare, faticare e infine perire distrutti. “Chiudo gli occhi” è il verso che apre ogni strofa, come se bastasse chiudere gli occhi, dunque non vivere, addormentarsi un istante per risvegliarsi in una dimensione peggiore, ancora più dura, fino a morire. Non vive l’operaio distrutto: fatica e chiude gli occhi, soffre e chiude gli occhi, fino a quando arriva a chiuderli per sempre.
“Vincenzina e la fabbrica” Enzo Jannacci (1974)
La storia di Vincenzina, emigrata avellinese nella periferia milanese, è quella del film Romanzo popolare diretto da Mario Monicelli nel 1974 per cui Enzo Jannacci scrive appositamente il brano che finisce su un 45 giri insieme a una versione strumentale del pezzo e poi nell’album Quelli che. Forse il più disperato pezzo sul lavoro mai scritto in Italia, sebbene la sua disperazione sia soprattutto nell’incedere del brano, nel senso di annullamento e rassegnazione che i suoni sembrano descriverci. Poche parole per raccontarci la vita di Vincenzina che altro non vede che la fabbrica, altro non può conoscere del mondo, mentre la squadra del cuore (nel film Giulio Basletti, Ugo Tognazzi, fervente tifoso milanista è suo marito) non perde, ma fa zero a zero, sottolineando un generale senso di immobilità disperata e perdita di senso anche attraverso le piccole cose, le più semplici. Il padrone non conosce i problemi, nemmeno quelli di una squadra che non ce la fa, perché il padrone in qualche modo se la cava sempre, ed è qui, tramite una piccola immagine, che l’ironia tipica dell’autore si cristallizza nella descrizione di una vita che, a dire il vero, pare non esistere se non per il lavoro e non mostrare altro di sé, nemmeno a chi si ama: “Vincenzina vuol bene alla fabbrica e non sa che la vita giù in fabbrica: non c’è, se c’è… com’è?”.
“Agapito Malteni ferroviere” Rino Gaetano (1974)
Nel primo lavoro in studio di Rino Gaetano, Ingresso libero del 1974 ci sono ben due brani, entrambi molto interessanti, che raccontano il lavoro da prospettive diverse, da una parte L’operaio della Fiat, dall’altra la storia di Agapito Malteni, un ferroviere pugliese del tavoliere che lavora a Manfredonia. Rino Gaetano tiene a dirci subito che Agapito Malteni è tutt’altro che uno sbandato, anzi, è ben educato, ha spirito cristiano, è un ligio lavoratore del sud della nazione che però matura dentro di sé un senso spiccato di livore per l’ingiustizia, per questo lavoro che costringe tanti compaesani alla fuga al nord, per lasciare “la falce in cambio di un martello” – i campi per la fabbrica, in un’immagine perfetta. Un giorno decide di architettare un piano, lasciare andare il treno da sé all’altezza di Barletta, dirottarlo, ma viene fermato da un collega (“svelò il suo grande piano all’altro macchinista / buono come lui ma meno utopista”) con cui si confida. Così questo pezzo, che cita chiaramente la storia de La locomotiva di Guccini (1972) e, tanto nella musica tanto quanto nel progetto distruttivo Il bombarolo di Fabrizio De André (uscita un anno prima nel concept album Storia di un impiegato), diventa in chiusura la storia di un’amicizia salvifica tra compagni di lavoro.
“Se io lavoro” Le Orme (1977)
Nel 1977 Le Orme incidono il loro disco parigino Storia o leggenda, il più pop della loro produzione, insieme malinconico ma pure, in qualche modo, arioso, extra prog. Questo pezzo, singolo dell’album, orecchiabilissimo ed estremamente godibile, ricorda il suono che di lì a poco Giusto Pio e Battiato praticheranno insieme e sottolinea una diversa prospettiva del lavoro, che in qualche modo ricorda quella di Luigi Tenco in Mi sono innamorato di te: se io lavoro è perché non so che fare, canta Aldo Tagliapietra, il lavoro per passare il tempo insomma, non solo per i soldi, il lavoro che non fa sentire inutili, il lavoro che riempie l’esistenza dell’uomo, perché perdere tempo significa restare indietro.
“O cara moglie” Ivan Della Mea (1978)
Ascrivibile a una certa canzone di protesta, certamente O cara moglie di Ivan Della Mea, inserita nel suo Ho male all’orologio del 1978, è un brano talmente potente e intrinsecamente destinato a durare ben oltre il contesto, da superare ampiamente i confini del suo genere e dal suo contesto di nascita. Un pezzo di folk italiano molto essenziale maturato su un crescendo esponenziale che accompagna la rabbia dell’Io narrante che torna a casa dal lavoro e racconta alla moglie di essere stato licenziato dopo aver scioperato. Inizialmente chiede alla donna di mandare il figlio a dormire per evitare che senta la storia, forse per pudore o una forma di orgoglio e di vergogna. Il pezzo però continua e nel raccontare la rabbia cresce esponenzialmente, si rafforza l’orgoglio e il desiderio, infine esplicitato, che anche il figlio senta e apprenda l’accaduto, per scoprire e capire cosa significhi lottare per i propri diritti e per la propria libertà.
“Gente in progresso” Franco Battiato (1983)
Se c’è un disco che racconta alla perfezione i malesseri di città dell’uomo contemporaneo, quelli di chi ha conosciuto la controra nell’infanzia del Sud e ora si trova a fumare sigarette una dopo l’altra per il gusto del tabacco lungo Corso Vittorio Emanuele e in Galleria, a Milano, compresso dai ritmi serrati di un mondo che gira intorno alla produzione e al capitale, beh, quello è Orizzonti perduti di Franco Battiato, anno 1983. Il disco più milanese della produzione di Battiato offre grande spazio al traversale racconto dell’anima lavoratrice dell’uomo degli anni ’80 ma si supera, con un verso esplicito e indimenticabile in questa Gente in progresso, dove la gente è in progresso solo per definizione, ma in realtà vive schiacciata dal motore dei ritmi frenetici del proprio tempo: “e tu he fai di sabato in questa città dove c’è gente che lavora per avere un mese all’anno di ferie?”. Cantare il lavoro per Battiato non è solo cantare il lavoro ma, semmai, cantare una vita che dipende da esso.
“Canto delle lavandaie del Vomero” Anonimo
Impossibile raccontare il lavoro nella canzone italiana senza fare un riferimento alla canzone popolare, quella napoletana, in primis, quella milanese e non solo, basti pensare ai canti delle mondine o a pezzi come La filanda di Milva, diventati poi pezzi della tradizione anche pop. Il canto delle lavandaie del Vomero è un canto antichissimo, risalente a un periodo imprecisato tra il Duecento e il Quattrocento, uno dei primi pezzi attestati della canzone popolare napoletana, il suo autore è anonimo. Cantato da moltissimi, anche da Amália Rodrigues, sembra racconti la mancata redistribuzione dei terreni promessi da parte di Alfonso D’Aragona, quei terreni che nel brano sarebbero i fazzoletti delle lavandaie, i moccatora, come da antico dialetto napoletano. Le lavandaie svolgevano la loro attività a Capodimonte, al Sebeto, alle fontane di Porta Capuana, alla Maddalena, ma arrivavano dalla zona del Vomero come attestato da Roberto De Simone che farà tornare le lavandaie nei suoi cori (primo e secondo coro) ne La gatta cenerentola. Il secondo coro delle lavandaie, in particolare, è un pezzo che oggi ritrova grande spazio in Italia e non solo, ripreso da Leo Mas e abilmente usato da Paolo Sorrentino nell’incredibile scena del conclave del suo ultimo The New Pope.