«Era ancora ragazzo quando ha fatto sapere al mondo la sua risposta alla guerra, all’atomica e alla distruzione dell’ambiente. Ha sostenuto attivamente il movimento per i diritti civili e risvegliato in molti il bisogno di rivolta sociale e politica», scriveva Patti Smith nell’introduzione alla raccolta dei testi di Bob Dylan. Quand’è passato all’elettrico, «ci ha regalato Highway 61 costruendo un ponte tra la poesia e il rock’n’roll. Da innamorato ci ha dato canzoni con l’atmosfera sacrale di Sad Eyed Lady of the Lowlands. In un momento di grande introspezione ci ha fatto dono delle canzoni su John Wesley Harding. Non ha mai esitato nel darci il libretto d’opera della sua esistenza».
Il repertorio anni ’60 di Dylan è una delle grandi avventure del rock. Ha iniziato in tono minore nel 1962, ma nel giro d’appena quattro anni ha creato sei album ognuno a modo suo fondamentale in un crescendo (o quasi) da non credere. Se l’hanno soprannominato il Picasso del rock è per le continue trasformazioni iniziate proprio nei ’60. Il Dylan di Freewheelin’ non somiglia per niente a quello di Nashville Skyline, il rocker di certe tracce di Bringing It All Back Home è ben diverso dall’autore delle parabole di John Wesley Harding. Il libretto d’opera della sua esistenza è pieno di colpi di scena.
Enigmatico, ironico, strafottente, punk prima del punk. Ma anche poetico, divertente, empatico, a suo modo romantico. Quest’uomo «di principio e di rivolta» ha attraversato il decennio come un saggio sotto anfetamina, un poeta che si muove a velocità sconsiderata e lascia alle spalle tutto e tutti, amici e compagni di strada compresi. Mettere in ordine i suoi nove dischi è un esercizio per forza di cose impreciso. Ho usato come unità di misura non solo l’importanza oggettiva degli album (sfido chiunque a dire che Nashville Skyline è meglio di Bringing It All Back Home), ma anche inevitabilmente quel minimo di gusto personale necessario per decidere se Blonde on Blonde è meglio o peggio di Highway 61 Revisited. Questo è il risultato.
Bob Dylan
1962
Nel primo album, un flop dal punto di vista commerciale, il ragazzo che annotava i dischi dei bluesmen scrivendo la frase bella e assurda “Realizzato per e su Bob Dylan”, come se quella vecchia musica lo riguardasse in prima persona e nel profondo, offre la sua versione di Woody Guthrie e degli altri suoi eroi. Sono tutte cover tranne due, il modesto raccontino per immagini dell’arrivo a New York e soprattutto l’omaggio all’idolo Song to Woody, che fa ancora un certo effetto e ha ritrovato una sua centralità nella narrazione di quegli anni grazie a una bella scena di A Complete Unknown. Dylan ha 20 anni, eppure canta come uno che ha molto vissuto. È il fascino dell’album: nella voce di Dylan è iscritta profeticamente la storia che non ha ancora fatto, la strada che non ha ancora percorso.
Nashville Skyline
1969
È amato per motivi evidenti molto più negli Stati Uniti che da noi, dove si tende a vederlo come un bel deragliamento, il primo di una lunga serie. Dylan goes country e in copertina ci saluta toccando il cappello, insolitamente sorridente. In queste canzoni pure meritevoli d’attenzione, alcune oggettivamente meravigliose, mancano la tensione nervosa, la scrittura visionaria, il timbro di voce tagliente che hanno reso grande Dylan negli anni ’60. Dalla sua, Nashville Skyline ha la morbidezza quasi incantata di pezzi come Lay, Lady, Lay, che si scoprirà essere stata scritta per Barbra Streisand, e Girl from the North Country, rigiocata in duetto con Johnny Cash. È un album molto piacevole e perciò poco dylaniano.
John Wesley Harding
1967
Dylan torna dopo l’incidente motociclistico e il ritiro a Woodstock e non è più lui. Ha cambiato stile, ha cambiato musica, ha cambiato persino voce. Non canta più con quel timbro nasale e stridente, le parole di fuoco sono state sostituite da storie allegoriche e immagini d’incerta interpretazione, ma affascinanti. Gli altri sono reduci della Summer of Love, lui fa il boscaiolo con la Bibbia in mano e canta canzoni per lo più senza ritornelli che sembrano parabole. John Wesley Harding ha tanti pregi: la qualità della scrittura (ha un grande lato A, con All Along the Watchtower), il modo in cui trasfigura la tradizione, i testi visionari abbinati a un country-folk suonato senza troppe pretese e dalla semplicità terragna. È l’America che si fa Vecchio Testamento.
The Times They Are a-Changin’
1964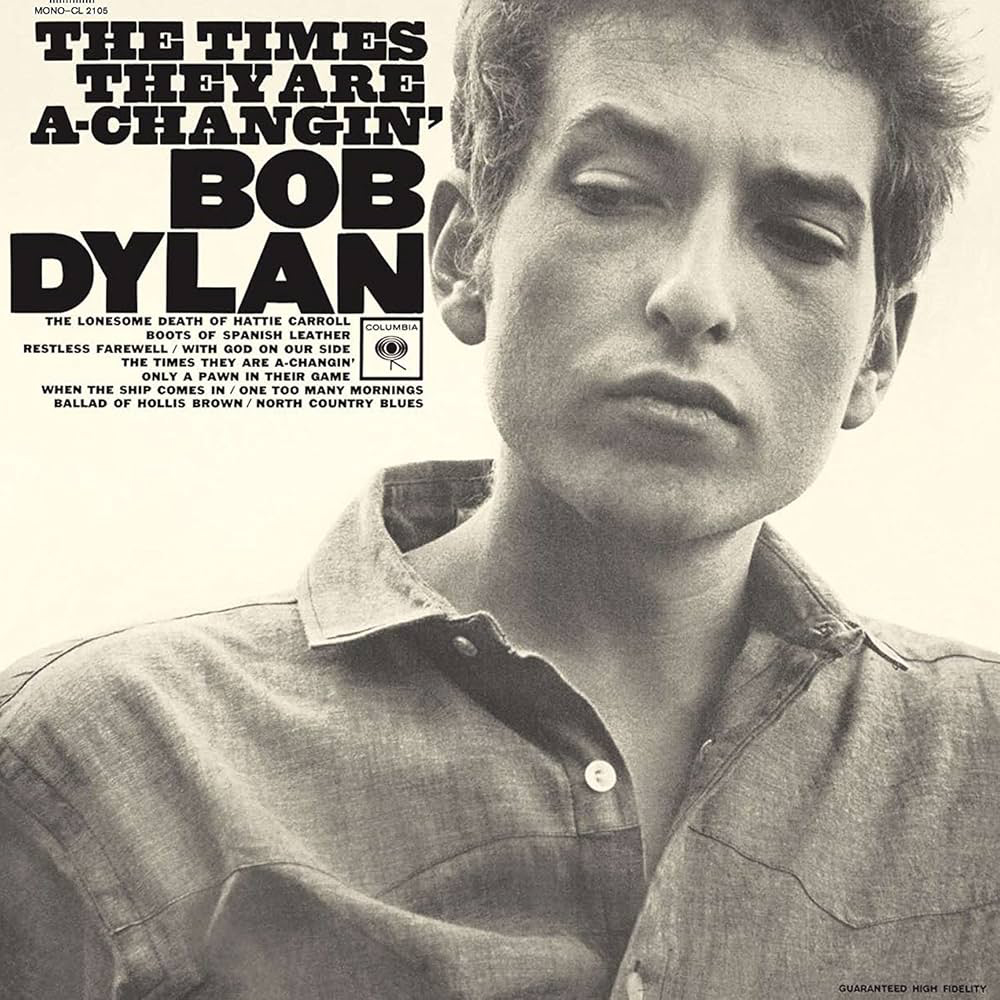
La convergenza tra la scrittura di Dylan e le istanze dei movimenti per i diritti civili trova la sua piena e definitiva affermazione nel terzo album, il più politico del cantautore sia per il numero di canzoni che raccontano il mondo e le sue ingiustizie, sia per l’intensità con cui le canta. L’omicidio di Hattie Carroll, la storia di povertà e violenza di Hollis Brown, l’assassinio di Medgar Evers, queste sono canzoni con nomi, cognomi e uno scopo. L’album si apre con The Times They Are a-Changin’ che ha le caratteristiche dell’inno generazionale, un’invettiva pacata e allo stesso tempo feroce, una descrizione della marea del cambiamento che si sta alzando e porterà via tutto e tutti, a meno che non si cominci ad andare nella direzione della giustizia sociale. E però finisce con Restless Farewell che è stranamente amara, una reazione al chiacchiericcio che circonda Dylan e un primo addio al movimento e alla scena folk che l’ha trasformato in una star. Times ha più di 60 anni ed è ancora un gran disco perché non ti fa pensare solo all’epoca che descrive, ma anche al fatto che canzoni del genere servirebbero pure oggi. Ma ha un carattere austero che lo rende meno interessante di altri dischi di Dylan del periodo.
Another Side of Bob Dylan
1964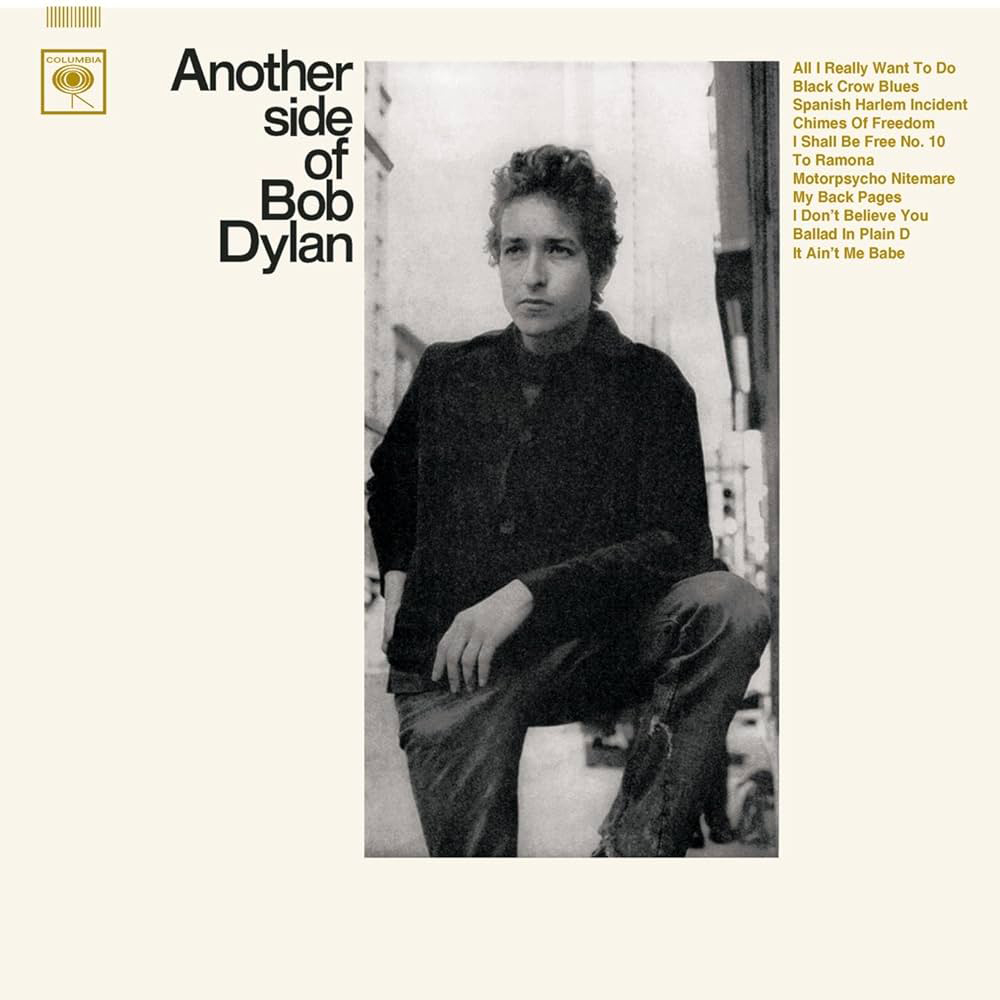
È l’altra faccia di Bob Dylan che dopo il suo disco più politicizzato e calato nell’attualità e nella storia riempie l’album di canzoni d’amore, di storie ironiche, di allucinazioni e di capolavori poetici. E così anche un’anti-canzone d’amore come It Ain’t Me Babe assume una connotazione diversa, la s’immagina manifesto dell’artista che dice a chi lo segue che non è lui il profeta del Movement, l’eroe del folk revival che indica la via. Alcune canzoni di Another Side sono scanzonate, altre hanno un tono accorato, come se riguardassero l’autore e tutti noi più di altre. È anche l’ultima celebrazione del folk voce-chitarra-armonica a bocca ed è pieno di classici, da My Back Pages all’incredibile Chimes of Freedom, che getta uno sguardo compassionevole su un’umanità ai margini.
The Freewheelin’ Bob Dylan
1963
Bastano cinque di queste 13 canzoni per fare di Freewheelin’ uno degli album più importanti degli anni ’60: l’inno Blowin’ in the Wind, la canzone per la fidanzatina (non Suze Rotolo che sta in copertina) Girl from the North Country, la caustica e feroce Masters of War con uno dei finali più sconvolgenti dell’epoca, le visioni di A Hard Rain’s A-Gonna Fall, la poesia di Don’t Think Twice, It’s All Right. Si capisce dal secondo album che Dylan ha un talento speciale e la capacità di portare la canzone di protesta, chiamiamola così, nel decennio delle rivoluzioni e della cultura giovanile. È un disco, questo, ma anche un pezzo di storia. Alcune di queste musiche sono tratte da repertori altrui? Ma certo. Dylan fa quello che i suoi maestri han sempre fatto nell’era precedente alla tutela giuridica del diritto d’autore: prende musiche altrui o tradizionali e ci mette sopra un suo testo. La differenza la fanno i risultati, capolavori di quelli che 60 e passa anni dopo ti fan dire: ma come faceva, ma come gli uscivano?
Bringing It All Back Home
1965
Il disco della svolta elettrica, il rock che incontra la lingua dei poeti beat, la rivoluzione fatta non con le parole contro i signori della guerra, ma immaginando una realtà allucinata. Una facciata più o meno elettrica e una più o meno acustica, le immagini affastellate con velocità da rapper (via Chuck Berry) di Subterranean Homesick Blues e la struggente fine di un amore in It’s All Over Now, Baby Blue, la protesta (ma anche la protesta contro la protesta) di Maggie’s Farm e le visioni felliniane di Mr. Tambourine Man, e poi ovviamente It’s All Right Ma (I’m Only Bleeding) e molto altro. Bringing It All Back Home scardina porte e apre la mente. Le parole sono gettate sulla tavolozza della musica con la creatività caotica d’un Jackson Pollock. Come dice una delle tante citazioni citabili del disco, chi non è occupato a nascere, è occupato a morire.
Blonde on Blonde
1966
Il primo grande doppio della storia del rock, il disco a cui Dylan ha lavorato più a lungo fino a quel momento, la chiusura del ciclo rock iniziato con Bringing It All Back Home, una raccolta di canzoni formidabili e dagli umori variabili che s’apre con la giocosa Rainy Day Women 12 & 35 e si chiude con l’epopea di 11 minuti di Sad Eyed Lady of the Lowlands, che occupava tutta la quarta facciata. In mezzo, canzoni per lo più su gente intrappolata dalla vita, classici (Just Like a Woman), pezzi facili (I Want You), canzoni d’amore allucinate (Vision of Johanna), dialoghi (One of Us Must Know), tanto blues, in un accumulo irresistibile e tipico da quel maggio 1966 in poi dei grandi doppi. Per molti Blonde on Blonde è il culmine di quattro anni d’incredibile creatività, il punto più alto di tutta la discografia Dylan, l’album dove trova il thin wild mercury sound che aveva in testa. Meravigliose le vocali allungate da quella voce alterata che qui per la prima volta sembra lottare conto l’esaurimento. Ancora meglio, per il mio gusto personale, il tono velenoso di Highway 61 Revisited.
Highway 61 Revisited
1965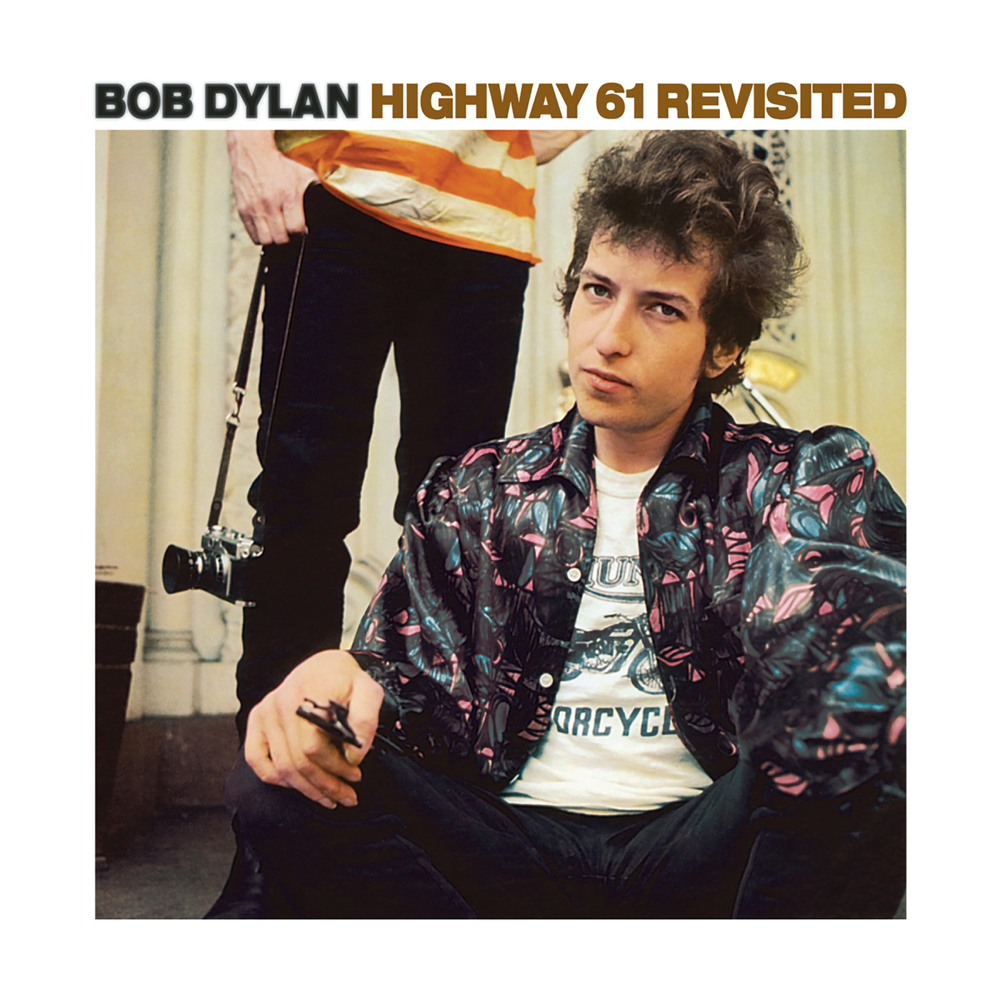
Un viaggio immaginario lungo la strada che collega il Minnesota, dov’è nato Dylan, alla Louisiana, la terra del blues. Dylan prende il folk e il blues e li trasfigura fino a renderli irriconoscibili, fino a distillare un suono urbano e pulsante di vita. La svolta elettrica c’è già stata, ma qui ci sono le canzoni più tese e musicalmente feroci del cantautore, che suona con gente come Mike Bloomfield e Al Kooper e che scrive come un poeta beat e anche un po’ come un surrealista, e cioè vomitando parole e immagini, più raramente raccontando storie in modo lineare. Qui ci sono la monumentale Like a Rolling Stone, che cambia il concetto stesso di singolo rock, quell’enigma dentro un mistero che è Ballad of a Thin Man, le visioni decadenti di Desolation Row e molto altro. Qui c’è il Dylan più strafottente, drogato, imbattibile. Uno dei grandi dischi anni ’60. Anzi, di più: il rock come lo conosciamo e amiamo inizia anche da questi 50 minuti.













