Ah, quale occasione mancata sono stati i Simple Minds, che dopo appena una decina d’anni dal loro esordio già iniziano una parabola discendente che non si è ancora fermata, dopo avere inanellato una serie di capolavori assoluti. Un fuoco indimenticabile, per citare gli amici/rivali U2.
La loro musica prende forma a seguito del terremoto punk, a quel punto i Minds sono poco più che adolescenti e si lasciano travolgere. Ma possono già contare su una tecnica e una cultura musicale non comune in altre band. Sanno suonare e hanno gusto: Charlie Burchill è un chitarrista in grado di passare da schegge lancinanti a texture ambient, mentre il tastierista Mike MacNeil, una specie di connubio tra Brian Eno e Tony Banks, primeggia attirandosi le ire di chi sperava che il punk spazzasse tutti i tromboni del prog, specie i tastieristi. Sulla scia di formazioni come Magazine e Ultravox (con e senza “!”) piazza i suoi strumenti al centro di un suono che da subito assume caratteristiche personali.
Con Burchill e MacNeil c’è il bassista Derek Forbes, e qui giù il cappello. Ossessivo e metallico, giri indimenticabili in grado entrare in piena armonia con il ritmo di corpi e menti. Forbes va in coppia con una girandola di battersiti (Brian McGee, Kenny Hyslop, Mike Ogletree e Mel Gaynor) che uniscono motorik a sensualità (in Once Upon a Time e Sparkle in the Rain al basso c’è John Giblin). Infine ci sono la voce (con la lezione di Bryan Ferry ben presente) e la fisicità di Jim Kerr, movenze fluide ed eleganti a farsi tutt’uno con la musica. Il furore punk è diluito con influenze kraut (Neu! e Kraftwerk in primis), glam e art (Bowie, Roxy Music), prog (Genesis, il Gabriel solista), goth e funk.
Peccato che a un certo punto accada qualcosa. Quel qualcosa ha un nome: Don’t You (Forget About Me), singolo dal successo stellare (paradossalmente nemmeno scritto dalla band, bensì dal produttore Keith Forsey e dal chitarrista Steve Schiff per la colonna sonora di The Breakfast Club) che mina lo sperimentalismo del gruppo. Scoprono una voglia irrefrenabile di diventare rockstar e ce la mettono tutta per riuscire, compresa la trasformazione di Jim Kerr in guru al pari di Bono, Sting e altri che a fine anni ’80 si danno da fare per unire rock e impegno sociale. La qualità musicale dal quel punto cala senza possibilità di risalita.
Finita l’epoca dell’impegno a Kerr e soci (ovvero Charlie Burchill, visto che gli altri hanno via via abbandonato) non rimarranno altro che i ricordi di un’era dorata che per quanti sforzi facciano non riusciranno più a eguagliare. Accontentiamoci del pacchetto di opere pubblicare nei dieci anni che li hanno visti protagonisti per scoprire il meglio e il… meno meglio di quel periodo.
Life in a Day
1979

L’esordio è acerbo, con la band che mette in campo un suono decisamente grezzo. È il disco più punk dei Minds, irruento, un po’ rabbioso, ma pur sempre originale grazie agli screzi eniani di MacNeil e a una vaga eleganza anticipatrice di sviluppi futuri. Una sorta di incrocio fra Sex Pistols e Roxy Music che stenta a decollare nonostante l’indubbio interesse di pezzi come la frastagliata Pleasantly Disturbed e la sbarazzina Chelsea Girl. Se si fossero fermati qui non ce ne ricorderemo, chi avrebbe sospettato invece che solo dopo pochi mesi…
Street Fighting Years
1989

Tra il Live Aid e i concerti pro Amnesty International, i Simple Minds si prendono un po’ troppo sul serio, diventano pomposi e si trasformino in ensemble combat rock-folk, quasi azzerando le particolarità del loro sound. Rifanno addirittura Biko di Peter Gabriel insieme a una Mandela Day che oggi appare retorica, nonostante la nobiltà degli intenti. Street Fighting Years è comunque un ultimo colpo di coda che conserva un paio di momenti interessanti, vedi le atmosfere genesisiane della title track e le inflessioni folk di Belfast Child, basata sulla rilettura di un traditional.
Once Upon a Time
1985
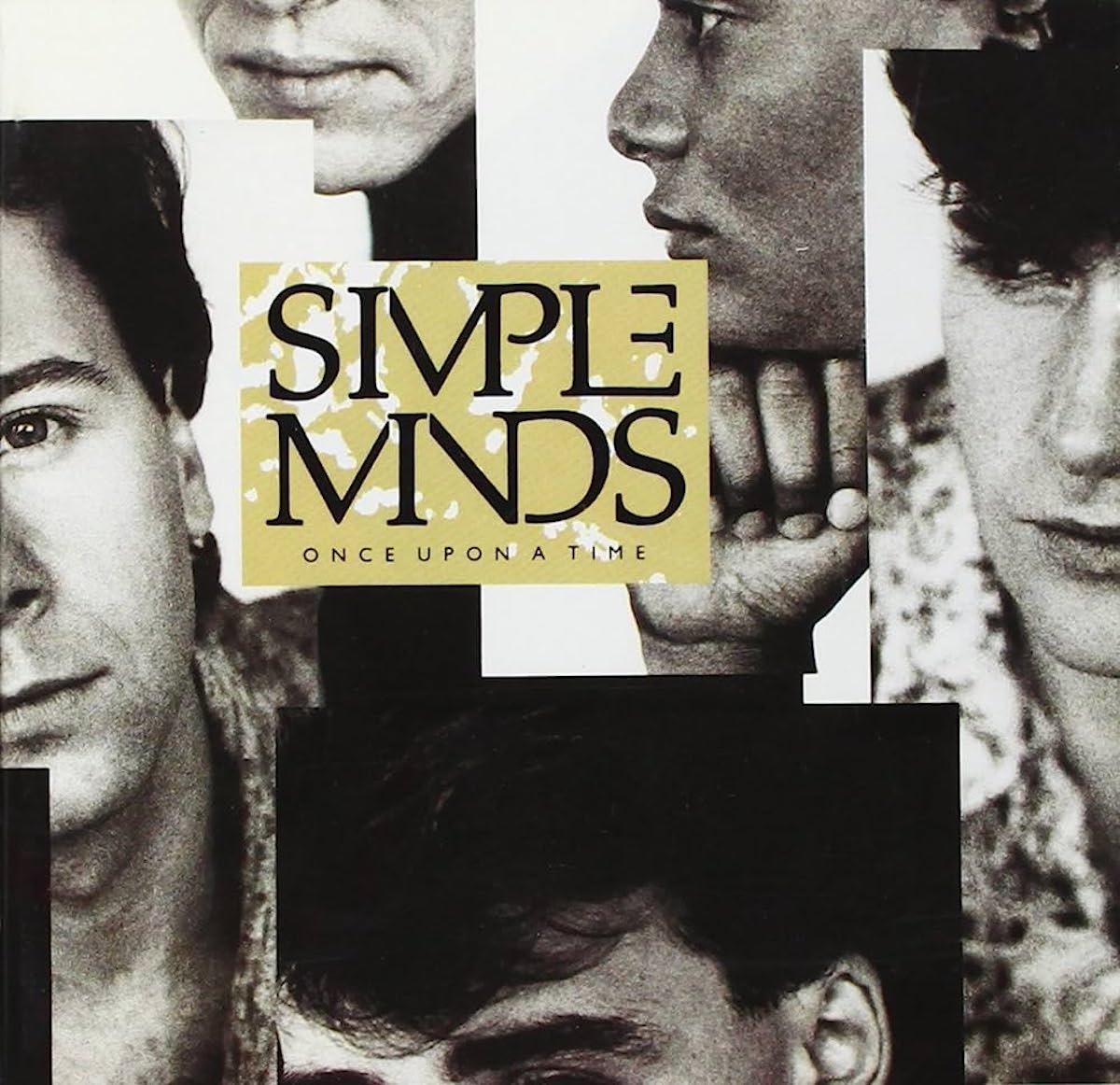
Il successo di Don’t You deve avere instillato nella mente di Jim Kerr e compagni l’idea che un singolone potevano anche scriverselo da soli. Ecco così arrivare Alive and Kicking che volendo è anche più interessante. Il disco ruota intorno al singolo coi Simple Minds che rinunciano alle eleganze fin qui mostrate a favore di una passionalità quasi springsteeniana. Alcune canzoni valide ci sono (Once Upon a Time, All the Things She Said, I Wish You Were Here), ma la svolta appare forzata e ancora mi chiedo come abbiano fatto a rinunciare alle loro peculiarità.
Sparkle in the Rain
1984
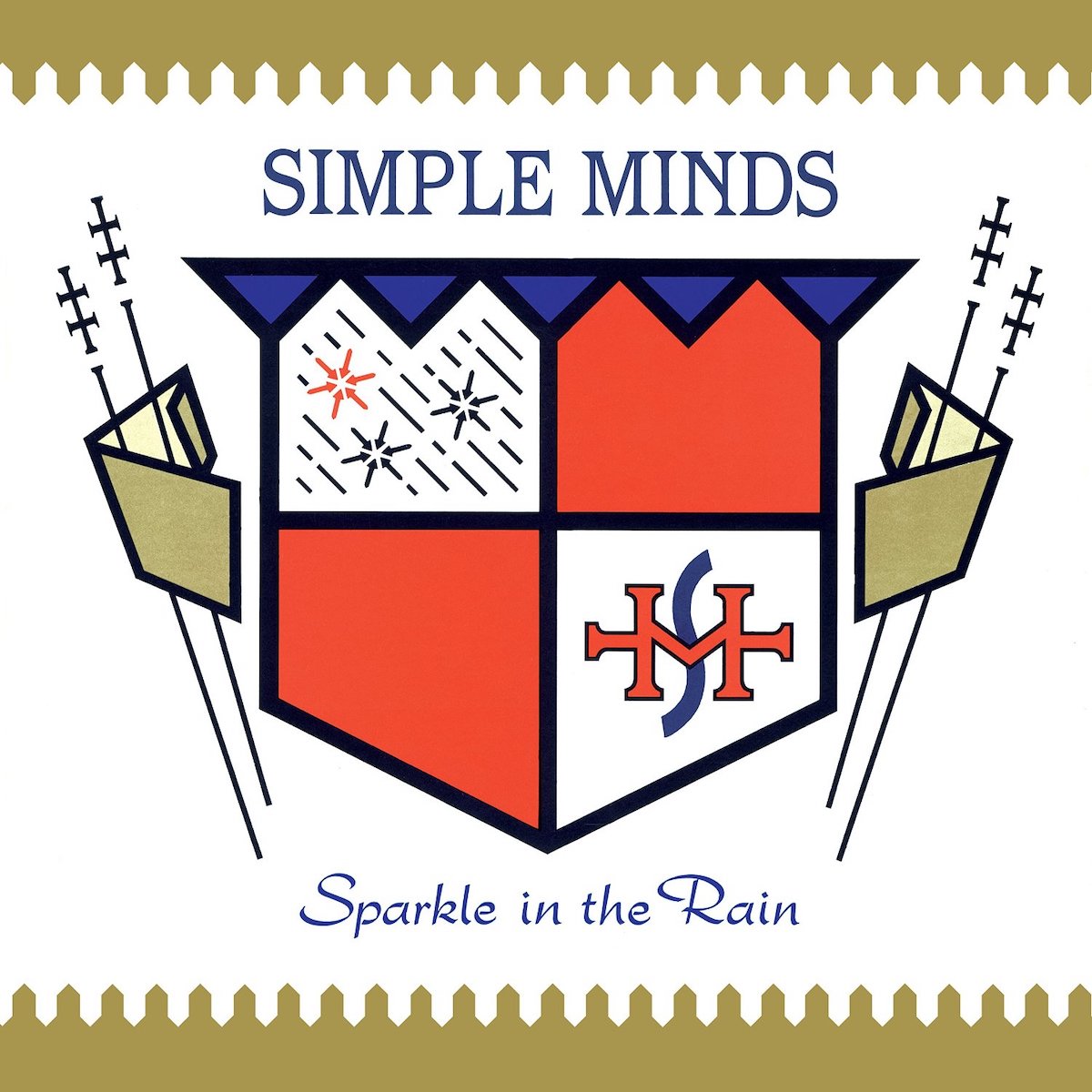
La voglia di svoltare verso un rock più dirompente era già apparsa in Sparkle in the Rain, che svoltava completamente rispetto alla raffinatezza di New Gold Dream. Nello stesso periodo l’ascesa degli U2 sembra irrefrenabile e cosa fanno i Simple Minds? Decidono di sposare quel tipo di suono affidandosi alle cure dello stesso produttore degli irlandesi, Steve Lillywhite. Ce n’era bisogno visti i risultati raggiunti? Certo che no, ma Sparkle in the Rain è comunque un disco potente e pieno di cose bellissime come Book of Brilliant Things, Speed Your Love to Me, Waterfront o Up on the Catwalk.
Real to Real Cacophony
1979

Solo sei mesi dopo Life in a Day, il miracolo: i Simple Minds diventano un gruppo totalmente nuovo, maturato ai massimi livelli e consapevole di un sound che si è fatto originale nel suo interpolare diverse esaltanti sfumature, dall’elettronica dei Kraftwerk al goth dei Joy Division, al prog, synth-pop, glam. Real to Real Cacophony risplende di un bagliore nero con i suoi rimi kraut e l’introversione di testi belli e visionari. In Carnival ci sono coriandoli di note all’impazzata, Calling Your Name è un pugno in faccia di ritmo e melodia, Film Theme e Scar sono colonne sonore di un mondo che brucia.
Empires and Dance
1980
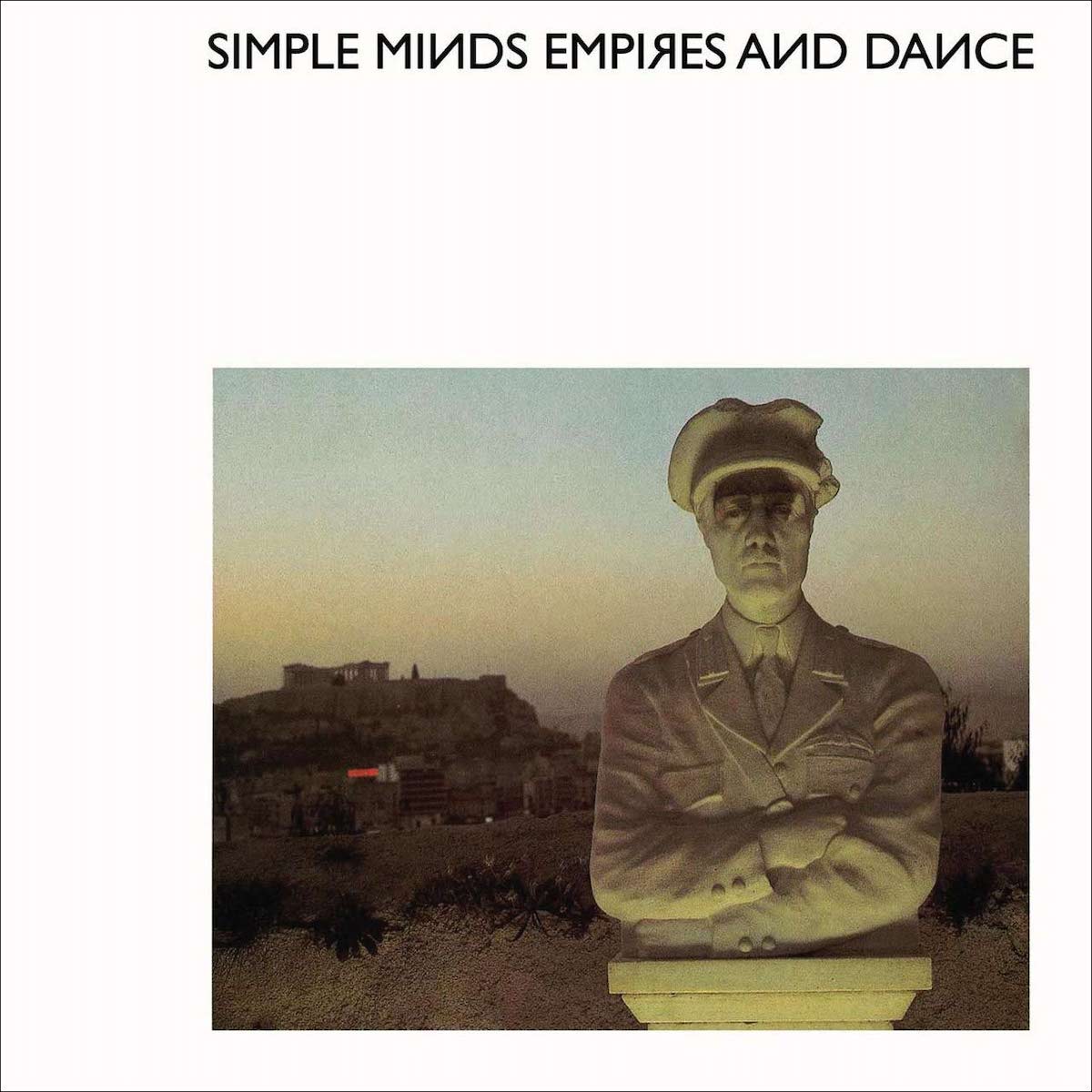
È il disco più oscuro e “irreale” dei Simple Minds, per certi versi un vero enigma. La dance del titolo è presente, ma è una danza macabra, a volte tribale. Ci si cala all’interno dell’inconscio collettivo europeo mentre avveniristici aeroporti suonano la musica di Brian Eno (I Travel, disco-wave narcotizzata), la pellicola rimanda ricordi sfocati, la musica si fa sperimentale come mai più succederà, ci sono accenni a Borges e a Gogol, c’è Twist/Run/Repulsion che è astrazione pura. Today I Died Again è una marcia funebre per Ian Curtis, ma la morte può anche danzare.
Sons and Fascination/Sister Feelings Call
1981

Sons and Fascination/Sister Feelings Call escono separatamente, col secondo in omaggio. Vengono poi uniti in un tutt’uno formidabile. La produzione di Steve Hillage dei Gong già lascia presagire il miglior connubio ’70-’80 che si possa sognare. In Trance as Mission riprende la Apocalypse In 9/8 di Supper’s Ready (ma è in 12/8), Theme for Great Cities ha aperture galattiche prog 3000, The American e Love Song singoloni da dicoteca marziana. Il concept immagina civiltà iper-tecnologiche in città-mondo e mette in scena l’apice della Mind-mistura nella fine del primo periodo post punk-prog-kraut, glaciale e calda al tempo stesso. Un ipertrofico e bellissimo Tales from Topographic Ocean post punk.
New Gold Dream (81-82-83-84)
1982

La puntina scende, si incunea nei solchi iniziali e le stelle esplodono in una sera d’estate. Someone Somewhere in Summertime mette in chiaro il nuovo balzo dei Simple Minds che splendono di rinnovato calore, panna electro-funk che cola in ritmi e melodie irresistibili. Sul tutto tastiere e chitarre iridescenti, un basso che punteggia estatico, visioni paradisiache con gli occhi chiusi a donare una vertigine tutta ’80. È un coro esaltante dell’esistere felici in quel decennio: “eighty-one-eighty-two-eighty-tree-eighty-you-four”. Si danza ipnotizzati da Glittering Prize, in Hunter and the Hunted ci piazzano addirittura Herbie Hanckok in un solo da stordimento dei sensi. Qua e là ancora piccole tracce di oscurità ma la luce si fa sempre più dirompente. New Gold Dream sta al top degli anni ’80.












