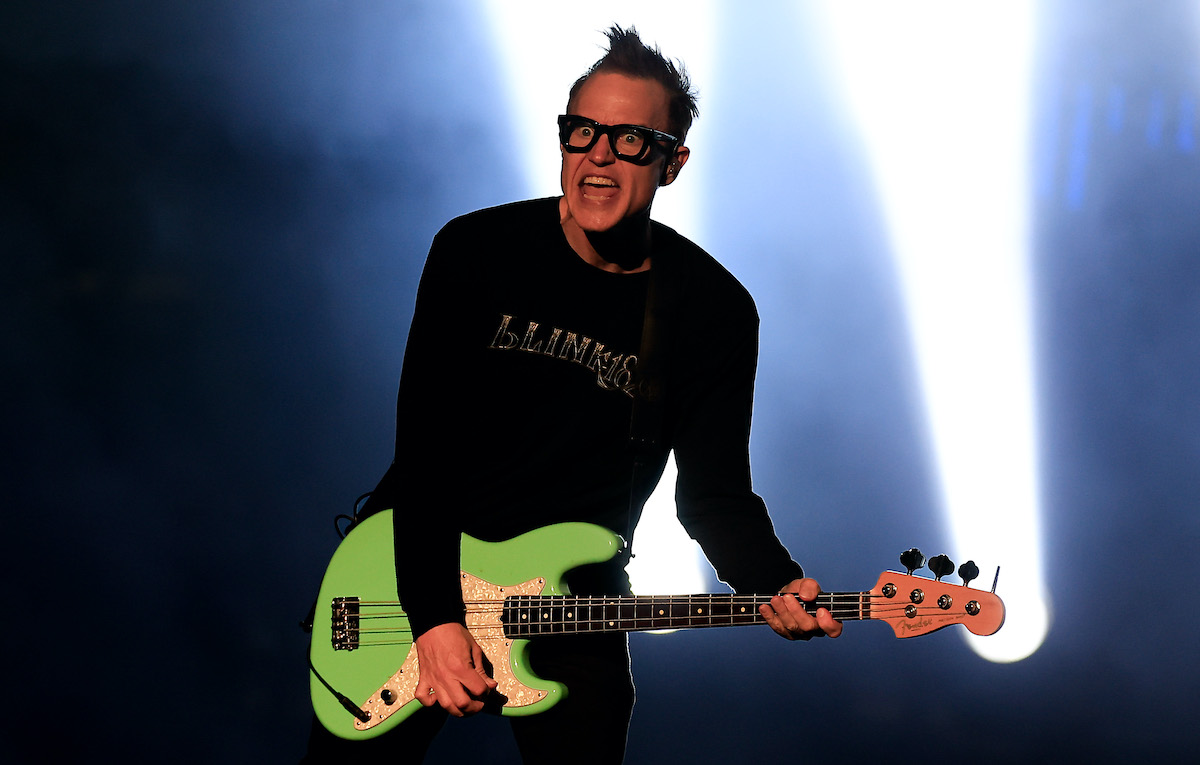«Il mio desiderio più grande era quello di esprimere me stessa», racconta Patti Smith nelle pagine del memoir Just Kids. E non avrebbe potuto riassumere meglio, in una sola frase, ciò che l’ha guidata nel corso di un’intera vita, consacrandola artista unica, intellettuale influente, donna eccezionale. Nata a Chicago nel 1946 e figlia della New York dei ‘60, fucina creativa di un’intera generazione, Patti Smith trova nell’arte la risposta al desiderio di libertà, una continua ricerca del vero, di sé stessa. Dalle prime performance poetiche, approda ben presto al rock: urgenza espressiva, riferimenti colti e poesia diventano inscindibili.
In una New York dove le regole sono state messe in discussione dalla Beat Generation, William Burroughs è il suo angelo custode, il CBGB un tempio. Dagli esordi e per tutta la carriera Patti Smith innalza poesia e musica abbracciando un’unica arte, portando il rock a un livello da cui non si torna. Quando Bob Dylan riceve il Nobel per la letteratura, è lei, emozionata, a incantare la platea della cerimonia di consegna, celebrando il ruolo di quegli artisti, figli del proprio tempo e di un mondo in continuo mutamento, in uno dei luoghi sacri della letteratura. Da sempre è un faro luminoso, artista coerente con sé stessa, mai doma.
Questa è una guida ai suoi dischi, solo quelli in studio e con materiale originale.
10. “Gung Ho” (2000)

Patti Smith inaugura il nuovo millennio con un netto distacco dal passato recente, anni che l’hanno vista tornare in studio e sul palco dopo il lungo addio alle scene. Se nei dischi precedenti non mancano intensità ed emozione, tra versi che cantano di senso della perdita e un nuovo viaggio nel mondo, qui la sensibilità torna agli esordi, più viscerale e diretta. Emergono brani come Glitter in Their Eyes e Persuasion (che vede la partecipazione ai cori di Michael Stipe dei R.E.M.) con gli arpeggi di Tom Verlaine, i testi scivolano dalla sensibilità biografica verso un abbraccio all’umanità intera, cercando di stabilire un equilibrio tra intimità e impegno sociale, embrione di ciò che emergerà in modo compiuto nei lavori successivi e, in special modo, in Banga. Per la prima volta nella sua carriera, Patti Smith non è ritratta in copertina: al suo posto, una foto originale del padre, protagonista anche nei testi, in posa durante la Seconda guerra mondiale.
9. “Radio Ethiopia” (1976)

La seconda opera di un artista, si dice, è sempre la più complessa. Radio Ethiopia ha il gravoso compito di seguire Horses, confermare Patti Smith come un’artista dalla sensibilità e poetica unici, non dimenticare il mercato e la programmazione radiofonica. Così, nascono brani come la title track e gli oltre sette minuti di virtuosismo accanto al distillato rock di tracce come Ask the Angels e Pumping (My Heart). Ancora, l’attacco al piano di Pissing in a River e la progressione dell’intero brano, inossidabili, si arrampicano verso alte vette drammatiche. Questo è il disco in cui la prova autoriale e strumentale non può certo essere messa in discussione, eppure il caleidoscopio sonoro accosta differenze di influssi e generi spesso distanti che, a tratti, può disorientare.
8. “Peace and Noise” (1997)
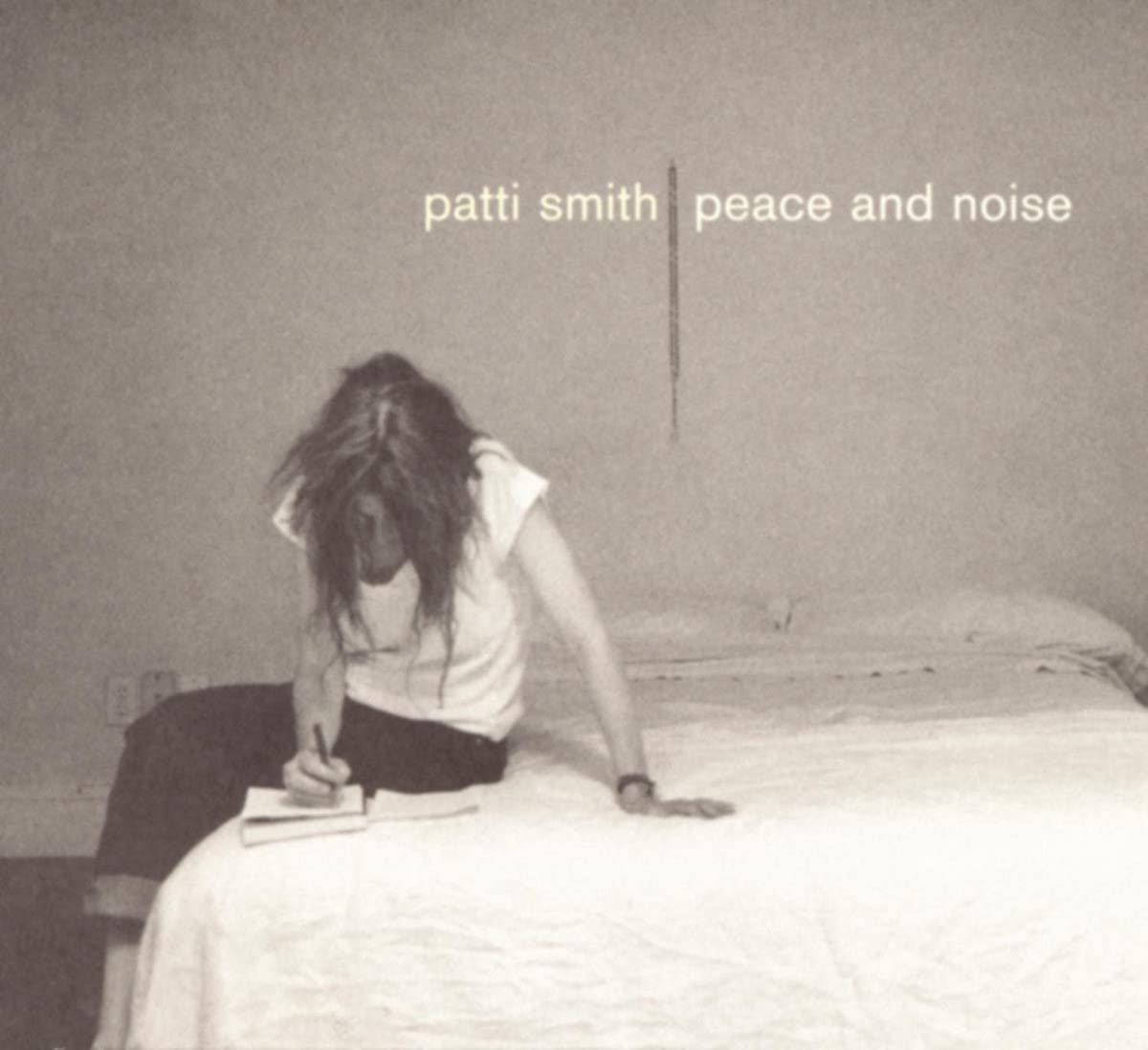
È il novembre del 1994 quando Fred “Sonic” Smith scompare, lasciando un vuoto incolmabile nella musica e nella vita di Patti Smith. Come racconta l’artista nel documentario Dream of Life, lo spirito di Fred è percepibile nell’album pubblicato tre anni dopo, Peace and Noise. Il pianoforte guida le linee melodiche della maggior parte dei brani, compaiono i versi recitati in Memento Mori, la chitarra acustica in Last Call. La quiete e il rumore evocati nel titolo si alternano tra i brani, dando vita a un disco sospeso, con vette di intimismo acuminate.
7. “Dream of Life” (1988)

Nove anni dopo aver abbandonato le scene ed essersi trasferita da New York a Detroit, ecco di nuovo Patti Smith. E l’attacco del disco che segna il suo ritorno alla musica è già storia ai primi ascolti: si tratta infatti di People Have the Power. Il lavoro non si esaurisce (ovviamente) alla prima traccia: l’arpeggio delicato che annuncia Paths That Cross e la delicatezza della title track preannunciano quella che è l’atmosfera generale dell’album, distaccato rispetto alla produzione dei ’70, un ritrovato senso dell’equilibrio e dell’attenzione alle strutture, un focus sui dettagli e una rinascita dell’intimismo. Alla produzione e presente anche nella scrittura del disco c’è Fred “Sonic” Smith, che non disdegna anche di imbracciare la chitarra (e il suo tocco alle sei corde, nitido, lo si sente eccome). Una scheggia, il buon auspicio per un nuovo inizio? Ahimé, no: dopo questo disco, Patti Smith si ritira ancora per lungo tempo, fino alla pubblicazione di Gone Again, quasi dieci anni più tardi.
6. “Trampin’” (2004)
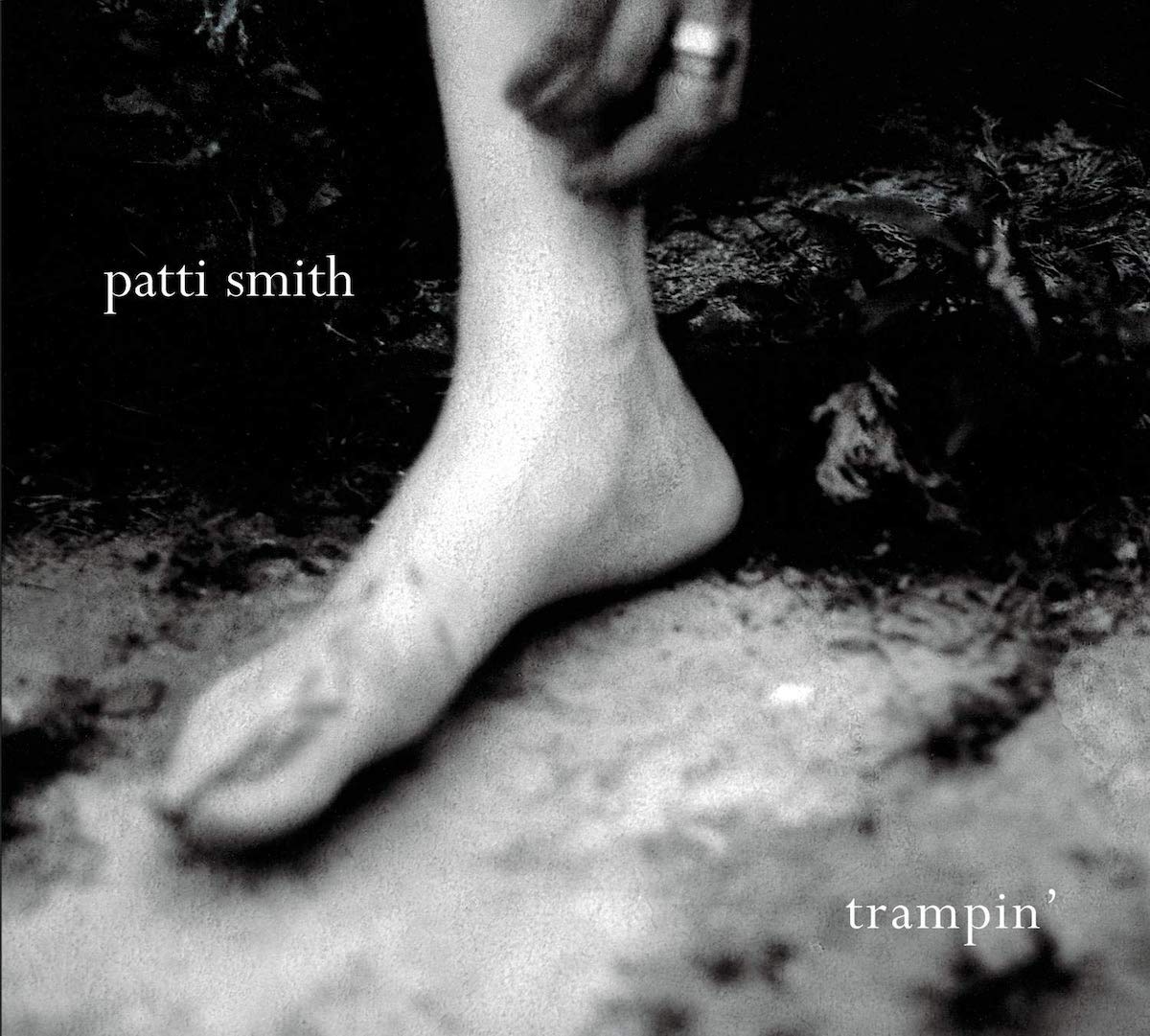
La ricerca della verità, il cammino dell’uomo lungo la strada della rivendicazione dei propri diritti: la vena politica è quella che emerge in questo disco, nel riflesso della costruzione di una società. Trampin’ è registrato in presa diretta, cattura l’essenza come da lezione del CBGB e morde i punti più nascosti della sensibilità umana quale dovere di ogni poeta. L’immediatezza non è tuttavia sinonimo di poco interesse verso un panorama sonoro ampio: dalla linea vocale che scorre su Gandhi alla chitarra distorta che introduce Stride of the Mind, compaiono le voci dei bambini di Radio Baghdad e il violoncello di My Blakean Year. La title track ha invece due protagoniste assolute: la voce di Patti Smith e il pianoforte della figlia Jesse Lee, a dar vita a una preghiera che affonda la sua ispirazione nel gospel, un inno. In questo disco, Patti Smith e la band si inoltrano nella tradizione nordamericana, seguendo la lezione di Woody Guthrie, ne catturano l’essenza, per restituire un’opera senza tempo e universale.
5. “Gone Again” (1996)
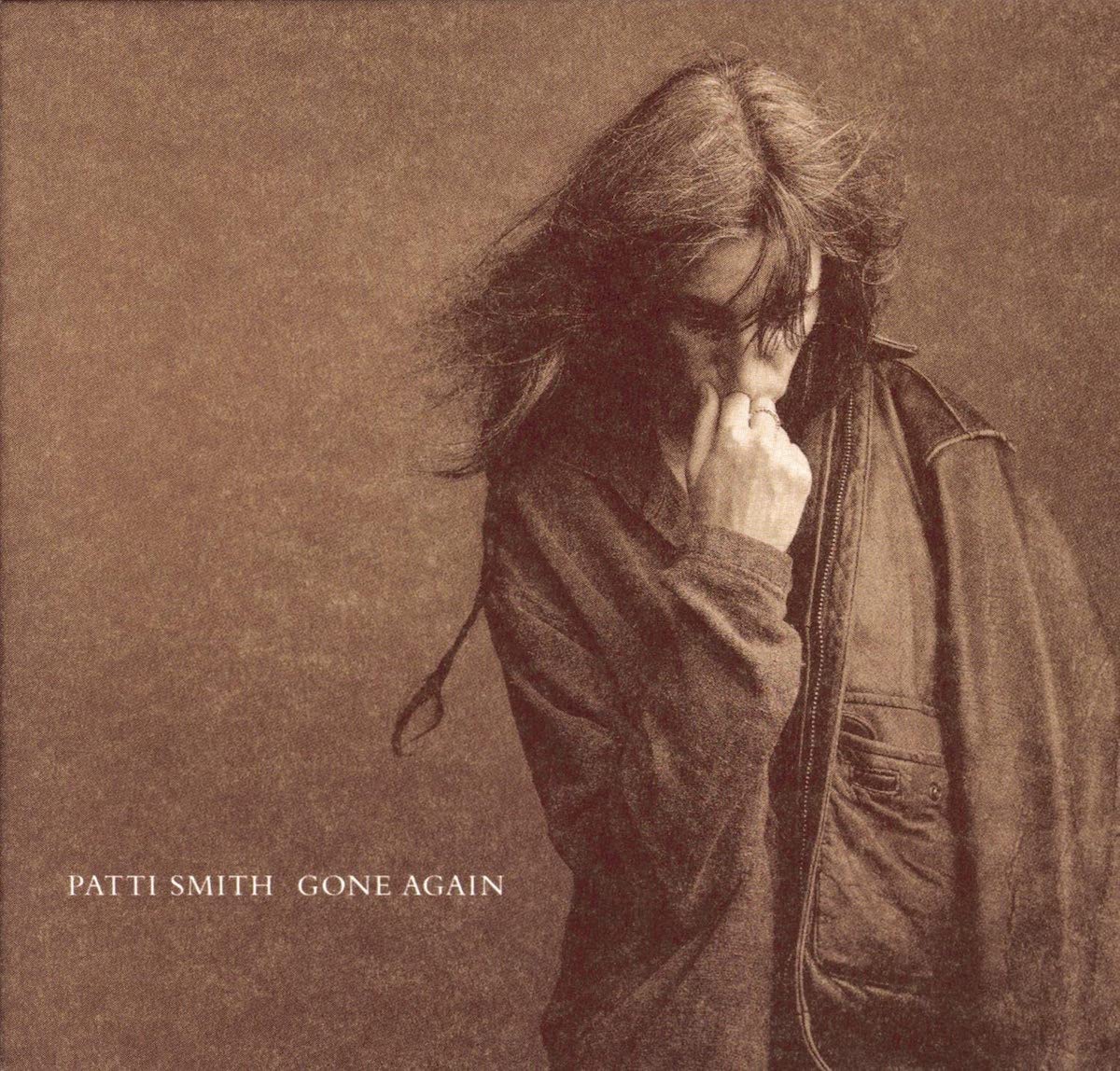
Nel 1995, dopo un lungo silenzio, Patti Smith ricomincia a suonare dal vivo, a tornare in contatto con il mondo dal quale si è ritirata. Un anno dopo, nasce questo disco. Aleggia nei versi e tra le trame melodiche il senso di perdita incolmabile che caratterizza la vita dell’artista, riflesso dei lutti recenti (il marito Fred, il fratello e Robert Mapplethorpe). Sarà un suo caro amico a illuminare la via, dedicandole le parole «continua la celebrazione della vita»: è Allen Ginsberg. La reazione alla tragedia non è un album di espiazione, bensì intriso di vita e Patti Smith la celebra come meglio sa fare, con la poesia: ecco dunque la perfezione di Gone Again, la chitarra acustica limpida che sorregge Dead to the World, a metà tra le ballate degli Appalachi e la devozione del gospel. Ogni verso scritto è ispirazione, la musica segue fedelmente il suono delle parole, rievoca emozioni solo sfiorate dai versi. Ecco un essere umano dalla consapevolezza acquisita si sfoglia strato dopo strato, l’intimità si mescola alle riflessioni sul presente, l’ottimismo santifica ogni dolore: questa è Patti Smith.
4. “Banga” (2012)

Gli otto anni trascorsi dal precedente album in studio (se si esclude Twelve del 2007, un disco di cover), Patti Smith non li ha certo passati con le mani in mano: si è dedicata ad altre forme d’arte, come la fotografia e il libro Just Kids. Con Banga torna all’essenza, poesia e musica si fondono, abbandonando le ruvidità degli esordi per acquisire una forma fluida e compatta ma non per questo meno vitale: il rock è addomesticato, ma vivo. Tra i musicisti, anche i due figli Jackson e Jesse, un cammeo di Johnny Depp e le chitarre di Jack Petruzzelli. E, tra le venature letterarie, la title track che si ispira a Michail Bulgakov, ma anche This Is the Girl, la ballata dedicata a Amy Winehouse e Maria alla Schneider, Patti Smith risale più lontano nel tempo, con Amerigo a riecheggiare il superamento dei confini da parte di Vespucci, l’abbracciarsi di diverse culture. I riferimenti colti sono innumerevoli e sparsi in tutto l’album, amalgamati con la spontaneità musicale. C’è anche una cover di Neil Young, After the Gold Rush.
3. “Wave” (1979)

Un addio, l’ultimo disco prima del ritiro di Patti Smith dalle scene per nove lunghi anni e che si apre con Frederick, la canzone dedicata al compagno d’arte e vita Fred Smith. Quando Wave viene pubblicato, una recensione di Rolling Stone ne evidenza la passione, il senso dell’epica che racchiude, la musica come vera e propria forza rivoluzionaria. Ed è proprio questa forza che emerge in tracce come So You Want To Be (A Rock’n’Roll Star), trascinata dalla chitarra di Lenny Kaye, per poi sfumare nel recitativo finale. Questo è anche l’album del languore di Dancing Barefoot, tanto quanto della storia narrata da Broken Flag, quella di Barbara Fritchie, la donna che sfidò i confederati durante la Guerra di secessione sventolando la bandiera dell’Unione. L’album ha avuto un successo modesto, eppure rivela il suo potere ascolto dopo ascolto.
2. “Easter” (1978)

È il terzo album di Patti Smith, prodotto da Jimmy Iovine. Se Till Victory riprende i toni abrasivi dei primi dischi, è subito percepibile dall’intro all’organo di Space Monkey e dalle evoluzioni vocali di Patti Smith che il disco punta a distaccarsi dai precedenti lavori. A prova di ciò, ecco Ghost Night e ancora la provocazione di Rock N Roll Nigger, l’inno agli outsider, la rivalsa dell’emarginazione iniqua con il suo attestato di sfida “Outside of society / Is where I want to be”. La canzone più trasmessa dalle radio e tramandata dalle generazioni nasce dal sodalizio Smith-Springsteen. È Because the Night che Springsteen le cede e che lei trasforma, monopolizzando ben presto le classifiche, dove rimane per cinque mesi, e la memoria collettiva.
1. “Horses” (1975)

Horses cattura l’essenza di un luogo, un’epoca e un’artista unica. Testimonia l’urgenza espressiva del punk-rock assorbita dal palco del CBGB e la la poesia della Beat Generation, le visioni del decadentismo francese e i sogni lisergici di Jim Morrison. Forme d’arte e di espressione antitetiche sono plasmate insieme in qualcosa di nuovo: i versi di Patti Smith si fondono con la musica da Gloria dei Them, sulla quale viene declamata una poesia, ai nove minuti di Birdland, in una sorta di performance improvvisate e virtuosismi che si innestano sull’immediatezza del punk. E in Elegie compare anche Allen Lanier dei Blue Öyster Cult alla chitarra.
Prodotto da John Cale, Horses non è una saetta improvvisa: quattro anni prima, Patti legge per la prima volta le sue poesie accompagnata da Lenny Kaye alla chitarra, ispirata e sostenuta da Allen Ginsberg e dalla scena culturale newyorchese, per pubblicare poi Piss Factory. Alla ricerca di una nuova forma espressiva, come già per Velvet Underground e Television, Patti Smith dà luce a un’opera limpida, colta, rabbiosa quanto basta. L’insegnamento dei grandi viene ripreso e scardinato, diventando storia, un manifesto del rock.