Oggi la musica è più che mai immersa nella sintesi, nella programmazione, nella tecnologia alla portata di tutti. Dirsi producer è semplice, avere una chitarra in un mix è quasi un’eresia, il sintetizzatore deve necessariamente farla da padrone, idem le batterie elettroniche. Sulla carta questa roba sembra evidentemente nemica del rock’n’roll, ma in passato anche insospettabili cantanti rock sono stati rapiti, affascinati, colpiti da questi strumenti e da questi suoni “peccaminosi”.
La lista è lunga (e comprende anche Robert Plant e Roger Daltrey, tanto per non farci mancare nulla), ma i risultati non sempre sono stati all’altezza o non sono stati adeguatamente compresi dai contemporanei. In questo articolo passiamo in rassegna dieci casi che, sia con infamia sia con lode, sono il simbolo di un grande cambiamento.
“McCartney II” Paul McCartney (1980)
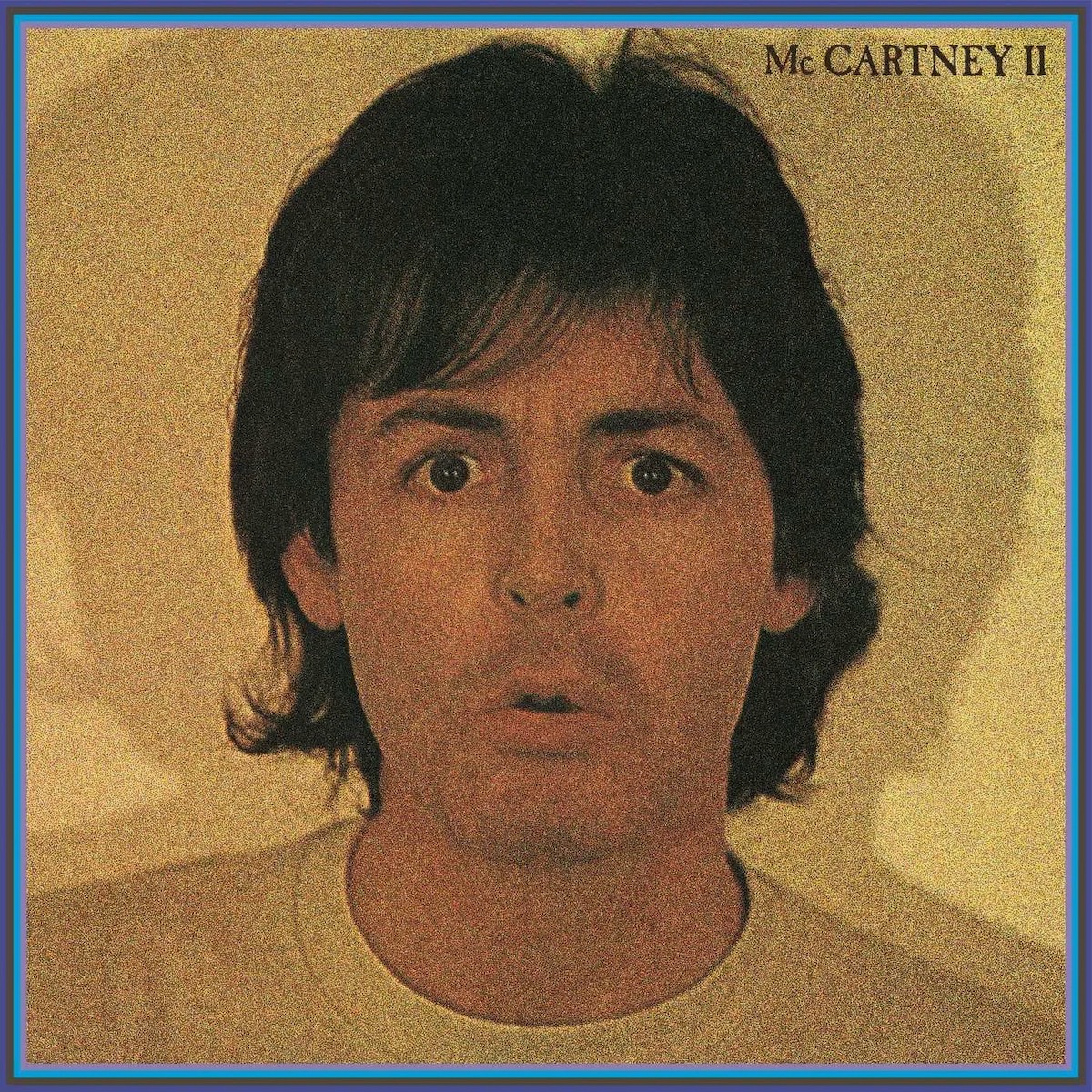
Tra i tanti rocker che hanno cambiato rotta verso il suono sintetico, Paul McCartney è stato forse il più coraggioso. In un momento di pausa dei Wings, che si scioglieranno a breve, scampato al suo secondo arresto per possesso di marijuana in Giappone, si chiude in casa e registra il secondo disco solista con le modalità del precedente: voci registrate in bagno, tutto suonato da lui e lui solo. Il sintetizzatore stavolta la fa da padrone trasformando Paul in un profeta dell’indietronica, ovviamente con quella weirdness che farà di McCartney II un disco di culto per una generazione di noiser alla ricerca di suoni elettronici storti e malandati. L’esperienza giapponese lo ispira per il pestone à la Human League Frozen Jap, che anticipa di un anno Computer Love dei Kraftwerk i quali senza dubbio si sono studiati la melodia a memoria. Il singolo Temporary Secretary, col suo arpeggiatore grottesco, ispirerà intere legioni di electroclasher diventando un classico della pista negli anni 2000. Secret Friend sembra un brano vaporwave. E pensare che all’epoca la critica massacrò l’album senza appello, volendo probabilmente punire Paul reo di abiurare al suo status di Beatle per abbracciare la contemporaneità, ovviamente interpretandola con il surrealismo psichedelico che lo contraddistingue, tanto da superarla (dichiarò di essere stato ispirato da Luciano Berio e solo per questa affermazione strabuzziamo gli occhi). Bisogna essere smemorati per non ricordare che proprio McCartney e i Beatles furono tra i primi a usare il sintetizzatore Moog nel pop. In Abbey Road molte manopole sono smanettate da McCartney, ed era solo il 1969.
“Bill Wyman” Bill Wyman (1982)

Dopo un ex Beatle, la controparte rollingstoniana. Anche se in questo caso nulla è dato per scontato. Bill nel 1982 è infatti ancora il bassista degli Stones, nonostante provi la sensazione di timbrare il cartellino per loro (non a caso mollerà baracca e burattini, anche se dopo secoli). Ma soprattutto ha trovato la sua dimensione da solista dopo il passo falso del moscio Stone Alone del 1976, dedicandosi anche alle colonne sonore. E forse è proprio durante la lavorazione dello score di Green Ice che le possibilità del sintetizzatore lo abbagliano (vedi il caso di Beach Chase, brano in cui questa macchina è fondamentale). Riconoscendo nella scena synth pop del periodo un vistoso collegamento con il rock’n’roll delle origini, decide di fare il salto di qualità comportandosi esattamente come McCartney: attacca il sintetizzatore, la drum machine e suona quasi tutto da solo. Il risultato è un grandissimo disco, trainato da due singoli micidiali come l’ironicamente autoreferenziale (Si, si) Je suis a rock star e la malinconica New Fashion, che suona come amara consapevolezza che i tempi cambiano e bisogna farci i conti. Wyman i conti li fa e alla grandissima, anche prevedendo delle tendenze: basti pensare a Seventeen, dove è come che prevedesse la generazione Instagram, il tutto condito da un arpeggiatore serpeggiante che sembra rispondere a quello di Temporary Secretary. L’album non otterrà lo stesso status di culto di quello di Macca, forse per la naturale propensione di Bill a fuggire i riflettori. Nonostante ciò, Wyman ci regalerà altri momenti sintetici entrati nella storia (basti pensare all’inquietante The Valley scritta per Dario Argento e il suo Phenomena). Nella storia però già c’era entrato con In Another Land, il suo contributo a Their Satanic Majestic Request, nel quale canta con voce filtrata da un tremolo che sembra proprio di un sintetizzatore.
“Trans” Neil Young (1982)

Il fatto che anche un rocker di razza come Neil Young si sia buttato nell’era del chip viene spesso dimenticato, per non suscitare l’imbarazzo della comunità dei sepolcri imbiancati rockettari. L’album della discordia è Trans, che è un florilegio di artificialità fuori dal comune dove Neil usa, per giunta, abbondanti dosi di vocoder. Il motivo di questo strappo con la tradizione non è solo dovuto all’esigenza di inserirsi nelle mode del momento, ma soprattutto esistenziale: il cantautore si ritrova infatti a dover comunicare con il figlio affetto da una malattia che gli impedisce di parlare, e in questo periodo rivede in maniera piuttosto massiccia tutti i propri valori estetico-linguistici. Ragion per cui Trans è forse il disco più “umano” di Neil, nonostante la freddezza che emana (basti ascoltare la dolcissima Transformer Man). E come in Computer Age, quest’epoca di dati digitali è tanto inquietante quanto fonte di soluzione per ogni incomunicabilità: la ripetizione è un modo per raggiungere il cuore anche senza parole, come nella praticamente proto Daft Punk We R in Control, tanto robotica quanto appassionata. Stilisticamente il disco cerca di mantenere un contesto rock – le chitarre – all’ interno di un contenitore “spaziale”, ispirato dichiaratamente ai Kraftwerk (a volte celebrati con micro citazioni) ma non a digiuno degli esperimenti hancockiani di Sunlight, nel quale il vocoder la fa da padrone. Bersagliato dalla critica all’epoca, anche Trans negli ultimi anni è stato rivalutato dalle nuove leve del “club alternativo”, cosa che rende giustizia all’intraprendenza dell’autore. Certo, i Crazy Horse ancora si mangiano le mani al pensiero di essere stati sostituiti dalle macchine, ma tant’è…
“Clues” Robert Palmer (1980)
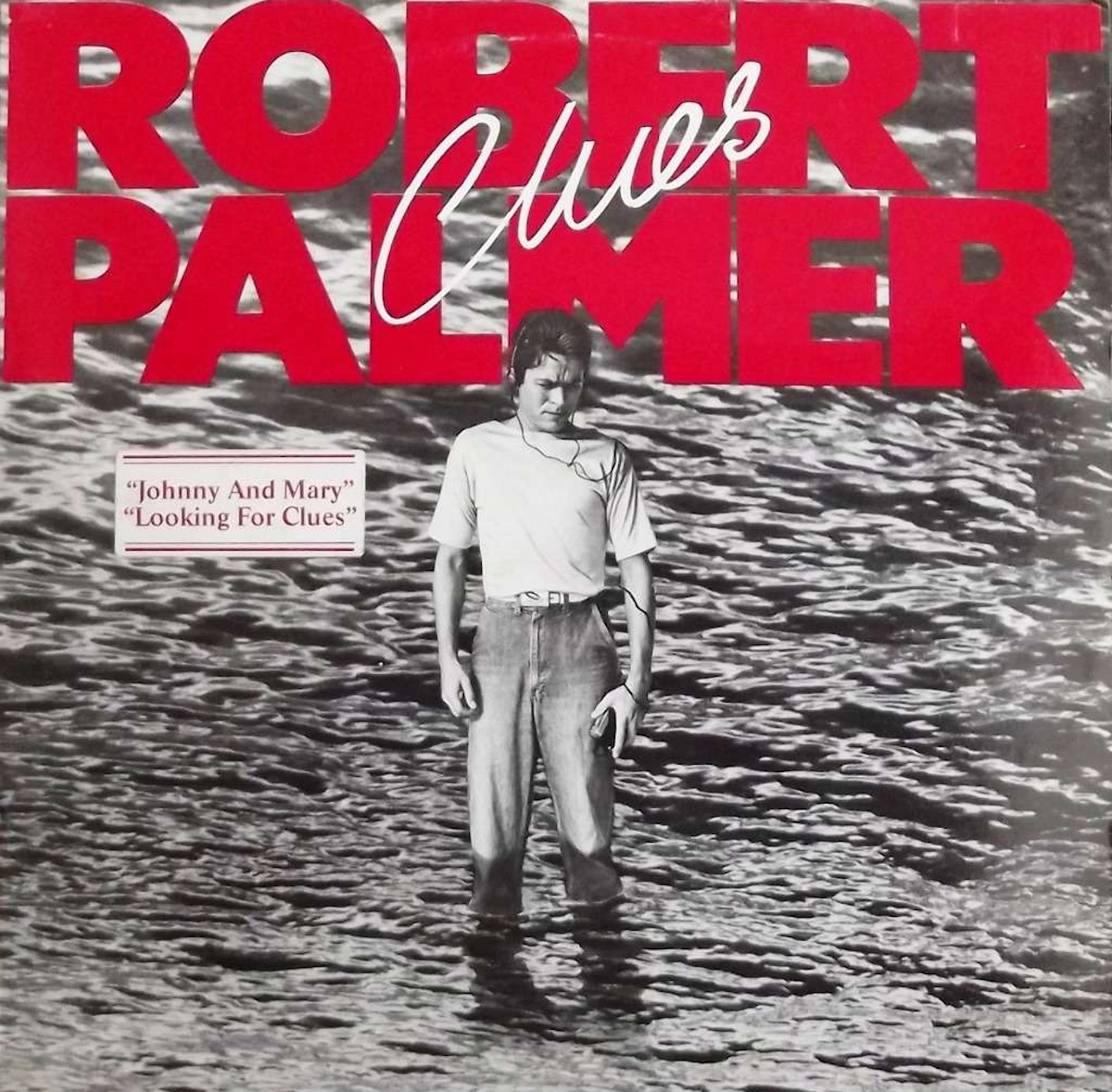
Un altro insospettabile rockettaro che fino al ’79 non mollava di un millimetro e nel 1980 se ne esce con un album per il 95% synth pop, tanto da coinvolgere la star sintetica per eccellenza del periodo, ovvero Gary Numan che presta tastiere e idee. I due scrivono insieme Found You Now e Palmer omaggia l’autore di Cars con una cover di I Dream of Wires. Le altre tracce non sono da meno, basti pensare a Looking for Clues, uno dei primi video singoli trasmessi da MTV, e soprattutto al classicone Johnny and Mary, una megaballata synth pop che pur non sbancando negli Stati Uniti diventerà un best seller dopo esser utilizzato negli spot delle automobili Renault. Oltre a Numan ci sono Chris Frantz, batterista dei Talking Heads a fare una comparsata di kick drum, e come ingegnere del suono Alex Sadkin, poi responsabile del sound dei Duran Duran di Seven and the Ragged Tiger. Palmer continuerà a battere sul chiodo del genere anche nel successivo Maybe It’s Kive, un disco ibrido dal vivo/in studio che cerca di unire la vecchia anima rock con il suo nuovo credo, con Gary Numan co-autore di una micidiale Style Kills che profuma di new wave. Nonostante Pride dell’83, nel quale Palmer flirterà ancora una volta con i sintetizzatori e le batterie elettroniche, alla lunga sarà il rock a vincere, soprattutto venato di funk (come nell’esperimento Power Station con Andy e John Taylor dei Duran e il batterista degli Chic Tony Thompson), ma sempre più tecnologizzato, digitale, plasticoso, segno che qualcosa è rimasto.
“Izitso” Cat Stevens (1977)

Ma come, anche Cat Stevens si è dato alle macchine? Non solo, si spinge così oltre che quasi anticipa l’electro. Siamo nel 1977 e Was Dog a Doughnut? è a tutti gli effetti uno dei primi brani techno pop della storia, con una serie di pad assurdi e uno dei primi sequencer che quasi sembra uscire dal catalogo della Mute Records, mentre Crazy starebbe bene nel repertorio degli Erasure. Il disco nasce come “sfregio” alla sua casa discografica, che dopo la pubblicazione dello sperimentale Numbers mette Stevens di fronte a un aut aut: o fai un disco che vende o te ne vai a casa. Bene, il cantante a quel punto registra Izitso e va bene dal punto di vista commerciale, lasciando di stucco tutti. Mentre i discografici si fregano le mani pensando a nuovi album e nuovi successi, Cat Stevens decide di abbandonare il patrigno e malfidato music biz abbracciando l’Islam. Per onorare (o meglio, per disonorare) il contratto discografico lascerà ai posteri il disco Back to Heart che è un ritorno alle chitarre acustiche e sarà un flop.
“Building the Perfect Beast” Don Henley (1984)

Anche per il cantante/batterista storico degli Eagles gli anni ’80 impongono un riposizionamento. Se l’esordio solista del 1982 è caratterizzato dalla presenza di synth ben piazzati e un mood che ricorda il post disco (vedi la stoccata contro i mass media Dirty Laundry), siamo ancora nel terreno del rock, seppure adult oriented. Nel 1984 Henley pubblica Building the Perfect Beast, creando le basi per l’hypnagogic pop: la hit The Boys of Summer è uno dei brani simbolo per molti artisti del genere, nonché una pietra miliare del synth pop più plasticoso. E da solo traina un album che all’epoca viene osannato da critica e pubblico, nonostante oggi non sia ben chiaro il perché: soprattutto dai fan degli Eagles, che vedendolo tra i 100 migliori dischi degli anni ’80 secondo Rolling Stone sentono cedere i bypass. Di sicuro è un disco programmato in ogni centimetro, tra sezioni ritmiche digitali e tappeti sintetici, tra i quali quelli messi a punto dal grande cantautore Randy Newman nella caustica Sunset Grill, polemica sulla vita urbana, così come quelli sciorinati in All She Wants to Do Is Dance, che si spalmano su una ritmica artificiale tipicamente dance e ottenuti con un preset del famoso Yamaha DX7 (l’autore Danny Kortchmar era uno dei primi a possederne uno). Per non parlare della title track, con dei fiati sintetici che sanno tanto di abiura ai bei tempi che furono e che ascoltati oggi sono davvero weird, tanto da sfiorare l’imbarazzante. Eppure forse è questo che rende Building the Perfect Beast un disco riuscito: che se ne parli male o se ne parli bene, comunque ne stiamo parlando.
“Radio K.A.O.S.” Roger Waters (1987)

Anche il vecchio duro e puro Roger Waters è cascato nel trappolone del synth pop? Ebbene sì, con la sua risposta ai suoi ex compagni di viaggio, i Pink Floyd. Che nel 1987 se ne escono con il digitalissimo A Momentary Lapse of Reason, ma mantengono ancora una scarpa nel loro passato di rock psichedelico. Waters invece no, cambia rotta e anzi gli da giù di Fairlight e di E-mu, usando campioni a più non posso soprattutto per quanto riguarda la batteria, che chiamare finta è un eufemismo. C’è anche l’utilizzo di un sintetizzatore vocale che è tanto un espediente per entrare nella narrazione (il disco narra la storia di Billy, un ragazzo disabile impossibilitato a parlare che con le sue capacità telepatiche si collegherà a una radio di L.A. mandando un ordine a tutte le basi missilistiche del pianeta di modo da distruggerle tutte in un sol colpo) quanto uno strizzare l’ occhio a un tipo di estetica synth pop. Tutte le canzoni sono sepolte sotto una patina artificiale e a volte quasi hi-nrg. Waters poi rivelerà che il pacchetto completo è stato frutto di un errore di calcolo. Voleva spingere su un suono moderno e contemporaneo, ma gli è sfuggito tutto di mano, tanto che si vergogna ancora oggi della produzione, che in effetti non gli ha giovato neanche a livello commerciale. A riascoltarlo oggi però è indubbio che sia un album quantomeno curioso, e probabilmente uno dei primi tentativi di pop hd della storia.
“How Old Are You?” Robin Gibb (1983)

Ve li ricordate i Bee Gees del primo periodo rock/soul? Ve li ricordate quelli disco rock de La febbre del sabato sera? Robin Gibb in questo disco solista li spazza via in un sol colpo, prendendo la strada maestra del synth pop senza riserve. Il singolo di traino Juliet ha fatto sognare un’intera generazione di adolescenti ignari, che dalle radio sentivano questa suadente ed energica ballata che di umano aveva solo il falsetto, marchio di fabbrica di Gibb e dei Bee Gees. Quando esce il disco, i Bee Gees sono in piena crisi: Living Eyes del 1981 è andato male, la band è confusa. Si rifanno con la partecipazione alla colonna sonora di Stayin’ Alive, il sequel di Saturday Night Fever con la regia di Stallone, in cui virano verso sonorità più elettroniche. Robin è quello che le interpreta meglio: in Danger sembra di vedere i Soft Cell in azione, la title track ha un beat potente innaffiato di synth, Don’t Stop the Night è un perfetto inno techno-pop che sembra uscire dalla penna degli Yazoo. È un album perfettamente in linea con i tempi, senza cadute di stile, ma anzi con un’atmosfera che in un certo senso è new romantic. Tanta perfezione tematica e sonora non è stata ben accolta nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Ha invece un certo seguito in Europa e soprattutto, manco a dirlo, in Germania dove il pubblico era attento a certe sonorità “automatiche” e lo premierà col piazzamento nella top 10.
“Homosapien” Pete Shelley (1981)
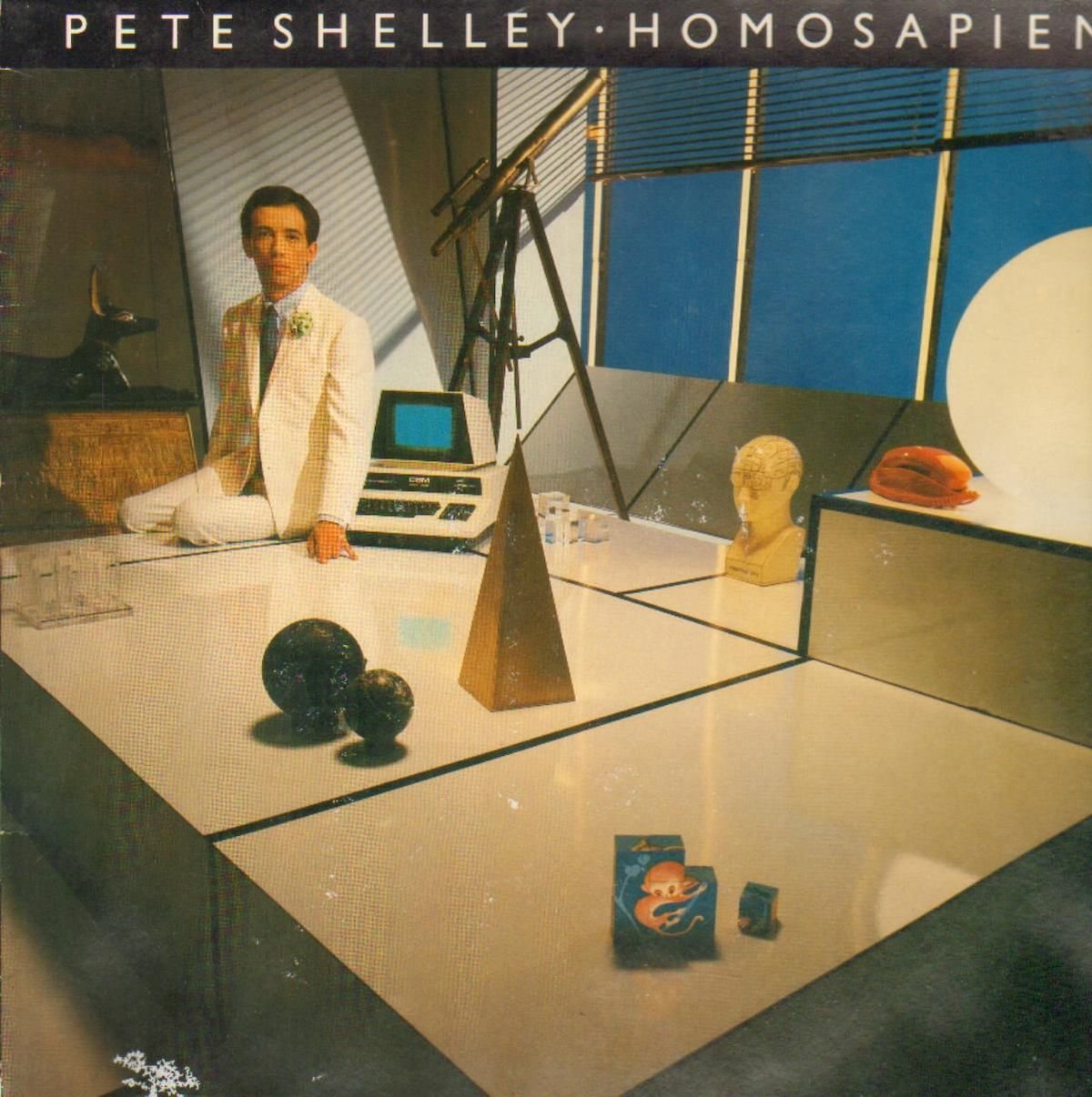
C’erano una volta i punk-rocker Buzzcocks: poi arrivarono i sintetizzatori. Potremmo raccontare la genesi di Homosapien in questo modo, con il leader Pete Shelley che, chiuso in studio con il produttore Martin Rushent, cerca di comporre qualcosa per ritirare su la band, all’epoca incapace di lavorare su un nuovo album e priva del sostegno finanziario della casa discografica. La situazione sembra disperata, ma mentre i due scrivono il materiale si rendono conto che il sound sta prendendo una piega molto diversa dai Buzzcocks: drum machine e sintetizzatori sono centrali, le cose non saranno più come prima. Ragion per cui Shelley decide di mollare il gruppo oramai agonizzante per buttarsi in questa nuova avventura che di rock non ha più nulla. Si fa ritrarre in copertina con un Commodore Pet, uno dei primi home computer tanto per sottolineare che il passato è lasciato alle spalle. Non era la prima volta che Pete armeggiava con l’elettronica. Il suo esordio da solista Sky Yen del 1980 era un viaggione drone registrato addirittura nel 1976 che spiazzò tutti e che negli anni è diventato un vero cult. Anche Homosapien ora gode di un certo rispetto, ma ancora deve essere considerato uno dei migliori album synth pop in assoluto degli anni ’80. Non c’è un riempitivo, va ascoltato tutto di un fiato per godere del suo sound dirompente. Anche perché Rushent diventerà, subito dopo, l’ artefice del successo degli Human League di Dare. Human League che, senza il precedente di Homosapien, potevano tranquillamente cambiare mestiere e andare a vendere bibite.
“Mr. Bad Guy” Freddie Mercury (1985)
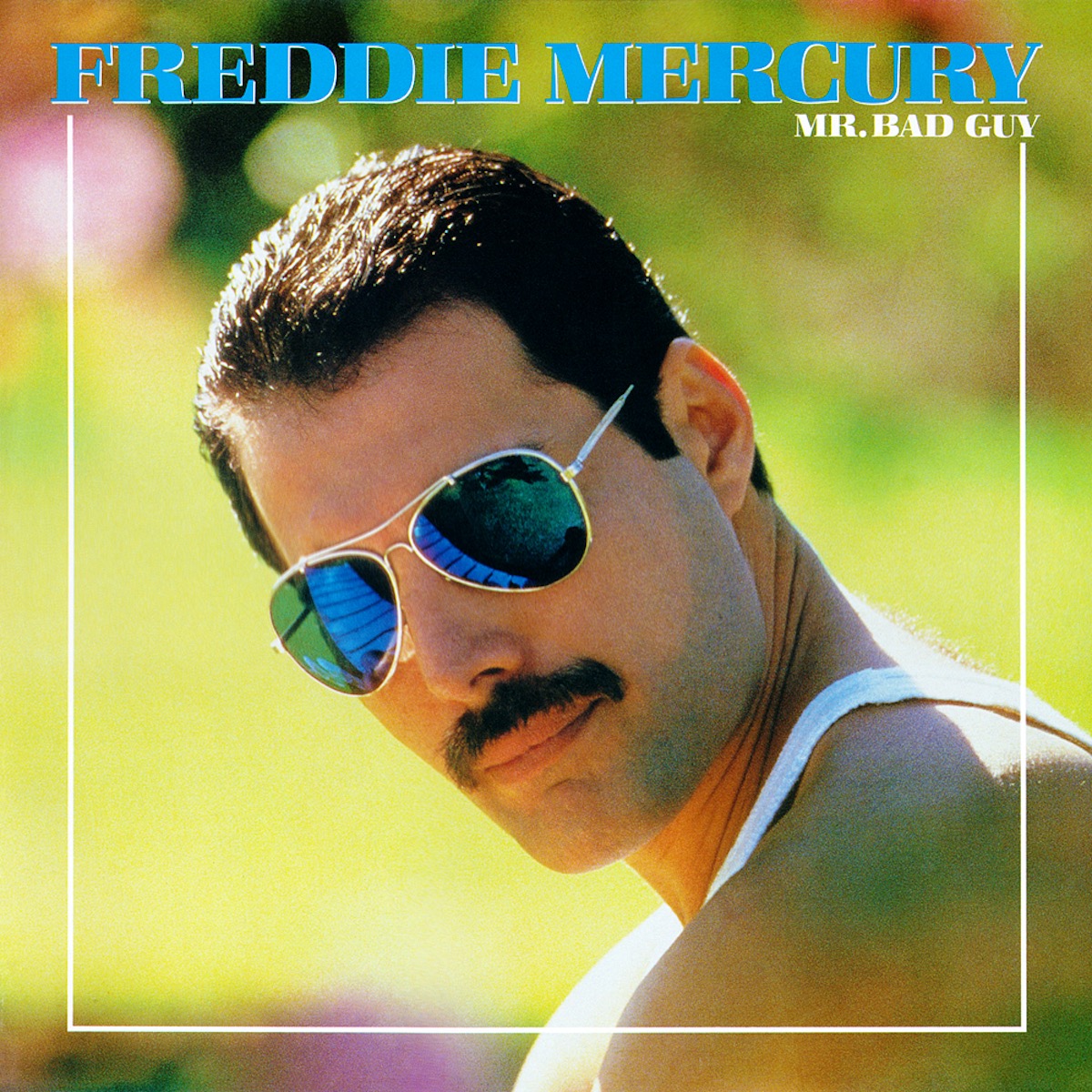
Ve li ricordate i Queen di Hot Space? Se sì, complimenti: l’ album in questione è quello che i fan vogliono cancellare dalla storia e che spesso si rivendono ai mercatini poiché il tasso di hard rock è veramente basso, anzi quasi inesistente. La fanno da padrone i sintetizzatori e un certo piglio funk, roba piuttosto estranea ai Queen che conosciamo, ma l’insieme, per il genere, è tanto consistente che Michael Jackson prende ispirazione a piene mani per comporre Thriller. Mercury è quello che più spinge i Queen in certi territori synth pop, ma la band fa muro dopo l’esperienza. A questo punto il cantante decide di sperimentare da solo. Inizialmente collaborando nel 1984 con Moroder per la sua Love Kills, contenuta nella colonna sonora della versione restaurata del Metropolis di Lang, e poi in questo suo primo album solista pieno di ambizione, alla ricerca del capolavoro. E se pensiamo alla scrittura o al tiro dell’epica Living on My Own o la neoclassica I Was Born to Love You creata con Fairlight e Synclavier, effettivamente poco ci manca. Peccato che il pubblico non sarà dello stesso avviso, trasformando quella che doveva essere la consacrazione solista del Mercury sintetico in un flop. Resosi conto del probabile effetto boomerang e impossibilitato a dare tutte le sue energie al progetto, vista la militanza nei Queen, il cantante decide di non ripetere più l’esperimento, se non con singoli brani (vedi la cover The Great Pretender, che nel 1987 sarà un successo). D’altronde se erano proprio i Queen a scrivere “No synthesizers” nei crediti dei loro dischi e il risultato è quello che conosciamo, allora è proprio vero. Quelle macchine infernali non puoi buttarle fuori dalla finestra perché ti rientrano dalla porta: quella MIDI, s’intende.
















