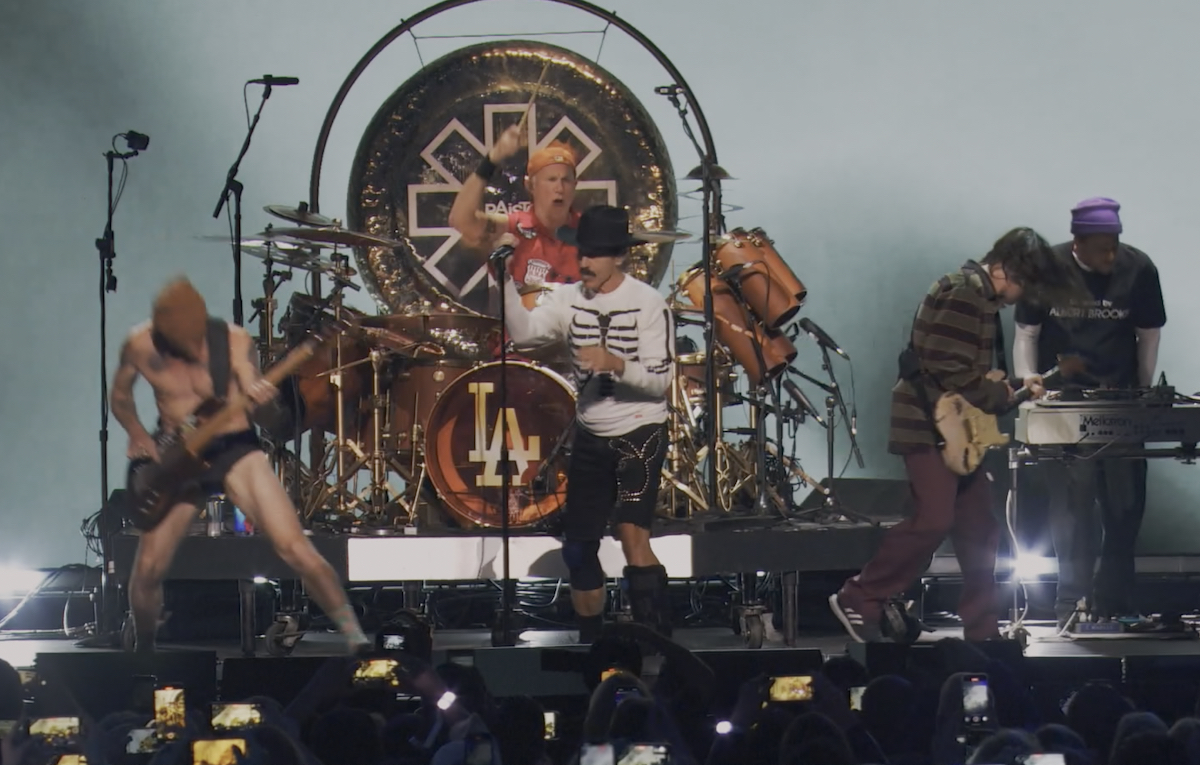Alzi la mano chi, dopo il botto planetario di Dookie, avrebbe predetto una carriera così sfavillante per Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt e Tré Cool. E invece, dopo quello che pareva il colpo della vita – avere letteralmente il disco giusto al momento giusto – i Green Day sono ancora qui, 30 anni più tardi, pronti a riempire stadi e arene in tutto il mondo e con (ancora) più capelli in testa di chi sta scrivendo questo pezzo. Non solo: il colpo della vita, ai Green Day, riesce addirittura due volte. Quando la loro parabola pareva terminare, con l’onda lunga del successo di Dookie ormai esaurita, ecco che il trio tira fuori American Idiot, un disco che dona alla band una seconda giovinezza e un ritorno di popolarità all’epoca totalmente inaspettato.
Tutta la carriera del trio si gioca sull’idea del cambiamento come una costante, a volte per scelta, a volte per necessità. È paradossale, perché i detrattori del punk-rock spesso accusano il genere di essere sempre uguale, tre accordi e via, e invece i paladini indiscussi di questo stile hanno messo in mostra, musicalmente parlando, più cambi d’abito di una maratona di Brachetti. L’ultimo disco in ordine di tempo è Saviors. Per Billie Joe e soci è un disco che definisce la loro carriera, alla pari di Dookie e American Idiot: beh, questo lo dirà il tempo. Qui ci siamo limitati a stilare una classifica – dal peggiore al migliore – di tutti dischi in studio del trio, escludendo i side project come Pinhead Gunpowder o Network.
Buona lettura, ci prendiamo a testate nei commenti.
Father of All Motherfuckers
2020
La cosa migliore di questo disco è la durata: fortunatamente la tortura dura meno di mezz’ora. Nonostante questo, i 26 minuti di Father of All Motherfuckers risultano paradossalmente più lunghi di un disco prog fatto da vecchi scoreggioni boriosi. Dopo l’ottimo ritorno di forma fatto segnare dal precedente Revolution Radio, i Green Day optano per un sound più rock’n’roll, ma allo stesso tempo più artefatto, sovrapprodotto, plasticoso. La voce perennemente effettata, una generale inclinazione al pop intesa nel senso peggiore del termine (non immediato, ma paraculo) e certi pezzacci che ricordano le cose più brutte dei Good Charlotte (e dire che ne han fatte di robe brutte i fratelli Madden) rendono questo album il peggiore del trio. Billie Joe, Mike e Tré hanno costruito le proprie fortune su una continua ricerca di nuove direzioni, senza mai perdere la propria identità: in questo disco, spesso, si fatica a riconoscerli. L’ultimo chiodo sulla bara è rappresentato dalla copertina, una roba di rara bruttezza.
39/Smooth
1990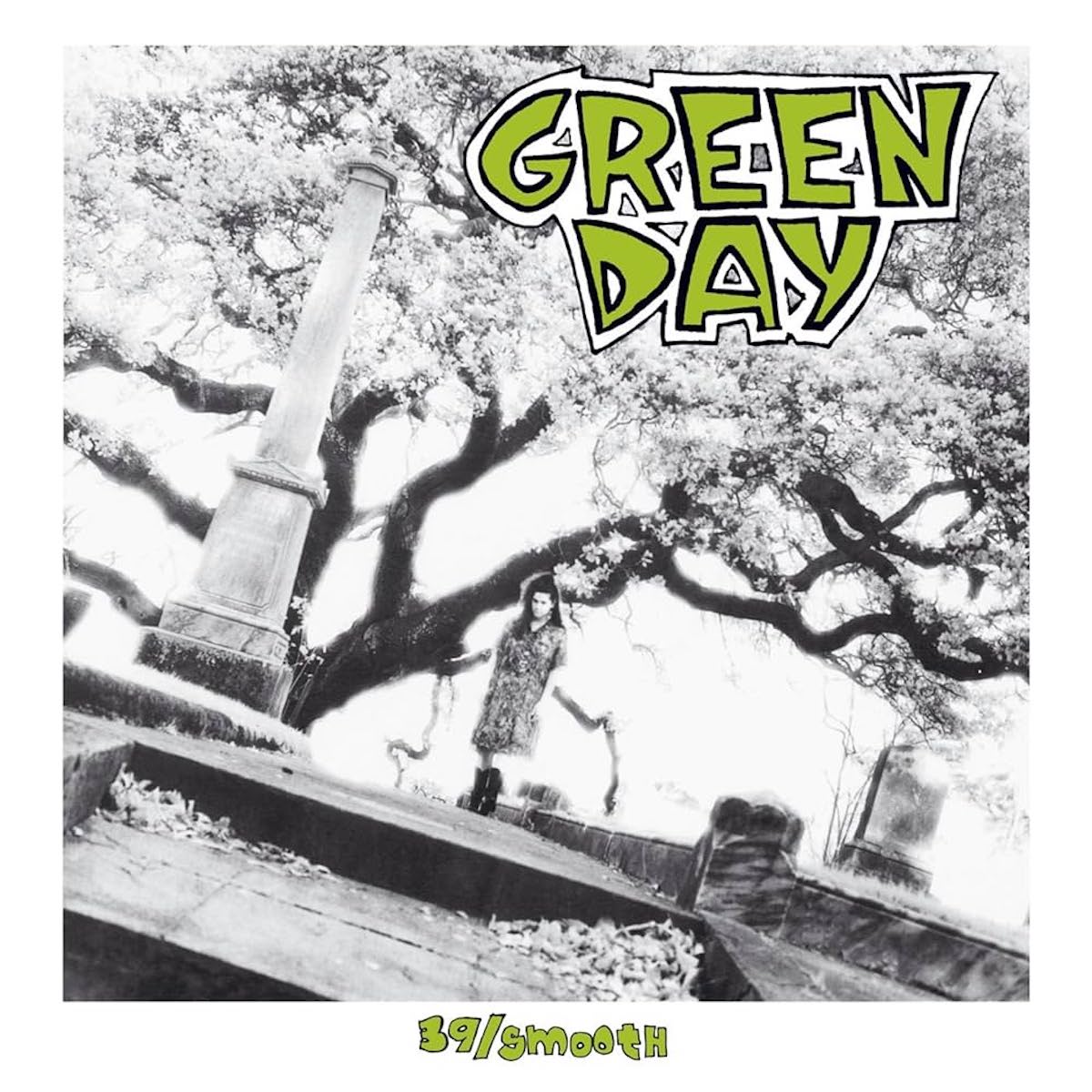
Da qualche parte bisogna pur cominciare e il viaggio dei Green Day principia proprio da qui. Primo album della band, è l’unico con John Kiffmeyer (noto anche come Al Sobrante) alla batteria, che verrà poi sostituito da Tré Cool. La scrittura è acerba, ma già lascia intravedere quello che si svilupperà nei due dischi successivi, Kerplunk e Dookie, entrambi figli di un netto incremento in termini di produzione, che aggiungeranno progressivamente lo smalto e il mestiere in grado di trasformare il trio in un fenomeno planetario. Smalto che manca invece in questo simpatico dischino, che suona da schifo. No, non nel senso puro e romantico del punk, dove fare schifo può anche essere un valore. Le chitarre non hanno dinamica e la batteria pare un barattolo di pomodoro, con l’intero album che pare registrato dentro a una pentola a pressione. At the Library è un gran bel pezzo di apertura e Goin’ to Pasalacqua a volte ritorna nella scaletta dei concerti della band, segno che il disco non è stato dimenticato né dai fan, né dagli stessi Green Day. Così come il successivo Kerplunk, anche questo lavoro esce su Lookout! Records, già casa di band di culto come Screeching Weasel, Queers e Operation Ivy, dal cui nucleo prenderà vita un’altra formazione che ha enormemente aiutato a portare il punk-rock nel mainstream, i Rancid. Se per un motivo qualsiasi (zio d’America, incredibile allineamento degli astri, casuale botta di culo) siete in possesso della prima stampa del disco in vinile nero, sappiate che avete a casa un piccolo tesoretto.
Uno... Dos... Tré!
2012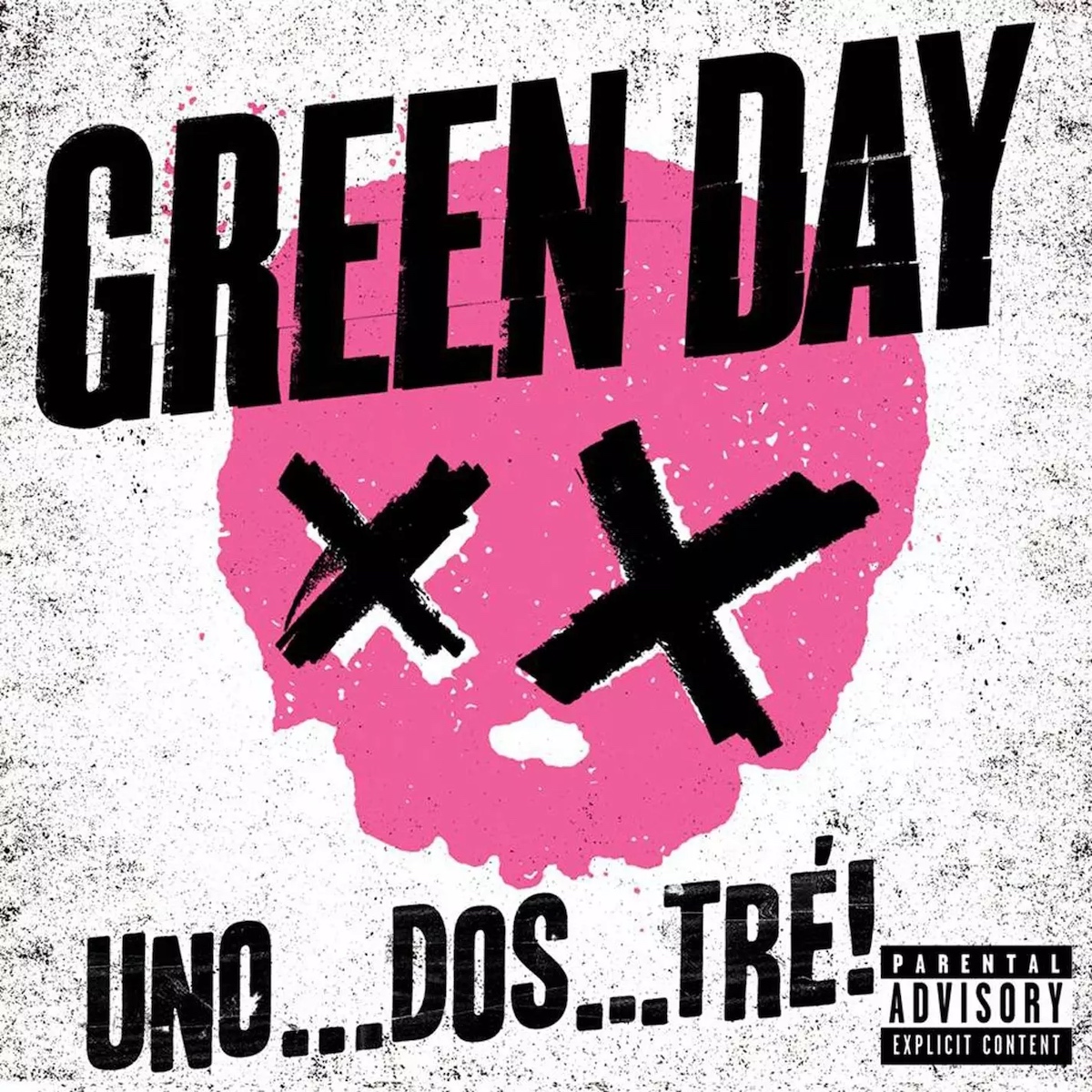
Ok, questi ve li beccate così, tutti assieme: perché in un mondo più giusto, di questi tre dischi ne sarebbe uscito uno solo, un insieme delle tracce migliori. Terminata la rincorsa alla rock opera che ha accompagnato la rinascita commerciale e mediatica della band nei primi anni 2000, i Green Day scelgono di tornare a fare quello che facevano a inizio carriera: one-two-three-four!, tre accordi, chitarra distorta, linea di basso assassina e Cool che picchia come un fabbro. Tutto bello, peccato che non sia andata proprio così. I tre, forse ancora in totale ego trip da (ritrovate) rockstar, pubblicano tre dischi in tre mesi, ¡Uno!, ¡Dos! e ¡Tré! (poi raccolti nel box set Uno… Dos… Tré!), con ogni album che ottiene il non invidiabile risultato di venire sbertucciato sia dalla critica che dai fan. Ancora una volta è il focus a mancare, con una valanga di canzoni che sembrano buttate lì più per far numero e non perché la cosa abbia realmente qualche tipo di senso. Ed è un peccato, perché scavando nella trilogia le perle non mancano, anzi: Lazy Bones ha l’appeal dei bei tempi andati, Stray Heart è la dimostrazione che i ragazzi sono ancora capacissimi di scrivere perfetti brani pop, Amanda è l’ennesima puntata perfetta su questa storia d’amore andata a male. Di Kill The DJ, invece, meno ne parliamo e meglio è.
21st Century Breakdown
2009
Un’ora e dieci. Un’ora e venti se comprate l’edizione deluxe con tanto di cover di Who e Social Distortion. Se riuscite a sentirlo tutto dall’inizio alla fine siete degli eroi. Oppure siete i Green Day in pieno ego trip. Che è quello che è successo ai ragazzacci americani dopo lo stratosferico e inaspettato successo dell’idiota a stelle e strisce. Il disco esce a cinque anni di distanza dall’album che li ha rimessi in cima alla catena alimentare del pop-punk, il lasso di tempo più grande mai intercorso fra un’uscita e un’altra in tutta la loro carriera. Capiamoci, non si tratta di un disco brutto: traccia per traccia quasi ogni pezzo risulta godibile, ma il giochino della rock opera questa volta riesce meno bene, molto meno bene. Meno a fuoco e accompagnato da un senso di pretenziosa grandeur che si traduce in una serie di inni da stadio: del resto la loro dimensione era tornata ad essere quella. Privi dello storico produttore Rob Cavallo, i Green Day chiamano in cabina di regia una vera e propria icona degli anni ’90, quel Butch Vig che condusse i Nirvana alla realizzazione di un certo Nevermind: l’ambizione davvero non mancava, ma il risultato finale rimane dolceamaro.
Saviors
2024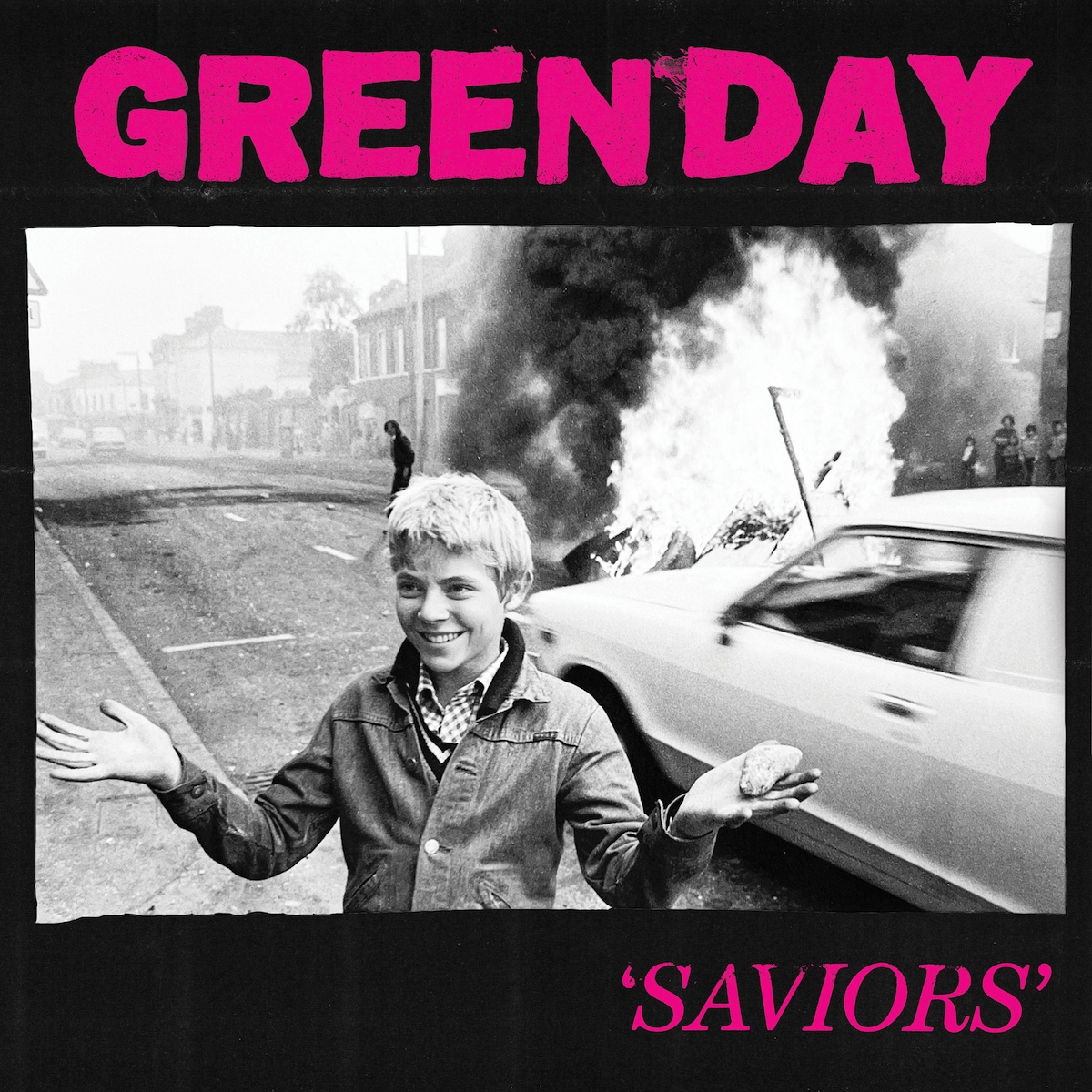
Quattordicesimo disco ufficiale per il trio di Berkeley. Mettiamola così: fare peggio del precedente – che non a caso trovate all’ultima posizione di questa classifica, sperando che ci rimanga a lungo – era semplicemente impossibile. Il disco è una sorta di bignami di tutta la carriera della band: dal commento politico (The American Dream Is Killing Me) al brano spacca arena per far partire il singalong collettivo (il bel singolo Bobby Sox, che ricorda le cose migliori degli Weezer), dal pezzo vecchia maniera di puro punk-rock (Look Ma, No Brains) per chiudere con uno dei piatti forti della casa, la ballatona radiofonica (Father to a Son, davvero riuscita). Manca, forse, l’elemento sorpresa, ma quanti altri gruppi riescono ad essere sorprendenti a questo punto della loro carriera? Se non altro ci siamo risparmiati certi esperimenti pseudo danzerecci che avevano caratterizzato alcune produzioni precedenti, hai detto niente. Per il resto, il disco fila via liscio, senza intoppi o cialtronerie, motivo per il quale lo trovate a metà classifica.
Revolution Radio
2016
Ciao Green Day, che fine avevate fatto? Dopo l’opulenza ridondante del 21esimo secolo e la sbornia caotica della trilogia eccovi di nuovo a fuoco, di nuovo voi. Il disco segna, in estrema sintesi, un ritorno di forma per i tre. Nuovamente a fuoco, senza particolari nemici, senza la rincorsa continua all’inno da stadio e con un Billie Joe appena uscito dal rehab. Dopo aver accolto in studio il chitarrista Jason White (che da anni li segue dal vivo e che, con Billie Joe, condivideva il side project Pinhead Gunpowder), i californiani tornano a registrare come un trio: il risultato è un disco riuscito, senza orpelli, che non stupisce, ma che contemporaneamente non delude davvero. Smessi i panni dei commentatori politici, i Green Day tornano a fare quello che sanno fare meglio: infilare una dietro l’altra una serie di canzoni pronte a prendere casa nelle vostre orecchie dopo il primo ascolto. Che non significa chiudere gli occhi rispetto a ciò che succede attorno (il riuscitissimo singolo Bang Bang affronta il tema delle sparatorie di massa), ma alleggerirsi di quella pomposità posticcia che aveva accompagnato il breakdown del secolo. Un brano come Outlaws, forse, avrebbe meritato maggior attenzione. Bravi, ben ritrovati.
Kerplunk
1991
Se Dookie esiste, è grazie a questo album qua. Ancora acerbo nei suoni, ma decisamente meno in termini di songwriting, si tratta dell’ultimo album dei Green Day come gruppo indipendente e il primo con Tré Cool alla batteria. Nonostante la generale ruvidezza della registrazione, il disco risulta enormemente più riuscito e sofisticato dell’esordio. Le caratteristiche che diverranno il marchio di fabbrica e di successo del trio californiano sono già tutte qui: le melodie irresistibili, i ritornelli che ti si piantano in testa, i brani eseguiti a rotta di collo, le rullate perfette che accompagnano ogni brano. Un pezzo come 80 lascia intuire come il successo mondiale che arriverà da lì a breve sia tutt’altro che casuale. Il disco contiene la prima versione di Welcome to Paradise, un classico all’interno del catalogo del gruppo che verrà ri-registrato due anni più tardi al momento dell’esordio su major: ascoltare le due versioni una accanto all’altra dimostra nel modo più limpido e immediato lo scarto che esiste fra i due mondi (indipendente e major) in termini di pura produzione. Qualcuno dirà che il vero punk (che palle!) è proprio questo e forse ha anche ragione. Sono i Green Day ad esser altro, fortunatamente.
Insomniac
1995
Tutti, da qualche parte, hanno un gemello cattivo. Insomniac è, in buona sostanza, il gemello cattivo di Dookie. Più che un disco, trattasi di un vaffanculo di 32 minuti e 49 secondi rivolto a critici, colleghi e, più in generale, a tutti coloro che non hanno ben digerito l’über successo del precedente Dookie, figlio dell’approdo su major label e quindi del tradimento dell’etica e dell’indipendenza del vero punk. Fra questi, il 924 Gilman Street, music club di Berkeley che mise al bando i Green Day il giorno dell’uscita di Dookie e al quale il trio ha dedicato 86. Tutto il disco ha un tono più scuro e meno giocoso rispetto a quanto la band aveva messo in mostra fino a quel momento, ma non per questo è da buttare. Bellissima la copertina, una leggera rivisitazione della composizione God Told Me to Skin You Alive di Winston Smith, già apparsa parzialmente nelle note di un vecchio disco dei Dead Kennedys, Plastic Surgery Disasters. Brain Stew, costruita su un mid tempo completamente inedito (allora) per la band, rimane una delle composizioni più creative e originali della band, e non a caso, a quasi 30 anni dalla pubblicazione, trova ancora spazio nella scaletta dei concerti. Finirà per vendere meno della metà del precedente: non è un brutto disco, semplicemente non è Dookie perché non poteva esserlo.
Warning
2000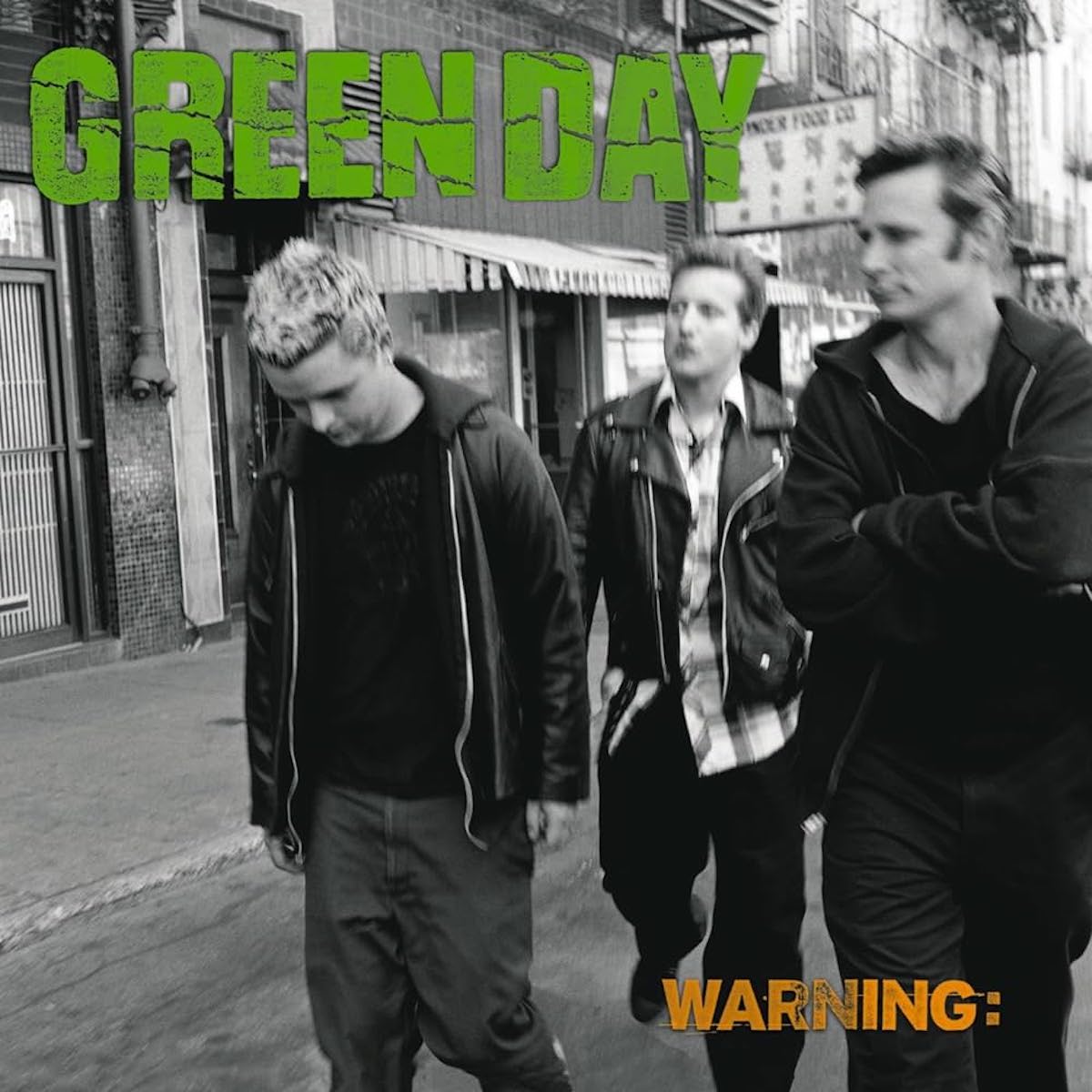
I Green Day entrano nel nuovo millennio tentando il cambio di suono: via il pop-punk che tanto successo ha portato loro ma che pare non tirare più (con ogni disco post Dookie che fa registrare sempre meno vendite del precedente) e dentro il power pop e il folk, con un approccio generale più disteso oltre a un’ampia implementazione di strumenti acustici. Commercialmente è un altro flop: si tratta del primo disco su major che – al momento dell’uscita – non arriva neanche al milione di copie. Il nu millennio ha portato con sé anche un altro trend, quello del nu metal e le parti alte delle classifiche – per anni casa del trio californiano – vedono oggi alloggiare Korn, Limp Bizkit e altri inquilini simili. Sticazzi, perché questo è un gran disco, dove ancora una volta i ragazzi si reinventano alla ricerca del successo perduto. Blood, Sex and Booze è un incubo sadomaso dove i Green Day ritentano la carta della marcetta in stile Hitchin’ a Ride, Misery potrebbe essere la colonna sonora di un mafia movie di serie B, Waiting rimane una delle migliori ballad del catalogo della band. Anche la scrittura dei testi segna un cambio di passo, con l’utilizzo della terza persona e la creazione di personaggi immaginari, preludio a quella rock opera che risponde al nome di American Idiot che sarà una nuova genesi per la band e che è, non a caso, alla terza posizione.
American Idiot
2004
No, non è Dookie parte 2 e ha funzionato proprio per questo. A dieci anni di distanza dall’esordio su major, da quel 1994 che fu un vero e proprio anno zero per l’esplosione del pop-punk, i Green Day si ripresentano sulla scena in grande stile. La genesi del disco è abbastanza nota: dopo l’ennesimo insuccesso commerciale (Warning) e la progressiva perdita di importanza, i tre si chiudono in studio e registrano un disco intitolato Cigarettes and Valentines. I master del disco vengono rubati e Billie Joe e soci, invece di re-incidere tutte le tracce, scelgono di ricominciare da capo. Nuovo concept, nuovo look: le magliette a strisce finiscono nell’armadio per far spazio a giacca, cravatta e eyeliner. American Idiot dona, di fatto, una seconda carriera al trio californiano, rendendoli nuovamente i più popolari nel genere che loro stessi resero popolare un decennio prima. Il disco è l’ennesimo cambio di passo in una carriera fatta di alti e bassi, una fotografia dell’America traumatizzata e belligerante post 11 settembre, all’alba della seconda amministrazione Bush Jr mentre è in atto la nuova invasione dell’Iraq. Nel disco si alternano le vicende di personaggi immaginari con un finale volutamente aperto, lasciato a libera interpretazione dell’ascoltatore. I singoli sono tutti stranoti, ma le altre tracce non sono da meno: la scatenata St. Jimmy (che regolarmente fa aumentare il conto degli infortunati durante i loro concerti), l’amatissima e profonda Letterbomb, la ferita insanabile che è Whatsername. Il disco della maturità, con tracce che sfondano il tetto dei nove minuti di durata, quasi un paradosso per i paladini dei tre accordi e via. Eppure tutto funziona, tutto sta in piedi, tutto – in qualche modo – ha un senso. PS Ehi voi! Sì, proprio voi che siete arrivati a leggere fin qui. Se questo disco è uscito quando eravate giovani, o se semplicemente è il primo disco dei Green Day che avete sentito, siete liberi di spostarlo alla posizione numero uno. Va bene così, lo capisco, siete perdonati.
Dookie
1994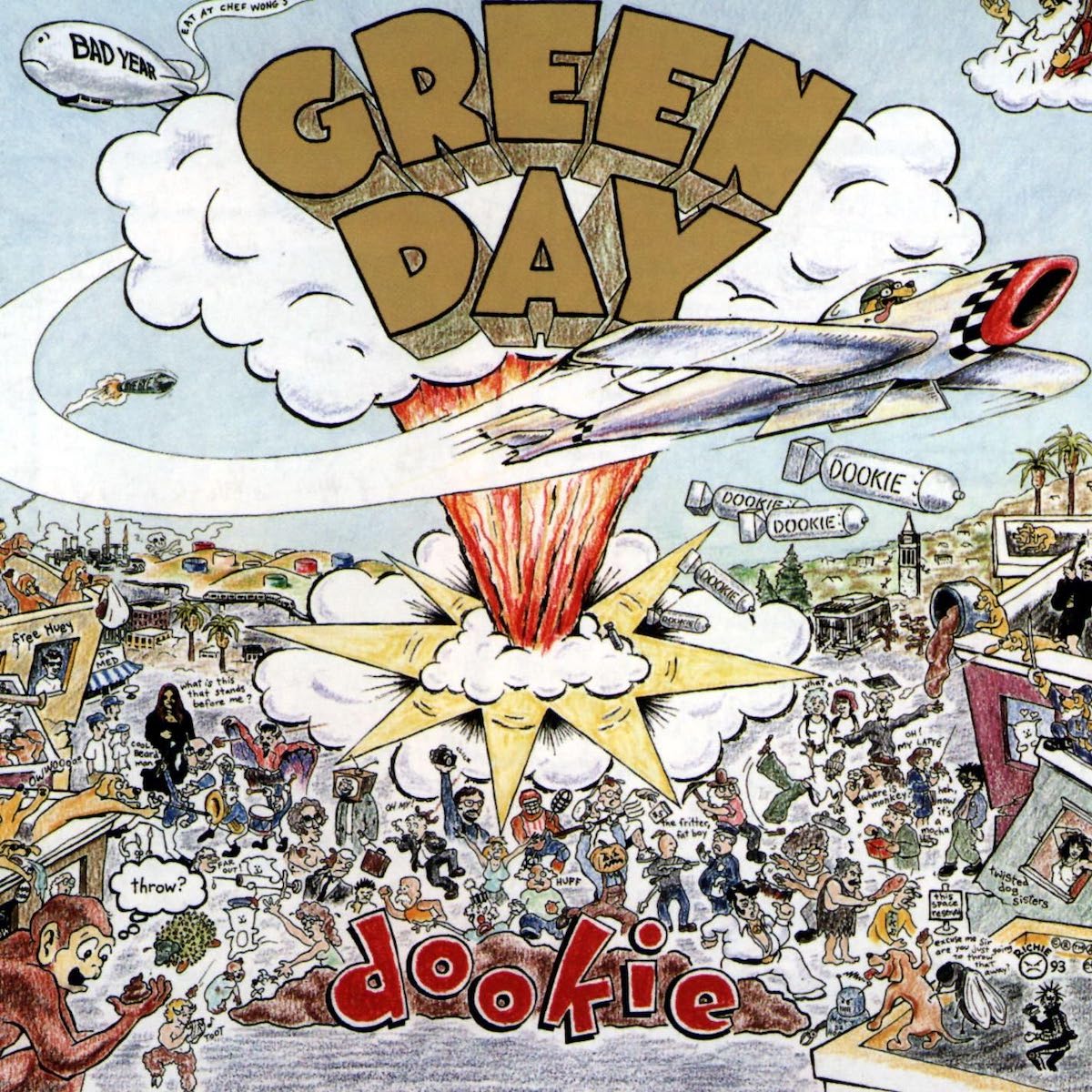
E siete perdonati perché Dookie è stato l’American Idiot della generazione di chi scrive, motivo per il quale sta una posizione sopra. Voglio dire, che il disco fosse spendibile da un punto di vista commerciale e mediatico (i video di When I Come Around e Basket Case erano praticamente in rotazione non stop su MTV) lo si poteva intuire, ma penso che nessuno – a partire dagli stessi Billie, Mike e Tré – potesse mai immaginare il botto che questo album avrebbe fatto. Il quadro storico è il seguente: la bolla del grunge è ormai esplosa (Kurt Cobain morirà due mesi dopo la pubblicazione di questo disco) e da qualche parte in California un ragazzino di nome Jonathan Davis si sfonda le orecchie con Rage Against the Machine e Faith No More, ma il successo del nu metal deve ancora arrivare. Il trono di re del rock è vacante al momento e a reclamarlo sono forse i suoi adepti più improbabili. Sono dei venduti? È vero punk questo? Sono queste le domande che accompagnano l’uscita del disco e che oggi, nel bene e nel male, nessuno ricorda e nessuno fa più. I duri e puri del genere li snobbano, loro accusano il colpo (la reazione sarà proprio quell’Insomniac che trovate alla posizione numero 5), ma nel frattempo scalano le classifiche e aprono le porte di un genere (punk, pop-punk, skate punk, chiamatelo un po’ come cazzo vi pare) a una generazione di ragazzini annoiati alla ricerca di nuovi idoli. La rivoluzione sonora si muove lungo la costa ovest degli Stati Uniti: la Seattle del grunge, dove piove mesi dieci mesi all’anno, sembra ormai lontanissima. Questa è la California, qui a Natale si va in spiaggia. Che non significa che il disco sia un trionfo di cazzeggio o che non ci sia spazio per l’introspezione, ma il mood è proprio un altro rispetto al chitarroso sludge del nordovest, il viaggio è completamente diverso. I Green Day, come li conosciamo oggi, nascono qui, con questo disco, con canzoni figlie di un’immediatezza assoluta, una collezione di gioiellini pop che molti loro epigoni possono solo sognare di poter scrivere. L’innegabile carisma di Billie Joe, soprattutto sui giovanissimi, ha fatto il resto. Al netto dei detrattori, che c’erano allora e ci sono oggi, questo è e rimane uno dei dischi più importanti degli anni ’90. Che altro dire di questo album che non sia già stato detto? Nulla, per cui andate a risentirvi She e la chiudiamo qua.
Nimrod
1997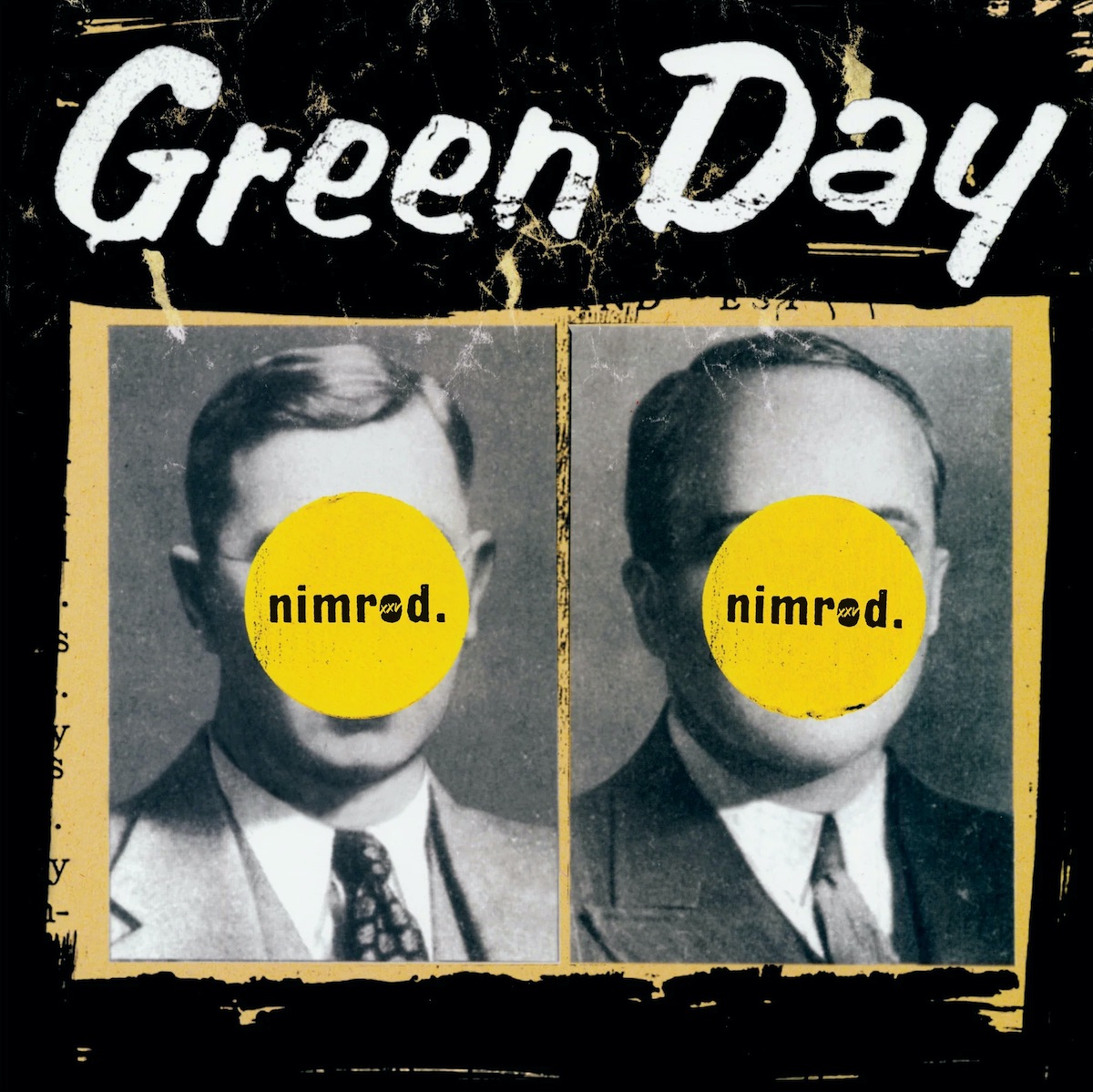
A mani basse il disco più sperimentale dei Green Day degli anni ’90. Somiglia più a una collezione di canzoni che non a un disco coeso e proprio questa è la sua forza, la versatilità. Per la prima volta in carriera, la band abbandona la rodatissima formula del punk à la Ramones per virare in direzioni nuove e inaspettate. L’aggressività senza compromessi di Platypus, il trionfo balzellante di King for a Day che a ogni concerto si trasforma in una gigantesca festa ska, c’è anche un po’ di surf nella strumentale Last Ride In. Non mancano gli zuccherini per radio e tv come Nice Guys Finish Last o la mielosa Redundant ed è semplicemente impossibile che non abbiate mai sentito il bisogno di spaccarvi la testa almeno una volta quando i tre attaccano la fanfara spaccaossa di Hitchin’ a Ride, il classico brano che lo senti una volta e non ti abbandona più. Ancora una volta, dopo l’insuccesso commerciale di Insomniac, la band si trova costretta a reinventarsi, scegliendo così la sperimentazione a tutto tondo, quella che poi i fan ritroveranno nella seconda parte di carriera del trio. Nimrod contiene inoltre quella che è una delle canzoni più celebri del trio, Good Riddance, un brano che lo stesso Billie Joe decise di inserire solo all’ultimo minuto, nonostante esistesse già all’epoca di Dookie ma, molto semplicemente, suonava troppo diverso rispetto a tutto quanto messo in mostra fino a quel momento. Il timore di Armstrong era che il brano non venisse capito e che potesse alienare ulteriormente una parte della già declinante fanbase del gruppo. Si tratta di una delle decisioni più azzeccate della band, la canzone infatti travalicherà i confini del genere per approdare ovunque, dalle serie tv (Seinfeld, I Griffin) ai balli di fine anno delle high school americane. Un brano talmente universale da diventare un classico sia dei matrimoni quanto dei funerali: perché la musica è questa cosa qui, ognuno ci trova dentro il proprio significato, esattamente come in questa classifica.