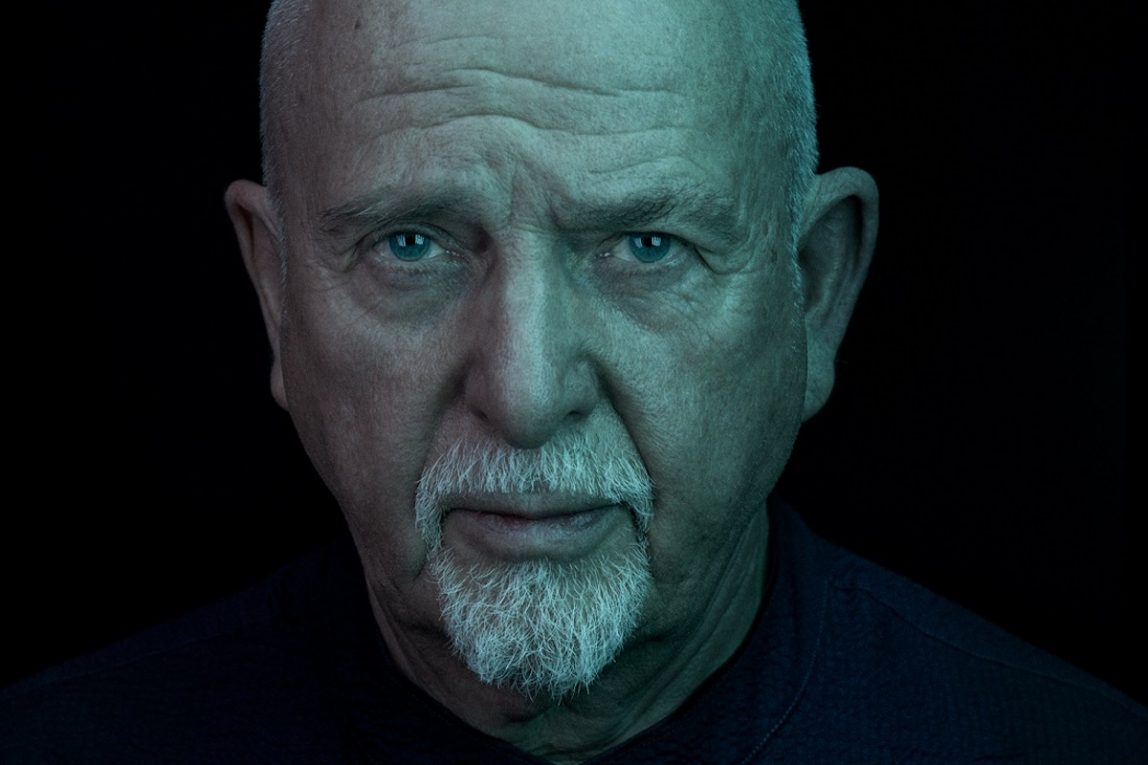Ecco una lista di alcuni degli artisti scomparsi negli anni ’10: Aretha Franklin, David Bowie, Chuck Berry, Ornette Coleman, B.B. King, Etta James, Whitney Houston, Lou Reed, Leonard Cohen, Prince, Merle Haggard, Kitty Wells, João Gilberto, Ravi Shankar, Tabu Ley Rochereau, David Mancuso, Amy Winehouse, Abbie Lincoln, Gil Scott Heron, George Jones, George Martin, George Michael, Allen Toussaint, Donna Summer, Phife Dawg, Prodigy, Adam Yauch, Heavy D, Captain Beefheart, Robert Hunter, Gregory Isaacs, Johnny Otis, Big Jay McNeely, Levon Helm, Kate McGarrigle, Guy Clark, Pete Seeger, Ralph Stanley, Gregg Allman, Glen Campbell, Maggie Roche, Mose Allison, Scott Walker, Jimmy Scott, Horace Silver, Fontella Bass, Lesley Gore, Percy Sledge, Alan Vega, Bernie Worrell, Wah Wah Watson, Scotty Moore, Roy Clark, Ric Ocasek, Roky Erickson, Tom Petty, Walter Becker, Jack Bruce, Ginger Baker, Ray Manzarek, Glen Frey, Keith Emerson, Greg Lake, David Axelrod, Willie Mitchell, Tommy LiPuma, Ronald Shannon Jackson, Yusef Lateef, Ben E. King, Tony Joe White, Don Williams, Daevid Allen, Gilli Smyth, Jaki Liebezeit, Holger Czukay, Ray Phiri, Ray Price, Butch Trucks, Naná Vasconcelos, Troy Gentry, Mindy McReady, Rosalie Sorrels, Dolores O’Riordan, Daniel Johnston, Gord Downie, Mark Hollis, Chris Cornell, Kim Shattuck, Avicii, XXXTentacion, Lil Peep, Mac Miller, Nipsey Hussle, Neal Casal, Sharon Jones e Juice Wrld. Per intenderci: questo elenco è parziale.
Le persone muoiono in tutti i decenni, ma la lista qua sopra rappresenta una concentrazione di artisti scioccante che comprende giganti per una o due generazioni, innovatori, giovani pionieri. I social media hanno amplificato la percezione delle loro morti, ingigantendo il lutto e la sensazione di perdita. E hanno permesso a tutti noi di condividere epifanie personali, canzoni preferite, foto, video e altre reliquie digitali.
Anche l’arte ha plasmato la nostra risposta emotiva. Esiste una lunga tradizione di poesie sulla morte e negli anni ’10 ci sono stati molti esempi degni di nota. C’entrano anche i progressi nel campo della registrazione digitale: gli studi casalinghi hanno reso il lavoro più facile e meno costoso, e gli artisti in cattive condizioni di salute hanno potuto lavorare in qualunque orario, a seconda del loro stato. Non tutti hanno la capacità di scrivere sulla propria morte, né hanno intenzione di farlo. Ma alcuni hanno compreso subito qual era il loro destino e hanno avuto ispirazione e forza sufficienti per mettere in musica la morte cantando del proprio lascito. Nel farlo, ci hanno lasciano un ricordati-che-devi-morire o semplicemente hanno portato a termine il proprio percorso, continuando a fare il lavoro che hanno sempre fatto.
Quest’ultima categoria comprende alcune delle opere più commoventi. I versi di Phife Dawg nell’album We Got It from Here… Thank You 4 Your Service del gruppo A Tribe Called Quest, registrato negli ultimi mesi di vita tra una dialisi e l’altra, era in linea con il vecchio repertorio. In The Space Program, parlava di morte esprimendosi in terza persona, incitando i vivi a fare la rivoluzione: “Non conformisti, non date retta a chi molla / Per i tipi alla Tyson e alla Che / Facciamo accadere qualcosa”, diceva Dawg, vero nome Malik Taylor, su un loop tratto dalla gemma spirituale soul-jazz di Andrew Hill Lift Every Voice, del 1969. Phife avrebbe sicuramente avuto altre cose da dire nell’album solista a cui stava lavorando, Muttymorphosis, che è rimasto incompiuto a causa della morte avvenuta nel 2016. Phife ha però fatto in tempo a completare Dear Dilla, un brano che ricorda il suo geniale amico beatmaker (il cui LP Donuts è a sua volta una delle grandi dichiarazioni finali della musica moderna). Nel testo, sotto forma epistolare, Phife sogna di condividere una stanza d’ospedale con Dilla, che sta producendo beat col suo Akai 3000. Nel video della canzone, Phife lotta con i suoi reni malati, riceve cattive notizie dai medici e, in una scena straziante, deve rifiutare un donut per via del diabete. “Tieni duro, questa non è l’ultima volta che ci vediamo”, dice Phife all’amico scomparso, “ci rivedremo a tempo debito, te lo prometto”.
Leonard Cohen ha sceneggiato la sua uscita di scena negli ultimi mesi di vita. Con l’aiuto del figlio Adam ha prodotto materiale per due album separati, You Want It Darker del 2016 Thanks for the Dance, uscito postumo quest’anno, più il volume di poesie The Flame. Cohen ha guardato l’abisso e riflettuto sul suo passato. Ha detto addio in Traveling Light alla sua defunta musa Marianne Ihlen, oggetto di So Long, Marianne. Ha chiamato il Congregation Shaar Hashomayim Synagogue Choir per evocare la sua discendenza ebraico-canadese (You Want It Darker). Ha descritto conquiste sessuali (The Night of Santiago), l’assopirsi del desiderio a causa dell’età (Leaving the Table) e il dolore profondo provocato da una perdita (Thanks for the Dance). E infine ha accettato l’inevitabile fallimento della vita (The Goal).
Quei due dischi sono fra i migliori di Cohen, così come Blackstar è uno dei più riusciti di David Bowie. Mentre si avvicinava alla fine, Bowie reclutava un gruppo di jazzisti di spicco di New York per eseguire alcune delle sue musiche più complesse, addentrandosi in un territorio in gran parte inesplorato. “Guardami, sono in paradiso”, cantava in modo assieme ironico e tragico nel video di Lazarus, sdraiato su un letto d’ospedale con una benda stilizzata sugli occhi, mentre straparlava come un convalescente squilibrato che crolla sulla scrivania. Intanto lavorava anche a Lazarus, un musical che riassumeva in qualche modo la sua opera, mescolando elementi di Hunky Dory e The Man Who Fell to Earth, e che raccontava la storia di un artista alla fine del suo percorso. Quando Bowie è morto poche settimane dopo la prima del musical a New York, il significato dell’opera è apparso più profondo e la stessa cosa è avvenuta con Blackstar, album uscito per il 69° compleanno del cantante due giorni prima della morte, nel gennaio 2016. A riascoltarlo oggi, con le sue allusioni alle lesioni, a Elvis e alla fama, sembra ancora più profondo.
Mentre gli anni ’20 s’avvicinano, gli artisti più anziani continuano a rimodellare il loro lascito. La decisione di Joni Mitchell di pubblicare il suo libro d’arte e testi Morning Glory on the Vine, realizzato in modo casalingo nel 1971, ha messo in prospettiva alcune delle sue opere più note e la cantante ha ricevuto vari tributi, tra cui la recente performance dal vivo dell’album Blue da parte di Brandi Carlile. Bob Dylan sta ancora reinventando la sua opera sera dopo sera nel Never Ending Tour e intanto amplia il catalogo delle registrazioni pubblicate con le Bootleg Series – l’ultima contiene le session di fine anni ’60 con Johnny Cash, le cui American Recordings sono autentici punti di riferimento per chi vuole lasciare una dichiarazione di fine carriera.
Altri artisti lavorano al proprio lascito lontani dai riflettori. David Jackman, artista visivo e musicista inglese amante dei bordoni che negli ultimi trent’anni ha pubblicato oltre cento registrazioni, ha appena dato alle stampe Herbstsonne (Autumn Sun), un album che in qualche modo ne riassume le pratiche artistiche. Si tratta di un singolo brano di 47 minuti pubblicato in una tiratura limitata di 300 CD per la piccola etichetta tedesca Die Stadt e non disponibile in streaming. È uno strumentale quasi ambient che andrebbe ascoltato su uno stereo tradizionale, con una resa dei bassi sufficiente a dare piena espressione ai suoi timbri complessi. È decisamente autunnale: ci sono rintocchi di campane della chiesa, mentre il bordone di un tanpura indiano evoca l’eternità. Ma la cosa davvero forte sono gli accordi di pianoforte a grappolo che sembrano cadere dall’alto – uno shock ogni volta spaventoso eppure soddisfacente, aspro e bello – con suoni che decadono come se fossero echi dell’accordo finale di A Day In The Life dei Beatles. L’inafferrabile artista non spiega il significato dell’album, né parla della sua salute o della sua vita personale. Ma Herbstsonne è potente tanto quanto le opere sopraccitate, è un’astrazione musicale della morte, minimale e al tempo stesso consolante e inquietante. È la giusta coda di un decennio in cui ci siamo abituati al lutto, per il corpo e per lo spirito.