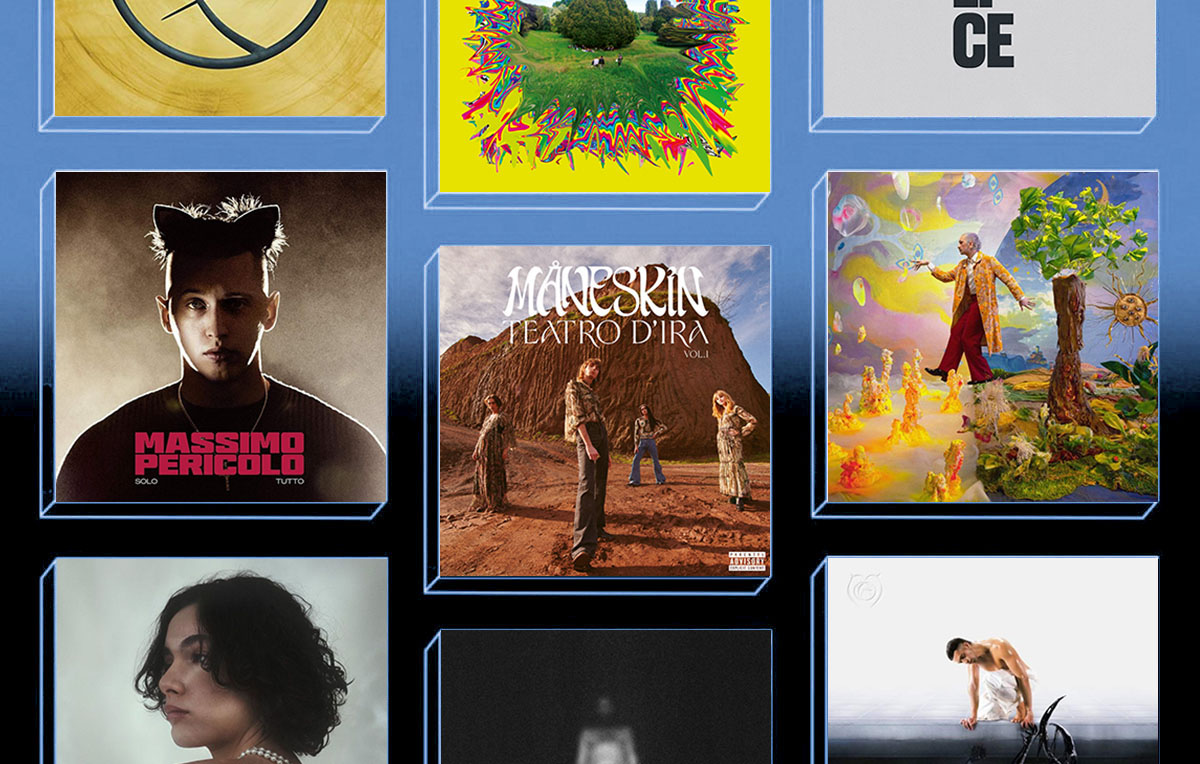Caparezza è l’artista pirandelliano per definizione, colui che, più di ogni altro, ha scelto di portarsi sul groppone l’antico dilemma del conflitto inconciliabile tra persona e personaggio sin dagli inizi della sua carriera. In più occasioni, Michele (Capa? Mikimix? Entrambi? Boh) ha provato a dissociarsi dall’immagine dell’artista infallibile e politicamente impegnato che lo ha connotato negli ultimi anni. I suoi leitmotiv privilegiati – che potremmo semplicisticamente sintetizzare in due tormentoni, «non mi avete capito» e «non aspettatevi troppo da me» – hanno fatto breccia in diverse canzoni, in cui l’autore ha voluto sottolineare quanto ampio fosse il divario che separa l’artista che effettivamente è da quello che pubblico, mercato e stampa di settore hanno deciso che debba essere.
E, però, negli ultimi anni qualcosa deve essere per forza cambiato: l’ansia da prestazione è scomparsa, l’esigenza di allinearsi alle aspettative di chi lo ascolta sembra soltanto un lontano ricordo, così come la pretesa – irrealizzabile – di essere finalmente “capito”. Anche la politica è stata confinata nel cassetto dei ricordi: il suo progetto di realizzare il grande Bildungsroman della classe operaia in tempi di berlusconismo è naufragato già da una dozzina d’anni per cedere il passo a una nuova fase, più psicanalitica e marcatamente depoliticizzata. Ascoltando un lavoro come Exuvia è facile intuire come le costine più visibili negli scaffali della sua libreria non siano più quelle dei vari Travaglio, Stella, Rizzo e Saviano.
Probabilmente, le maxi-inchieste da cestone di Autogrill sono state sostituite da altre ossessioni letterarie, come Lacan, Fromm, Harlow e Fisher. Fatto sta che quell’artista che cantava di logge massoniche deviate, appalti truccati, imprenditori senza scrupoli e metalmeccanici privi di diritti non esiste più: è stato fagocitato da un asceta che riflette sulla sua finitezza, che tenta di porsi in connessione con le sentinelle dell’inconscio, nella convinzione che nessun uomo possa realmente coincidere con sé stesso, che ciascuno di noi sia sempre altro rispetto a ciò che crede di essere. Un viaggio interiore inaugurato da un fischio nelle orecchie fastidioso ma rilevatore, un terremoto capace di innescare un vortice di ragionamenti che sfociano nella consapevolezza di non essere, per gli altri, ciò che si è per sé stessi. Partendo da questi presupposti, i lavori che Caparezza (o, per meglio dire, di Michele Salvemini con ancora addosso il costume da Caparezza) ha portato a conclusione negli ultimi 8 anni possono essere considerati come tre sedute di una seduta di psicanalisi collettiva che ha coinvolto tutti: Capa (la maschera), Michele (la persona) e Mikimix (il prodotto non posizionato sul mercato discografico). La domanda sorge spontanea: a che punto è, questa seduta?
Abbiamo incontrato Caparezza alla vigilia del suo concerto di Bologna, per parlare delle trovate narrative che ha escogitato per l’Exuvia Tour e provare a comprendere quale sarà la prossima tappa del suo pellegrinaggio interiore. E sulla fuga di notizie degli ultimi giorni che parlavano di un suo ritiro dalle scene, commenta: «Non mi ha dato fastidio, ma forse chi scrive dovrebbe assumersi qualche responsabilità in più».
Come hai trascorso i mesi che hanno anticipato il tour? Il mood è stato sempre il solito, “chino sui libri e sui manuali”, recintato nella tua fortezza della solitudine a Molfetta?
Sempre Molfetta! Abbiamo fatto tutto lì, grazie alle strutture che abbiamo realizzato nel corso degli anni. Ah no, aspetta, dimenticavo che, per un paio di giorni, ci siamo dovuti spostare a Terlizzi (che è a 5 minuti da Molfetta).
Soddisfatto della data di Treviso?
Sì, moltissimo, intanto perché tutti cantavano i pezzi nuovi, e non era così scontato; e poi perché era da tanto che non salivo su un palco, circa quattro anni, che nella vita di un artista è un’infinità di tempo. Però, per fortuna, è andato tutto per il verso giusto: ho scoperto che il mio corpo ha memorizzato tutto ciò che si fa su un palco, è come se gli ingranaggi fossero tornati al loro posto in maniera automatica.
Come cambia l’approccio a un tour, alla soglia dei 50 anni?
È più vicino a quelle gite che fanno le nonne quando vanno nei luoghi sacri, decisamente meno rock’n’roll rispetto al passato, per così dire. Mi ritaglio dei momenti per la mia quiete, per stare tranquillo e rilassato; però, quando sono sul palco, continuo a non risparmiarmi.
Che posto ha il tema del “rito di passaggio”, architrave narrativo di Exuvia (ma pure della parte finale di Prisoner 709), nella grammatica scenografica del tour? Com’è possibile rendere in maniera visivamente efficace un messaggio del genere?
Ogni live è stato interamente congegnato come una sorta di viaggio metaforico all’interno della mia foresta mentale, che poi è il concetto alla base di Exuvia, e il rito di passaggio non solo è il fulcro narrativo dell’intera esibizione, ma il protagonista silenzioso di tutto il tour. È ovunque: nei costumi, nei monologhi che recito tra un pezzo e l’altro, nel mero dato scenografico.

Foto: Luigi Rizzo
La domanda ti darà fastidio, ma devo fartela per ragioni di bottega: com’è nato questo fraintendimento sul tuo ritiro?
Non mi dà fastidio, sono tranquillissimo! Hai mai letto Il processo di Kafka? A un certo punto ti incolpano di una cosa che non hai fatto e passi il tempo a cercare di capire il perché. Con un’unica differenza, però: Josef K. non sapeva di cosa fosse accusato, io sì, ma non capivo come mai, perché quello che ho detto differiva profondamente da quanto è stato riportato dai giornali. Detto questo, potrei risponderti brevemente: è Internet, bellezza. E forse bisognerebbe fare lo sforzo di organizzare una battaglia contro i virgolettati selvaggi e responsabilizzare le persone che scrivono. Chiunque amministri la scrittura deve essere responsabile, altrimenti andremo incontro a una deriva fake e tendenziosa che, insomma, visti i tempi…
Ti considero un po’ l’Archie Ferguson della musica italiana: come il personaggio di Paul Auster, anche la tua vita ha conosciuto diverse biforcazioni. Personalmente, tendo a ricollegare la tua produzione artistica in tre fasi distinte: nella prima, quella di Mikimix e delle velleità “sanremiste”, vedo un tentativo (mai convintamente perseguito) di adeguamento al sistema; nella seconda (che faccio partire da Verità supposte e considero conclusa con Il sogno eretico) ho scorto un artista ossessionato dall’ansia da prestazione e dall’impellenza di rimanere all’altezza delle aspettative del pubblico e, infine, dopo il breve intermezzo di Museica (una sorta di terra di mezzo nella tua produzione discografica), arriva la quarta fase, la mia preferita, quella più psicanalitica e marcatamente depoliticizzata, dove ti trasformi una specie di Guido Anselmi post moderno e a farla da padrone è il tema della crisi d’identità. Quale sarà la quinta fase di Caparezza?
Il punto cruciale è proprio questo: ce ne sarà una quinta? Io non lo so, così come non sapevo, all’epoca di Verità supposte, di stare attraversando quella fase che hai descritto così bene. Stesso discorso nel caso di Museica: oggi sono giunto a considerarla anch’io una specie di zona franca nella mia elaborazione artistica ma, ai tempi, durante le fasi di scrittura e registrazione del disco, non ho mai avuto questa sensazione. Secondo me l’avvento dell’acufene, e più in generale la consapevolezza definitiva della mia finitezza e degli acciacchi ha accelerato una sorta di processo verso la messa in discussione di tutto quello che avevo realizzato fino a quel momento. Anche se può sembrare strano, fino a Museica, mi sentivo un predestinato: era come se ogni cosa, nella vita, mi portasse a percorrere quella particolare direzione, ero convinto che, nonostante tutto, ci fosse un solco già segnato. Quando sono arrivati i primi problemi alle orecchie, però, la prospettiva è cambiata radicalmente: ero davanti a un vicolo cieco, cosa avrei dovuto fare? Così ho cominciato a mettere in dubbio tutto, in primis me stesso, fino a sentirmi in prigione, bloccato, rinchiuso in una cella con la sola compagnia di tutte le mie paranoie: una cella da cui volevo liberarmi a tutti i costi. Sulla base di queste premesse, la mia quinta fase dovrebbe andare inevitabilmente verso la libertà, ma qui sorgono tutta una serie di problemi: che volto diamo, alla libertà? E che significato possiamo attribuirle? È difficile rivestire di una cornice di senso un concetto così astratto, utopistico e irraggiungibile: vedremo, vedremo.
E però, nonostante le paranoie, ti vedo molto più riappacificato con il tuo passato: è come se, da Prisoner in poi, due dei tuoi leitmotiv privilegiati, «non mi avete capito» e «non aspettatevi troppo da me», fossero stati riposti nel dimenticatoio. Insomma, come vivi il fatto di non essere quel santone onniscente che una parte della tua fan base pretendente che tu sia?
La vivo molto serenamente, perché è una fase che mi piace di più e in cui ho abbandonato ogni ansia da prestazione. A Treviso sono salito sul palco con una grande tranquillità: sapevo di aver svolto il mio lavoro, di non dovere dimostrare più niente e di trovarmi a mio agio con i miei limiti e con tutti i problemi connessi alla mia veneranda età.

Foto: Luigi Rizzo
Quindi questo scontro pirandelliano tra personaggio e alter-ego è finalmente concluso? Che ne so, magari nel prossimo album ti presenterai soltanto come Michele Salvemini, magari addirittura con i capelli rasati a zero, in un processo di demolizione radicale della maschera…
Tanto per cominciare, Exuvia è già nella sua interezza un lavoro di Michele Salvemini. Per quanto riguarda la possibilità di presentarmi senza capelli, perché no? Potrebbe accadere, se non fosse che, forse, non mi sentirei a mio agio da un punto di vista prettamente estetico-identitario. Qualche tempo fa ho provato a eliminare il pizzetto, ma è stato un errore madornale: ho finito per chiudermi in casa per la vergogna, scoprendo un volto che non era più il mio. A prescindere dagli sviluppi che vivrò nel conflitto con il mio alter-ego, so di poter contare su un pubblico che sa di non doversi aspettare niente da me, e questa assenza di aspettative mi fa sentire tremendamente a mio agio.
In questa tua ricerca, hai trovato qualcosa che ha scosso profondamente le tue certezze e le tue convinzioni su qualche argomento?
Ovviamente sì. Ad esempio, come sai, ho scritto La Certa, che è un pezzo sulla morte, perché ho perso un amico e, da lì, ho cominciato a riflettere ossessivamente su questo argomento. Ancora prima di diventare Mikimix, incarnando uno dei miei tanti alter-ego che poi ho lasciato per strada, avevo già affrontato il tema della morte, ma con un piglio abbastanza adolescenziale, un po’ in stile Jim Morrison. Adesso lo affronto con più consapevolezza, sono più soddisfatto, più maturo. Penso che sia del tutto normale: con il passare degli anni, le riflessioni aumentano e, di conseguenza, anche i contenuti delle canzoni.
Ma quindi basta politica? Per sempre? E non rispondermi che «non cantare di politica è l’atto più politico di tutti», per favore.
“Definitivamente” non fa parte del mio vocabolario. Sicuramente non nel modo in cui lo facevo nel passato, e sai perché? Perché se fai un tuffo di cinque minuti in internet, ormai lo fanno tutti. Basta andare su Twitter: il primo giorno c’è l’ondata di indignazione per una questione politica, quello dopo per una puntata dell’Isola dei Famosi. Non siamo più negli anni ’70, non c’è più una passione politica, un’ideologia a cui tenere fede: è stata fagocitata dalle dinamiche social e, almeno per ora, è un linguaggio a cui non riesco più ad appassionarmi.